Qui Juve: il derby capita al momento giusto.3 punti importanti non solo per la supremazia cittadina ma soprattutto per la classifica piuttosto deficitaria. Chiellini è rientrato dal ritiro della Nazionale, dopo aver accusato un affaticamento muscolare . e sarà regolarmente al centro della difesa con Bonucci oppure De Ligt a centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto anche McKennie, che sta sfruttando la pausa per recuperare al 100 percento dal fastidio all’anca che ne ha condizionato il rendimento. Possibile riposo per Kulusevski: Cuadrado tornerà sulla fascia destra dopo il turno di squalifica scontato contro il Benevento, mentre la coppia d’attacco sarà quella composta da CR7 e Morata. Infine, dalla panchina potrebbe tornare ail fantasista aPaulo Dybala, che corre verso una convocazione che manca dal 10 gennaio di quest’anno.
Qui Toro: il tecnico granata Davide Nicola striglia a dovere i suoi 15 giocatori dell’organico a disposizione senza gli 8 nazionali e N’Kolou ancora indisponibili per i postumi post covid.
La squadra granata è consapevole che affronterà una Juve ferita ma piuttosto incerta e dimessa:il Toro sente di poter fare suoi i 3 punti per accelerare verso la salvezza per riuscire a programmare al meglio la prossima stagione.
Il modulo di partenza sarà sempre il 3-5-2 con la probabile sostituzione di Lyanco con Buongiorno al centro della difesa.Il brasiliano è apparso troppo incerto nelle ultime prestazioni.
A centrocampo probabile sostituzione di Rincon col pimpante Gojak oppure con Baselli tornato di nuovo in forma.In attacco Sanabria confermato accanto a capitan Belotti, tornato sui suoi standard ottimali ed impegnato con la nazionale italiana.
Vincenzo Grassano







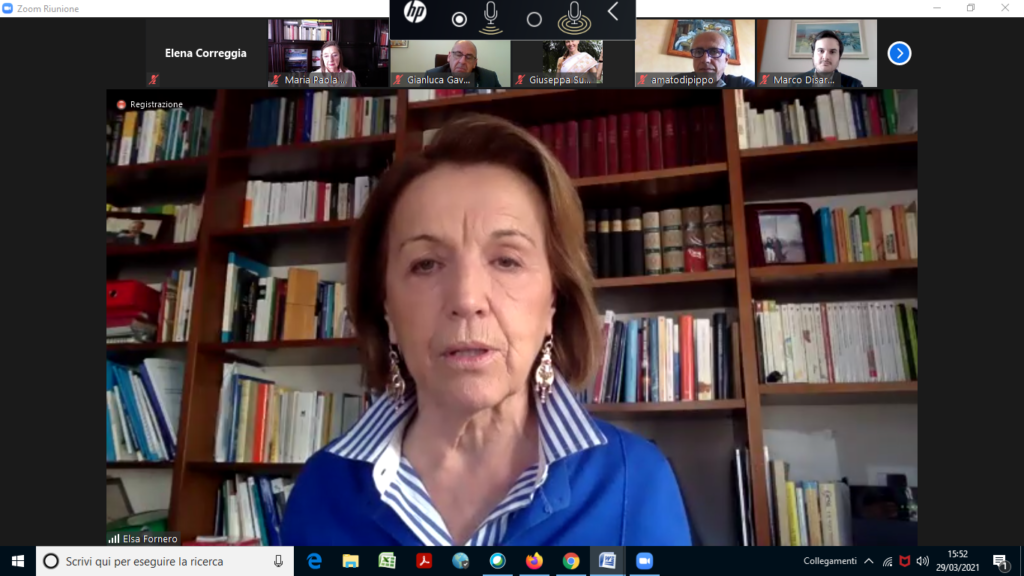



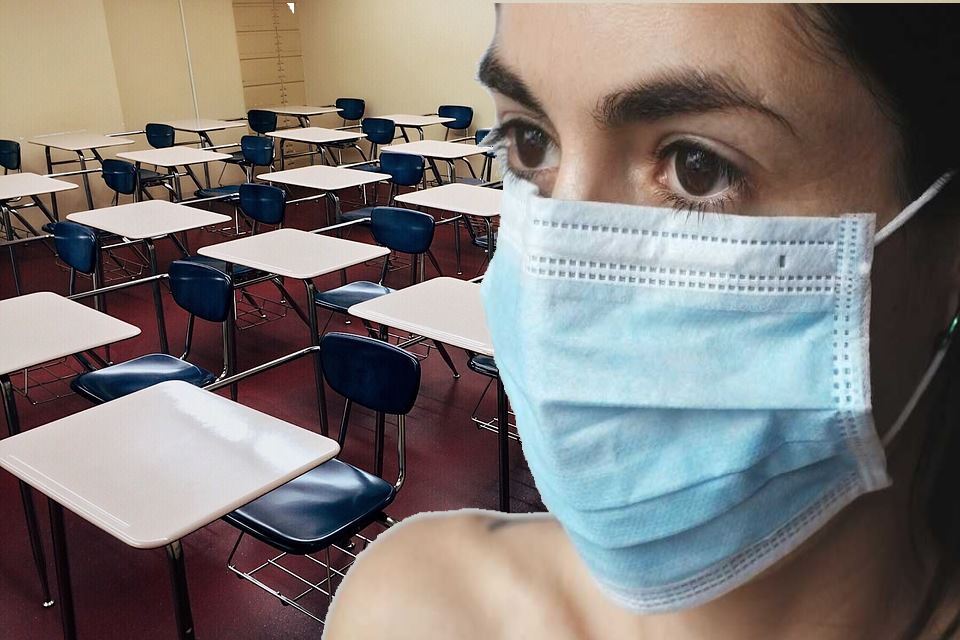
 Siamo alla vigilia di Pasqua e ci sono regioni che vorrebbero riaprire le scuole per pochi giorni prima delle vacanze” agli arresti domiciliari” di genitori e figli. Un segnale demagogico di scarsa intelligenza. Azzolina, per grazia di Dio, è stata allontana dopo che ha provocato gravissimi danni alla scuola, ma il nuovo ministro non appare migliore. E’ un provinciale ferrarese adatto al massimo a fare l’assessore. Ministri così sono stati la rovina costante della scuola italiana: pensiamo alla Fedeli o al fascista De Vecchi.
Siamo alla vigilia di Pasqua e ci sono regioni che vorrebbero riaprire le scuole per pochi giorni prima delle vacanze” agli arresti domiciliari” di genitori e figli. Un segnale demagogico di scarsa intelligenza. Azzolina, per grazia di Dio, è stata allontana dopo che ha provocato gravissimi danni alla scuola, ma il nuovo ministro non appare migliore. E’ un provinciale ferrarese adatto al massimo a fare l’assessore. Ministri così sono stati la rovina costante della scuola italiana: pensiamo alla Fedeli o al fascista De Vecchi.
