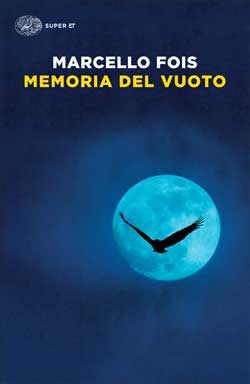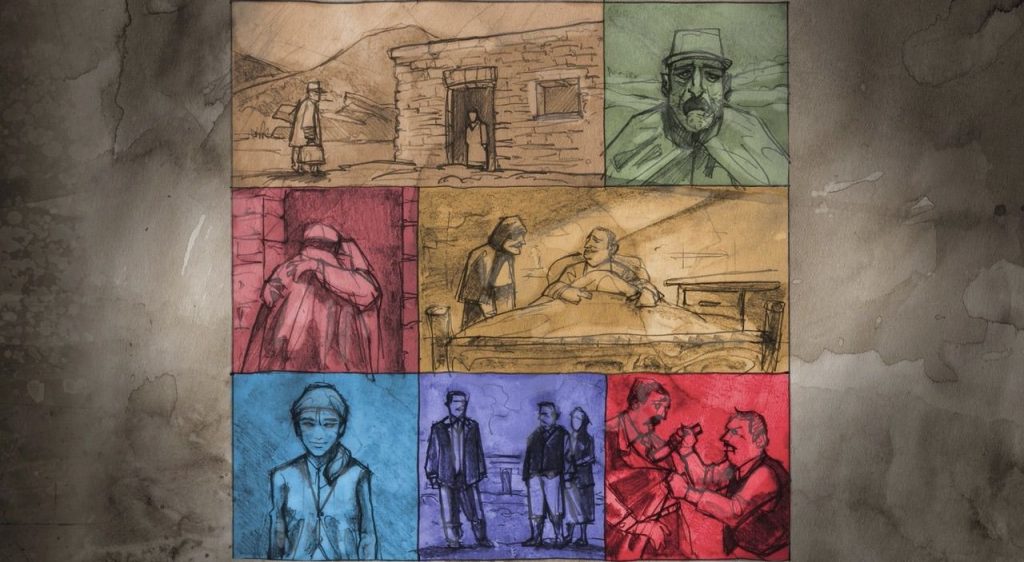Il 2026 della Fondazione Mirafiore verrà aperto da Domenico Iannacone, con un appuntamento che inaugura il nuovo anno del Laboratorio di Resistenza Permanente all’insegna del racconto civile e dell’ascolto.
L’incontro, inizialmente previsto per il 24 gennaio, è stato spostato a domenica 25 alle 18 per impegni lavorativi del protagonista.
Giornalista e documentarista tra i più autorevoli del panorama Italiano, Iannacone ha costruito nel tempo una narrazione rigorosa e profondamente umana delle vite che restano ai margini del racconto dominante. Le sue inchieste e i suoi reportage hanno aperto una finestra su un’Italia spesso invisibile, restituendo dignità, complessità e voce a persone e territori raramente rappresentati.
Dopo gli esordi giovanissimo sulle testate regionali fino al ruolo di inviato per programmi simbolo dell’informazione televisiva, come Ballarò e Presa diretta, Iannacone ha condotto per sette edizioni I dieci comandamenti e dal 2019 è su Rai 3 con Che ci faccio qui, programmadi approfondimento diventato anche un progetto teatrale di grande impatto civile.
Nel corso della sua carriera ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, cinque Premi Ilaria Alpi, il Premio Paolo Borsellino, il Premio Goffredo Parise, il Premiolino e più recentemente il premio Franco Cuomo per il giornalismo.
Che ci faccio qui – in scena dal 2024 rappresenta un esempio di teatro civile di narrazione, capace di trasformare il racconto televisivo in orazione pubblica, mantenendo intatta la forza documentaria e amplificando la relazione diretta con il pubblico.
Il suo lavoro fonde la migliore tradizione documentaristica italiana con l’eredità del cinema neorealista, ponendo al centro l’umanità dei protagonisti.
Nel corso dell’incontro alla Fondazione Mirafiore, Domenico Iannacone condividerà esperienze, testimonianze e incontri che hanno segnato il suo percorso professionale e umano. Il pubblico sarà accompagnato attraverso il racconto diretto e il supporto di materiali audiovisivi dentro storie che interrogano il nostro sguardo sul presente e sul ruolo dei media, mostrando come la televisione possa essere ancora uno strumento di conoscenza e responsabilità.
MARA MARTELLOTTA