Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il Piano triennale per la Cultura 2025-2027, un documento strategico che punta a rafforzare il sistema culturale regionale con una visione di lungo periodo, maggiore inclusività territoriale e più sostegno alle filiere creative. Il piano prevede fondi complessivi pari a circa 148,5 milioni di euro.
Tra i principali obiettivi figurano il coinvolgimento delle aree periferiche, la programmazione culturale triennale per superare la logica della precarietà annuale, e l’incremento delle risorse per settori chiave come la produzione cinematografica e televisiva.
Viene infatti confermata e potenziata la misura del Piemonte Film TV Fund, inizialmente prevista con un budget di 4 milioni annui per il triennio 2023-2025: l’investimento sale ora a 7 milioni di euro all’anno, a fronte dei risultati positivi in termini occupazionali e di ricadute economiche.

Un altro pilastro del Piano riguarda la valorizzazione delle eccellenze culturali nei territori meno centrali, promuovendo progetti che nascano e si sviluppino al di fuori dei principali poli urbani. Torino e le città capoluogo resteranno snodi centrali, ma si vuole incentivare la partecipazione delle realtà culturali locali attraverso bandi più accessibili e attenti alla distribuzione geografica.
Tra i criteri di valutazione per l’assegnazione dei fondi saranno inclusi elementi come l’inclusione sociale, le pari opportunità di accesso alla cultura e l’adozione di pratiche sostenibili, in linea con gli obiettivi di una cultura sempre più responsabile e aperta.
Importante anche l’attenzione riservata al Sistema Museale Nazionale, che sarà rilanciato attraverso una governance integrata tra musei statali, regionali, comunali, diocesani e privati. Al suo fianco, verranno attivati numerosi investimenti a sostegno di musei, teatri, biblioteche, archivi e presìdi culturali locali.
L’assessore alla Cultura Marina Chiarelli ha sottolineato il valore del Piano come espressione di un confronto diretto con il mondo culturale:
«Questo Piano è frutto dell’ascolto delle esigenze del comparto, a cui abbiamo voluto rispondere con proposte e soluzioni concrete», ha dichiarato.
«Il settore culturale si conferma un motore essenziale per lo sviluppo sociale ed economico del Piemonte e, di conseguenza, è oggi ancora più necessario estendere queste opportunità a tutto il territorio, comprese le aree al di fuori delle zone metropolitane. Vogliamo assicurarci che nessuno resti indietro, valorizzando le eccellenze culturali anche nei territori più decentrati, che spesso rappresentano il cuore pulsante delle piccole comunità. Inoltre, riserveremo particolare attenzione alle realtà impegnate nell’inclusione sociale, nelle pari opportunità e nella sostenibilità ambientale. Parallelamente, confermiamo la scelta di una programmazione triennale, per consentire agli operatori culturali di pianificare con maggiore serenità e prospettiva. Con il nuovo Piano poniamo le basi per un sistema culturale più forte, inclusivo e sostenibile».




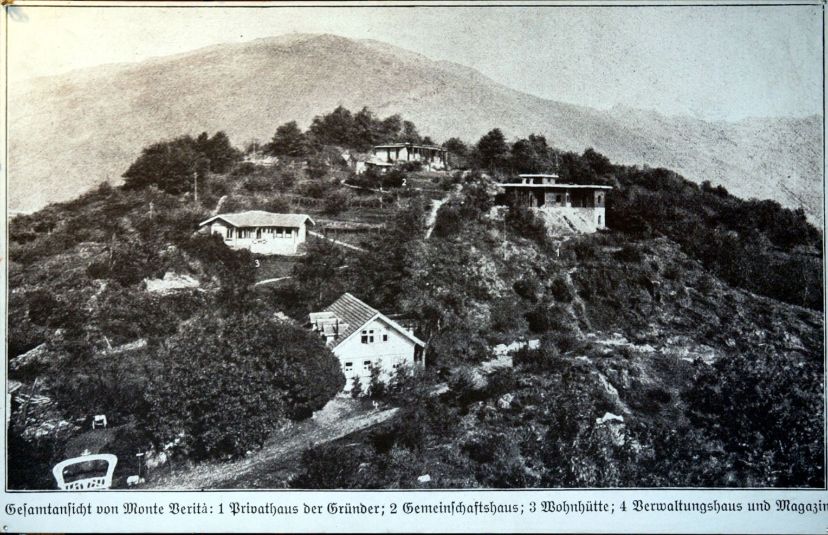

 Nel basamento vi sono quattro bassorilievi in bronzo che rappresentano due avvenimenti storici ( “Il Congresso di Parigi” e “Il ritorno delle truppe sarde dalla Crimea”) e gli stemmi della famiglia Cavour incorniciati da una corona d’alloro e da una ghirlanda di frutti.
Nel basamento vi sono quattro bassorilievi in bronzo che rappresentano due avvenimenti storici ( “Il Congresso di Parigi” e “Il ritorno delle truppe sarde dalla Crimea”) e gli stemmi della famiglia Cavour incorniciati da una corona d’alloro e da una ghirlanda di frutti. 




