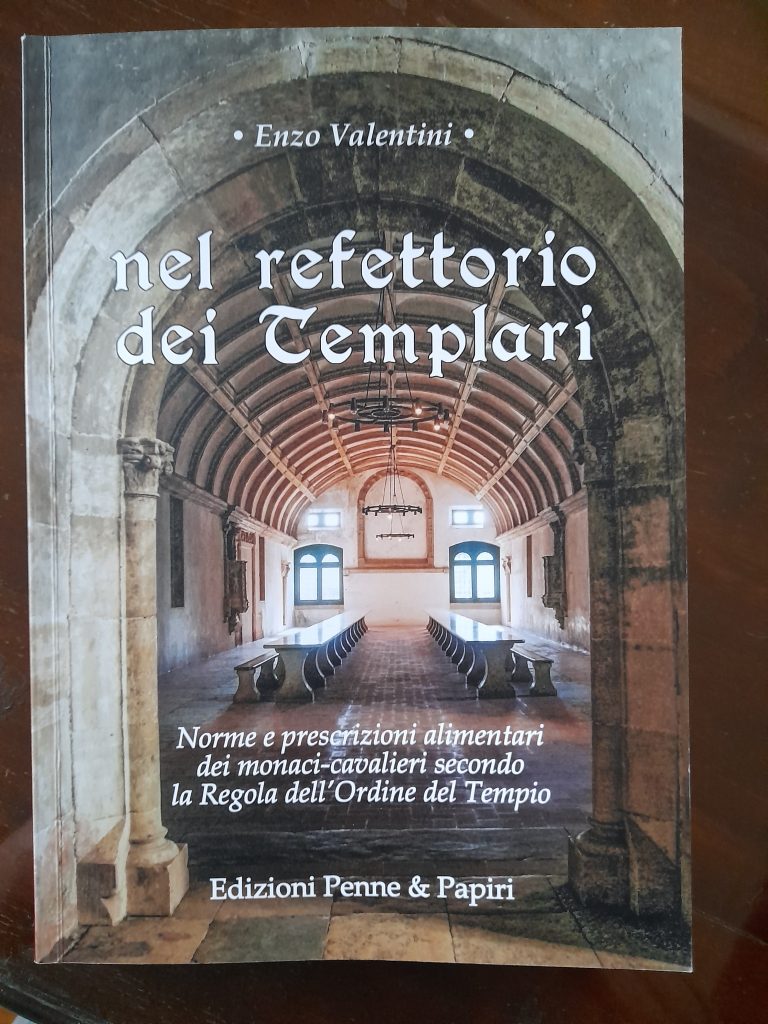Mercoledì 23 novembre a Torino all’Educatorio della Provvidenza
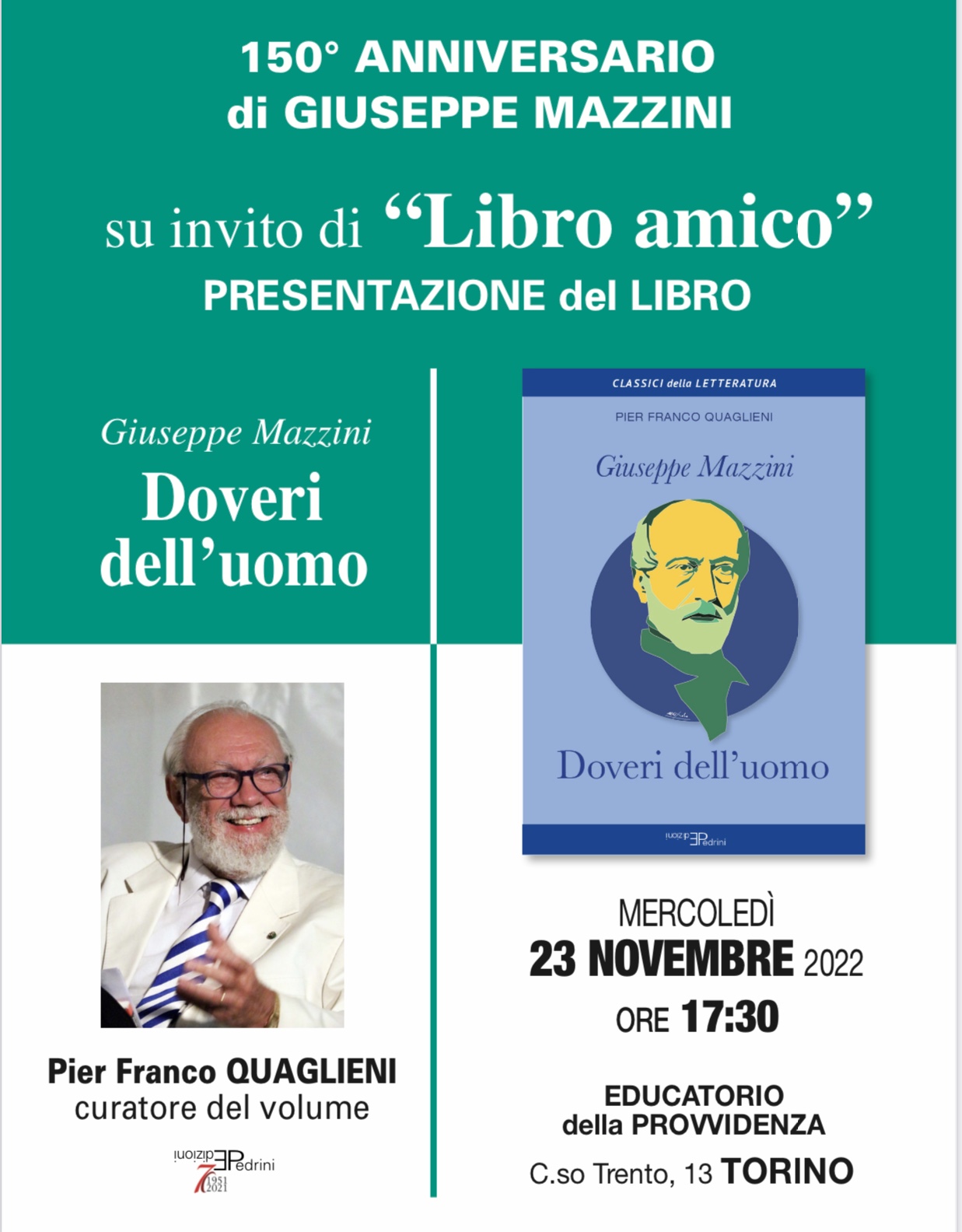
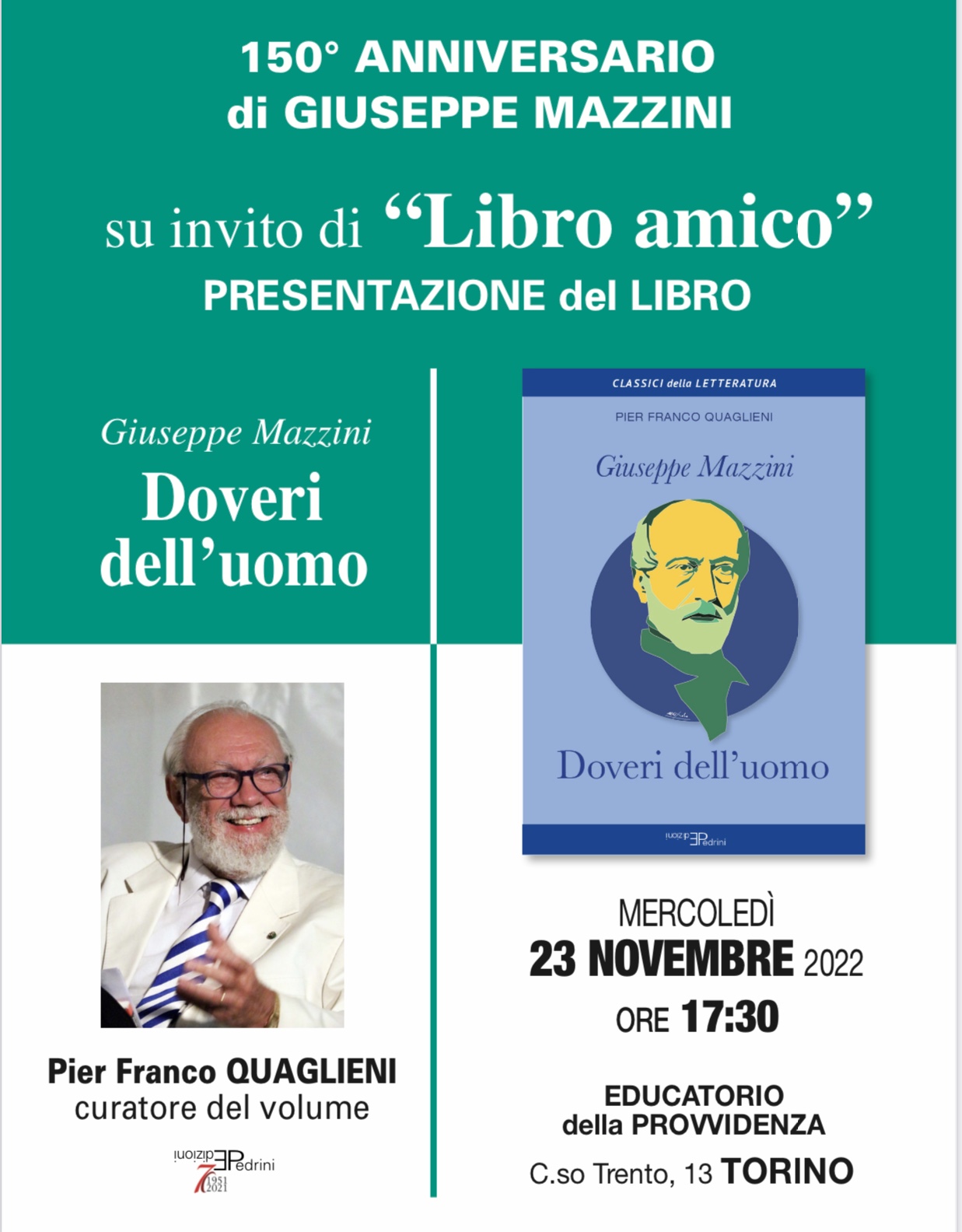
Il 16 novembre del 1977 fu ferito a morte Carlo Casalegno. Dopo, il lugubre comunicato delle Brigate Rosse. Abbiamo colpito un servo dei padroni.
Vice direttore della Stampa era colpevole di scrivere contro i terroristi e per la democrazia. Anni tremendamente drammatici. Torino ed il Piemonte ne furono protagonisti. Nel bene e nel male.
Ora come allora non c’erano dubbi. Il bene era l’antiterrorismo ed il male assoluto il terrorismo nero e rosso. Quella sera ero uscito con gli amici, amici e soprattutto compagne e compagni. Il giorno dopo sciopero operaio e studentesco. Lo ammetto subito che non fu un successone. Tanti e fin troppi i punti oscuri dentro il cosiddetto movimento. Aree di giustificazionismo? Direi proprio di sì. Una sorta, in alcuni casi fin troppo esplicita di complicità. Questo omicidio cominciò nel cambiare le cose all’interno, appunto del movimento.
Per primo il figlio di Casalegno. Era stato un dirigente di Lotta Continua che a Torino di fatto fu fondata nel 69. Un anno prima c’era stato il suo scioglimento al congresso di Rimini. I ragazzi che volevano fare la rivoluzione avevano capito che non potevano fare la rivoluzione. Prese corpo la cosiddetta Antonomia Operaia. Metà del servizio d’ordine di Lotta Continua aderì ad Autonomia Operaia e metà in Senza Tregua. Gente violenta . Entrambi teorizzavano e praticavano la violenza, la violenza di massa. Quella che per capirci si presentava ai cortei con le chiavi inglesi i caschi ed i passamontagna. Molti di loro erano armati e andavano in montagna e ” giocavano ” a fare i partigiani. Dove la drammaticità si incontrava con il ridicolo. Ebbene il figlio di Casalegno, in un articolo sul giornale Lotta Continua disse : basta con la violenza.
Avevo vent’anni, e ieri come adesso ho solo provato disprezzo per i terroristi o per chi voleva e credeva di risolvere tutto politicamente con la violenza. Ieri come allora mi sono chiesto : perché si comportano così? Dopo ho anche letto a tal proposito. La risposta, evidentemente è complessa. Dunque talmente articolata che è difficile cercare di fare una sintesi. La storia è anche storia di individui. Con i loro pregi e loro difetti. Difficile, se non impossibile trovare dei pregi nei terroristi. E tra i loro difetti ci metterei, al primo posto la stupidità mista ad arroganza.
Chi si credevano di essere nell’ergersi giudici e boia al tempo stesso? Me lo sono sempre chiesto trovando la sola risposta nella loro arrogante stupidità. Si sono inventati una realtà che non esisteva, scambiando le loro illusioni come volontà dei più. Basta ascoltare i loro proclami. Deliranti, e parlano a nome di tutta la classe operaia e a nome di tutto il popolo. La violenza è l’omicidio come tragica conseguenza. Sono anni che non si cancellano dalla memoria. A volte c’è la tentazione. Ma è inutile e probabilmente dannoso. Memoria del funerale di Carlo Casalegno con corso Vinzaglio invaso da una moltitudine di persone. Dagli operai in tuta all’impiegato in giacca e cravatta, alla casalinga.
Tanta ma tanta gente di ogni estrazione sociale e dunque anche politica. Li’ c’era proprio tutto il popolo di Torino. Con le istituzioni e lo Stato nelle sue diverse articolazioni. Capivi che la rassegnazione e indifferenza dei giorni precedenti diventava partecipazione e volontà d’agire. Anche per ciò il terrorismo rosso e nero è stato sconfitto.
PATRIZIO TOSETTO
Via al recupero di Cattedrali e edifici storici delle Diocesi Piemontesi: i lavori dureranno tre anni e serviranno 2 milioni di euro di cui 1,6 dalla Regione
Poggio: «Piemonte super potenza culturale, incrementiamo il parco di luoghi resi di nuovo fruibili per il pubblico»
Il Vescovo delegato per i Beni Culturali ecclesiastici del Piemonte, mons. Derio Olivero: «I vescovi del Piemonte sono grati alla Regione per questa rinnovata attenzione al nostro patrimonio»
Torino, 13 novembre 2022
Affreschi riportati alla luce, ripresa di scavi archeologici e restauri conservativi su tutti gli edifici storici e cattedrali piemontesi delle Diocesi. Regione e Conferenza Episcopale piemontese hanno sottoscritto una convenzione per recuperare gran parte del patrimonio architettonico di proprietà delle diocesi, palazzi e monumenti di grande valore, molti risalenti al ‘600 che abbracciano gran parte dello spettro stilistico della regione dal Romanico a Barocco.
«L’obiettivo è incrementare il parco di edifici storici resi di nuovo fruibili per il pubblico con restauri conservativi e ammodernamenti tecnologici – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio -. Il Piemonte è una super potenza culturale, per questo vogliamo sfruttare il vantaggio di ospitare luoghi da cartolina che sono anche didattici. Lavagne sulle quali sono stati scritti capitoli importanti della storia dell’arte e delle nostre tradizioni cristiane».
«Grazie a questo importante accordo, – sottolinea il Vescovo delegato per i Beni Culturali ecclesiastici del Piemonte, mons. Derio Olivero, – significative testimonianze del patrimonio culturale conservato nelle cattedrali e negli episcopi saranno recuperate e collegate agli itinerari storico-artistici già operativi sul territorio che negli anni scorsi hanno beneficiato di analoghi accordi regionali e dei fondi OttoXMille della Chiesa cattolica. I vescovi del Piemonte sono grati alla Regione per questa rinnovata attenzione al nostro patrimonio».
Saranno riportati alla luce affreschi e dipinti come quelli della cattedrale San Donato di Pinerolo, mentre a Susa riprenderanno gli scavi archeologici all’interno della cattedrale di San Giusto dopo la recente scoperta della cripta, risalente all’XI secolo riemersa sotto il pavimento dell’abside. Gli interventi della durata di tre anni previsti all’interno dell’accordo su gran parte delle eredità storiche richiederanno una spesa di quasi 2 milioni di euro di cui oltre 1,6 milioni messi a disposizione dalla Regione, fondi che serviranno a mettere in sicurezza, ad esempio, il palazzo Episcopale di Mondovì e a Torino i locali del palazzo episcopale del duomo dove è custodito l’archivio storico. A Novara sarà recuperato il portale storico del duomo Santa Maria Assunta con un restauro conservativo, ad Alessandria è previsto il consolidamento del campanile di Santi Pietro e Marco. In molti edifici saranno eliminate le barriere architettoniche ed eseguiti lavori di efficientamento energetico come a Santa Maria del Bosco e San Michele di Cuneo.
Lunedì 14 novembre ore 17.30
via Ottavio Revel 15 – Torino
CENTRO STUDI PIEMONTESI
Presentazione del volume
La diplomazia del disincanto
Costantino Nigra e l’Italia
sul finire dell’Ottocento
di
Andrea Pennini
Torino, Centro Studi Piemontesi, 2022
Con l’autore intervengono
Pierangelo Gentile e Michele Rosboch
Info e prenotazioni: tel. 011/537486 – info@studipiemontesi.it.
La conferenza potrà essere seguita in differita sul Canale YouTube del Centro Studi Piemontesi
1 Museo Egizio
2 Palazzo Reale-Galleria Sabauda
3 Palazzo Madama
4 Storia di Torino-Museo Antichità
5 Museo del Cinema (Mole Antonelliana)
6 GAM (Galleria d’Arte Moderna)
7 Castello di Rivoli
8 MAO (Museo d’Arte Orientale)
9 Museo Lombroso- Antropologia Criminale
10 Museo della Juventus
 È qualche anno che abito fuori Torino e l’andare in centro non rientra più tra quelle che posso definire “abitudini”. Il lato positivo è che, quando ci vado, apprezzo maggiormente lo spettacolo che la città mi offre: la folla che si muove disordinata, qualcuno, più frettoloso degli altri, che attraversa correndo la strada anche se c’è il semaforo rosso, i tram che partono scampanellando sui binari, il sali-scendi delle persone dai pullman, qualche cestino troppo pieno e i portici che rimbombano del brusio dei passanti. Piazza Castello è una delle piazze principali dell’antica Augusta Taurinorum, è di forma quadrata e su di essa si affacciano Palazzo Madama e Palazzo Reale, mentre il profilato perimetro è delineato da portici eleganti ed importanti edifici, quali l’Armeria Reale, il Teatro Regio, il Palazzo della Regione Piemonte, la Galleria Subalpina, la Torre Littoria e la piccola Chiesa di San Lorenzo, che si erge all’angolo con via Palazzo di Città, mentre l’affollata via Garibaldi sfocia nella stessa piazza come un fiume nel mare. Poco più oltre s’innesta la Piazzetta Reale, costeggiata da Palazzo Chiablese, dove si trova l’ingresso per i Musei Reali e si accede al passaggio pedonale che porta a Piazzetta San Giovanni. Quando inizia a fare bel tempo si accendono le fontane, ricordo che quando finiva la scuola, noi studenti del Liceo Classico “Gioberti”, come molti altri ragazzi degli istituti vicini, andavamo a buttarci sotto l’acqua fredda per festeggiare l’arrivo dell’estate.
È qualche anno che abito fuori Torino e l’andare in centro non rientra più tra quelle che posso definire “abitudini”. Il lato positivo è che, quando ci vado, apprezzo maggiormente lo spettacolo che la città mi offre: la folla che si muove disordinata, qualcuno, più frettoloso degli altri, che attraversa correndo la strada anche se c’è il semaforo rosso, i tram che partono scampanellando sui binari, il sali-scendi delle persone dai pullman, qualche cestino troppo pieno e i portici che rimbombano del brusio dei passanti. Piazza Castello è una delle piazze principali dell’antica Augusta Taurinorum, è di forma quadrata e su di essa si affacciano Palazzo Madama e Palazzo Reale, mentre il profilato perimetro è delineato da portici eleganti ed importanti edifici, quali l’Armeria Reale, il Teatro Regio, il Palazzo della Regione Piemonte, la Galleria Subalpina, la Torre Littoria e la piccola Chiesa di San Lorenzo, che si erge all’angolo con via Palazzo di Città, mentre l’affollata via Garibaldi sfocia nella stessa piazza come un fiume nel mare. Poco più oltre s’innesta la Piazzetta Reale, costeggiata da Palazzo Chiablese, dove si trova l’ingresso per i Musei Reali e si accede al passaggio pedonale che porta a Piazzetta San Giovanni. Quando inizia a fare bel tempo si accendono le fontane, ricordo che quando finiva la scuola, noi studenti del Liceo Classico “Gioberti”, come molti altri ragazzi degli istituti vicini, andavamo a buttarci sotto l’acqua fredda per festeggiare l’arrivo dell’estate.
Vivere in un qualche luogo significa arricchirlo di ricordi, ma alcuni luoghi più di altri si legano ai vissuti e credo che per me piazza Castello sia proprio uno di quelli: punto di ritrovo “davanti al chiosco di giornali di via Garibaldi” o alla “focacceria”, i festeggiamenti bagnati – e leggermente maleodoranti- alla fine del ginnasio e tanti altri piccoli momenti che riaffiorano tutte le volte che passo di lì. Ma non è per raccontarvi della mia adolescenza che vi ho condotto qui, ma per proporvi di entrare a dare un’occhiata ad una delle varie collezioni che sono conservate all’interno del Palazzo. Nel regale complesso si trova la Galleria Sabauda, una delle raccolte pittoriche più importanti d’Italia, con alla spalle oltre 180 anni di storia. Le opere, oltre 700 dipinti che spaziano dal XIII al XX secolo, sono esposte dal 2014 nella Manica Nuova di Palazzo Reale, all’interno del complesso del Musei Reali di Torino.
Fra i contenuti di maggior interesse spicca una raccolta particolarmente importante di autori rinascimentali piemontesi, fra cui Giovanni Martino Spanzotti, Gaudenzio Ferrari e Defendente Ferrari, un vasto assortimento di opere prodotte dai maggiori nomi della pittura italiana, come Beato Angelico, Duccio di Boninsegna, Piero del Pollaiolo, Andrea Mantegna, Filippino Lippi, Il Veronese, Tintoretto, Guercino, Orazio Gentileschi, Giambattista Tiepolo e uno dei migliori nuclei italiani di dipinti della Scuola Fiamminga, con nomi quali Van Dyck, Rubens, Rembrandt, i Brueghel, Memling e Van Eyck.
La storia della collezione della Pinacoteca è lunga e complessa, inizia il 2 ottobre 1832, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione della collezione di Carlo Alberto, con cui si sancisce che le opere vengano messe a disposizione della comunità e «aperte al pubblico». Allora però la raccolta era esposta a Palazzo Reale, dove rimase fino alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento, quando venne spostata a Palazzo Carignano. Negli anni Ottanta dell’Ottocento le opere erano 550, disposte tra le varie sale dell’edificio, divise per autori (piemontesi ed italiani), grandi formati, nature morte, ceramiche e fiamminghi. Alessandro Bandi di Verme ampliò la galleria di 5 sale e ordinò che i quadri fossero disposti secondo una concezione logica ed estetica.
Negli anni Trenta del Novecento la raccolta prende il nome “Galleria Sabauda”, ma si impoverisce poiché Mussolini cede svariate opere ai musei londinesi. Durante il periodo bellico l’esposizione chiude al pubblico per molto tempo; negli anni Cinquanta la Galleria viene inserita nel piano di rinnovamento dei grandi musei nazionali che necessitano provvedimenti e finalmente, il 24 maggio 1959, la Galleria riapre ufficialmente. Oltrepasso la cancellata, eseguita nel 1840 da Pelagio Palagi a scopo di delimitare la Piazzetta Reale dalla pubblica Piazza Castello, alzo lo sguardo verso le faccione dorate dell’orrorifica Medusa e mi avvio alla biglietteria.
Una volta entrata mi trovo di fronte al lungo corridoio e qui da una parte si affacciano le numerose stanze e dall’altra spiccano le statue romane. A questo punto non mi resta che cercare i numeri delle sale e iniziare il percorso. Le opere esposte sono moltissime, tutte meravigliose, ma alcune incontrano particolarmente i miei gusti, come il dipinto del fiammingo Hans Memling, “Scene della passione di Cristo” (1470). Si tratta di una tela di modeste dimensioni, emblematica di uno degli stili pittorici che più mi piacciono, quello fiammingo. Con “arte fiamminga” si è soliti indicare la produzione artistica del XV-XVI secolo, portata avanti nei Paesi Bassi, caratterizzata da un approccio sensoriale ed analitico della realtà fenomenica delle cose, che si traduce in pittura in una minuziosa descrizione dei più piccoli dettagli, resi in maniera sorprendentemente realistica. A questa tipologia di opera sarebbe il caso di avvicinarsi con una lente d’ingrandimento, alla ricerca di personaggi nascosti, come, in questo caso, il bambino che assiste affacciato alla finestra al crudele destino di Gesù. Mi avvicino alla tela che va letta dall’ alto a sinistra a scendere, percorrendo con lo sguardo le strette vie raffigurate con dovizia di particolari, affollate di personaggi usciti da un presepe nordico, ognuno con caratteristiche proprie. Mi perdo in uno spazio urbano che sembra rifuggire i principi della prospettiva e della verosimiglianza, l’autore ha inserito più di venti scene della Passione di Cristo, così come sono ricordate dai Vangeli. In primo piano, ai lati, vi sono rappresentati i committenti, Tommaso e Maria Portinari, due facoltosi banchieri fiorentini.
All’interno della Galleria vi sono altri quadri fiamminghi, tutti, a mio personalissimo avviso, da osservare avvicinandosi il più possibile, con sguardo indagatore, come si volesse giocare a fare i “detective”. Incontro varie nature morte, composizioni di fiori pomposi, bicchieri e vetri lucenti e piccoli insetti che si inseriscono nel componimento con “nonchalance”; mi imbatto in grandi maestri quali Anton van Dyck, (Principe di Savoia Tommaso Carignano, 1634), Van Weyden e un minuscolo ma non meno affascinate Rembrandt Harmenzoon van Rijn. Non riesco a non fermarmi davanti alla piccola opera, sembra una fotografia scattata al buio, gli occhi si devono abituare all’oscurità che si sta osservando e finalmente percepiscono i dettagli che emergono dall’ombra: una brace ormai spenta illumina una brocca, un attizzatoio e delle aringhe messe a essiccare. La fioca luce, vera protagonista del componimento, si posa anche sul volto dormiente e sulle dita intrecciate dell’anziano signore, vestito di nero e seduto abbandonato su una sedia. La virtuosistica tela quasi monocroma è databile al 1629, il suo significato rimane incompreso, alcuni pensano si tratti di un filosofo o Tobia dormiente, oppure ancora l’allegoria dell’accidia o il ritratto del padre del pittore prossimo alla morte.
Guardo un’ultima volta la piccola composizione, per avere la certezza di non essermi persa nessun dettaglio, poi mi allontano piano, come non volessi svegliare l’assopito vecchio stanco.
Mi aggiro per la pinacoteca continuamente osservata da tutti quei personaggi dipinti, ogni tela cela una storia al suo interno, come nel caso dell’opera di Bartolomeo Passerotti, “Perseo e Andromeda”, nella quale l’autore raffigura l’eroe di ritorno dall’impresa dell’uccisione della mostruosa Gorgone, nel momento in cui si imbatte nella candida fanciulla ancorata allo scoglio, lì imprigionata a causa della spregiudicatezza della madre. Quasi non me ne accorgo, ma sto inconsciamente giocando a riconoscere miti e personaggi studiati sui libri di scuola durante le ore di letteratura, riconosco l’episodio di Ercole che affida Deainira al Centauro Nesso, rappresentato da Pecheux, Apollo e Dafne e Pan e Siringa nelle opere di Filippo Lauri, ancora mi soffermo davanti a Lucrezia, magistralmente rappresentata da Guido Reni nell’atto estremo del suicidio, ma poi anche la tragica vicenda di Diana e Callisto nella tela di Cambiano e infine mi attardo un po’ di fronte all’opera di Galliari, che raffigura un mito che molto concerne Torino, “La caduta di Fetonte”.
 Forse non si sa, o quantomeno non si dice abbastanza, ma nel capoluogo piemontese, proprio nella Galleria Sabauda, sono conservati grandi nomi della storia dell’arte, quali Botticelli, di cui è visibile la così detta “Venere Gualino”, dal nome del suo acquirente, Riccardo Gualino, che la comprò nel 1920 per poi cederla dieci anni dopo alla Galleria. Davanti al quadro è impossibile non pensare alla ben più nota Venere degli Uffizi. L’opera venne probabilmente realizzata nel momento di massima attività della bottega del maestro fiorentino. La fanciulla si presenta nuda al visitatore, leggera e pallida, alle sue spalle una nicchia dal fondo scuro; poggia i piedi su un gradino di marmo chiaro, che le vicende conservative del dipinto hanno reso leggermente sghembo. Cerca, con pudore, di coprirsi con le mani e con i lunghi capelli biondi ramati. Oggi si tende a vedere nella “Venere Gualino” un’opera indipendente, anche tenendo conto di una menzione di Giorgio Vasari, che ricorda come in varie case fiorentine si trovassero raffigurazioni simili, prodotte nella bottega di Botticelli: una scultura della tipologia della “Venus Pudica” dovette essere il modello in comune tra queste opere e la tela degli Uffizi. Altri nomi in cui ci si imbatte con timoroso rispetto sono Filippino Lippi, Andrea Mantegna, Beato Angelico, Veronese, Tiepolo, Orazio Gentileschi, Vanvitelli, Canaletto e altri, autori che ha più senso vi inviti ad andare a visionare piuttosto che elencarli freddamente.
Forse non si sa, o quantomeno non si dice abbastanza, ma nel capoluogo piemontese, proprio nella Galleria Sabauda, sono conservati grandi nomi della storia dell’arte, quali Botticelli, di cui è visibile la così detta “Venere Gualino”, dal nome del suo acquirente, Riccardo Gualino, che la comprò nel 1920 per poi cederla dieci anni dopo alla Galleria. Davanti al quadro è impossibile non pensare alla ben più nota Venere degli Uffizi. L’opera venne probabilmente realizzata nel momento di massima attività della bottega del maestro fiorentino. La fanciulla si presenta nuda al visitatore, leggera e pallida, alle sue spalle una nicchia dal fondo scuro; poggia i piedi su un gradino di marmo chiaro, che le vicende conservative del dipinto hanno reso leggermente sghembo. Cerca, con pudore, di coprirsi con le mani e con i lunghi capelli biondi ramati. Oggi si tende a vedere nella “Venere Gualino” un’opera indipendente, anche tenendo conto di una menzione di Giorgio Vasari, che ricorda come in varie case fiorentine si trovassero raffigurazioni simili, prodotte nella bottega di Botticelli: una scultura della tipologia della “Venus Pudica” dovette essere il modello in comune tra queste opere e la tela degli Uffizi. Altri nomi in cui ci si imbatte con timoroso rispetto sono Filippino Lippi, Andrea Mantegna, Beato Angelico, Veronese, Tiepolo, Orazio Gentileschi, Vanvitelli, Canaletto e altri, autori che ha più senso vi inviti ad andare a visionare piuttosto che elencarli freddamente.
Prima di uscire “a riveder le stelle” vorrei soffermarmi ancora su un’opera e su un autore che amo particolarmente: “Ercole nel giardino delle Esperidi” di Pieter Paul Rubens, (Siegen, 1577-Anversa, 1640). L’opera si trova nella sala 29, dove sono esposti altri capolavori del genio barocco per eccellenza. Nelle sue opere prevale la complessità, la policentricità, l’intrecciarsi di motivi e linee di forza, la pienezza rigogliosa delle forme, lo splendore e la vivacità dei colori, il virtuosismo tecnico che gli permette di giungere ad una definizione dell’opera molto finita e preziosa. In questo specifico quadro è rappresentato un Ercole forzuto e massiccio, fatto di carne e di muscoli, secondo i canoni di Rubens, mentre sta per cogliere i pomi d’oro nel mitico giardino delle Esperidi. È l’undicesima fatica che l’eroe greco deve affrontare e che riesce a superare grazie al consiglio di Prometeo, che gli suggerisce di farsi aiutare da Atlante.
Alcuni di voi si ricorderanno la divertente rivisitazione Disney in cui il protagonista viene appellato “scemercole”, bene, forse è vero che l’intelligenza è caratteristica più di Odisseo che di Ercole, ma in questo episodio l’eroe dimostra di sapersela cavare. Quando Ercole si reca da Atlante, quest’ultimo accetta di aiutarlo, ma per poterlo fare è necessario che il forzuto greco regga un po’ il Mondo al posto suo; Ercole acconsente e a quel punto Atlante, sgranchendosi la schiena, fa per andarsene e abbandonare l’eroe a quel compito infausto. Spaventato dal quel mesto destino Ercole aguzza l’ingegno: “Fammi aggiustare la veste prima di andartene,” dice Ercole ad Atlante mentre gli ripassa quel Mondo così pesante, e l’altro ci casca in pieno.
Dall’arte c’è sempre qualcosa da imparare.
Alessia Cagnotto
Un viaggio nel tempo e nella storia di Torino” (Ed. Graphot) nel quale l’autore Giuliano Vergnasco ripercorre la storia e lo sviluppo della città tramite le piazze, da quelle storiche del centro a quelle dei quartieri più periferici legando ad esse immagini storie e personaggi.
“Piazze, larghi e rondò. Un viaggio nel tempo e nella storia di Torino” con le sue 350 pagine e le oltre 500 immagini si propone come la strenna natalizia del 2022 per gli appassionati della storia cittadina.
L’autore: Giuliano Vergnasco nato il 10 marzo 1967 a due passi da Piazza Statuto, è da sempre appassionato di storia, in particolare quella di Torino. Collezionista di libri, guide, cartine e fotografie della città. Gestisce il blog “Like a killer in the sun”, nel quale parla di politica, attualità, sport, cucina e di libri. Autore del podcast “Torino tra storia e trasformazioni” nel quale in brevi pillole racconta la città. Ha pubblicato con Loredana Cella “Piazza Statuto e Porta Susa” (Graphot, 2012) e ha partecipato alle raccolte di racconti “Barriera stories” (Graphot, 2021) e “A Torino Centro” (Edizioni della Sera, 2022).