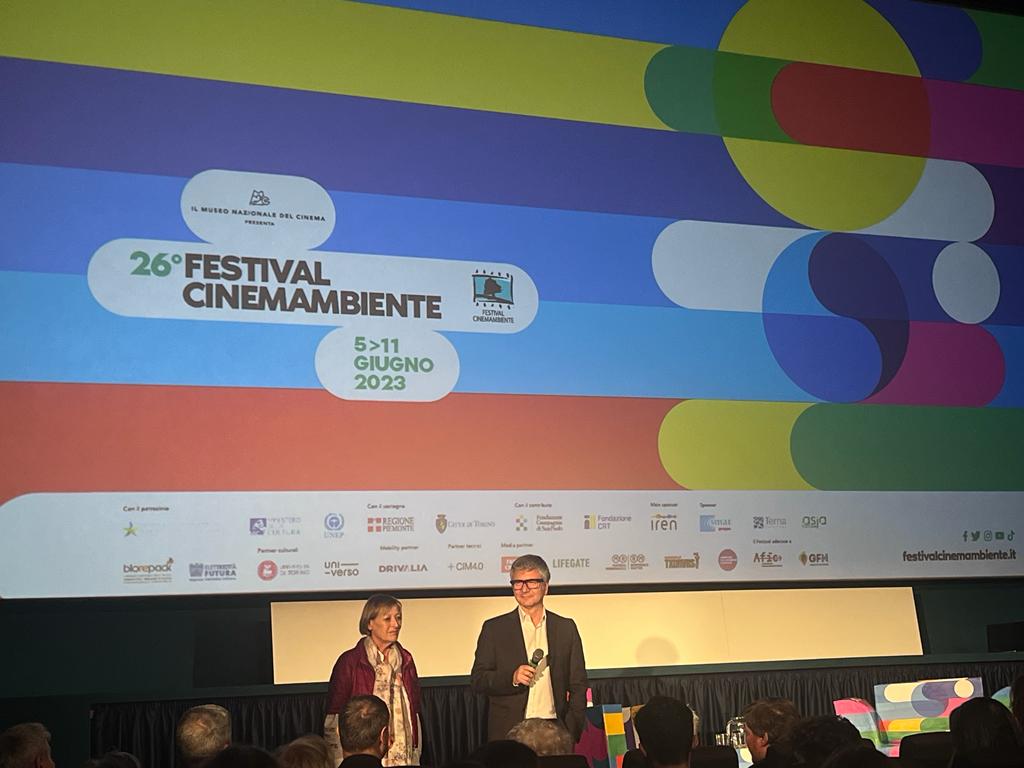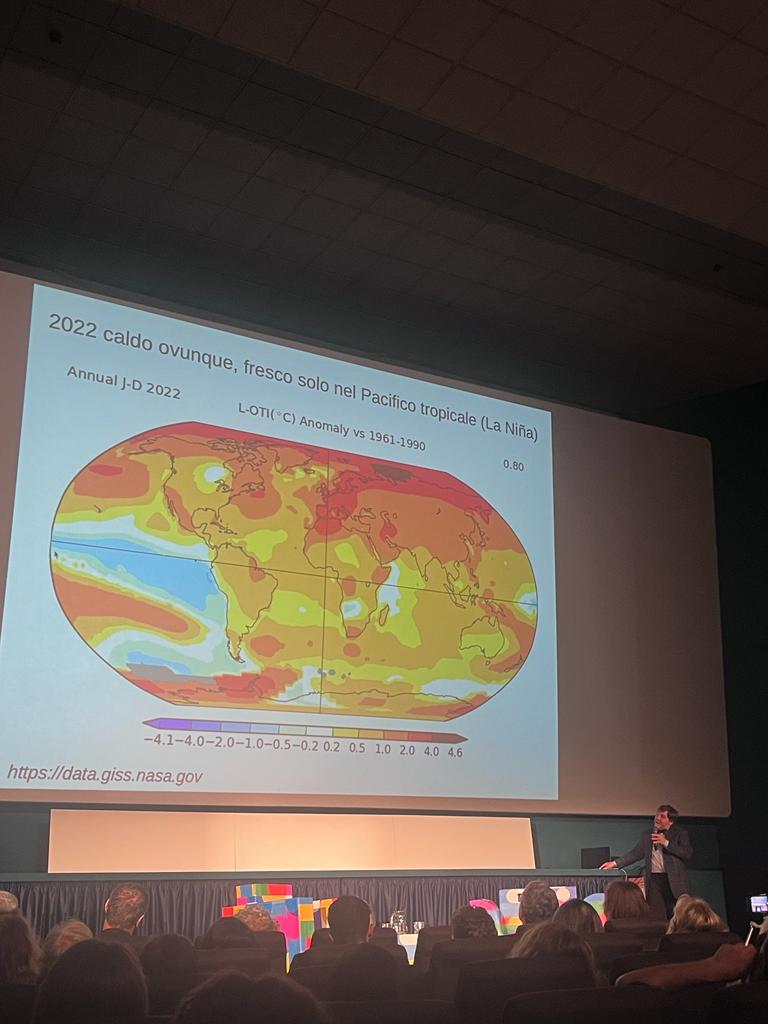Si estende alla Circoscrizione 2 la raccolta di prossimità degli oli vegetali di provenienza domestica. Prende il via oggi, infatti, il posizionamento di oltre 70 cassonetti a Mirafiori Nord, Mirafiori Sud e Santa Rita: i contenitori, di colore blu, verranno collocati da Amiat in altrettanti luoghi individuati di concerto con la Città e la Circoscrizione, nell’ambito dell’Accordo siglato tra la Città di Torino, Amiat Gruppo Iren e CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).
Il progetto di estensione della raccolta di prossimità ha preso avvio nel mese di aprile nella Circoscrizione 8, dove sono già stati attivati oltre 50 punti di raccolta, ed è disponibile anche nella Circoscrizione 6. Il servizio verrà poi esteso a tutta la città, aggiungendosi a quello già attivo presso i Centri di raccolta Amiat, dove è possibile conferire gli oli vegetali esausti all’interno dei fusti presenti.
Nei punti di raccolta collocati sul territorio, invece, l’olio vegetale esausto, precedentemente filtrato da impurità ed eventuali residui di cibo per ottimizzare il processo di trasformazione da rifiuto a risorsa, dovrà essere raccolto in bottiglie ben chiuse che dovranno essere conferite direttamente all’interno degli appositi contenitori. Sarà possibile smaltire olio di oliva e di semi vari usati per frittura, oli di conservazione dei cibi in scatola o in vetro e oli vegetali deteriorati o scaduti.
Prosegue inoltre la campagna di comunicazione congiunta di Città, CONOE e Amiat, “Trasforma un rifiuto in risorsa” che, attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione di opuscoli informativi sta accompagnando il progetto, con l’obiettivo di informare i cittadini e di sensibilizzarli anche alla corretta gestione degli oli vegetali esausti.
Per maggiori informazioni: https://www.amiat.it/servizi/raccolta-oli-vegetali-esausti