E’ ambientato nel “piccolo paradiso proletario” del vecchio Borgo Campidoglio di Torino
Un “giallo” urbano, dal titolo intrigante e un tantino inquietante. “Zeus ti vede”. Proprio come recita la scritta misteriosa in cui, non di rado, ci si imbatte per le strade – soprattutto periferiche – dell’esoterica Torino (e di altre città), sulla cui origine si sono spese nel tempo svariate, improbabili e perfino un po’ folcloriche versioni e interpretazioni.
 Tre parole e il disegno di un triangolo simbolico al cui interno un grande occhio scruta e avverte minaccioso i passanti. Tre parole che danno anche il titolo all’ultimo libro (224 pagine, pubblicate da “Neos edizioni”) del torinese Riccardo Marchina, giornalista e scrittore, che già per “Neos” aveva scritto nel 2011 “L’agenzia dei segreti precari” e nel 2018 “Lo squalo delle rotaie”. E proprio quelle parole affiorano alla mente di Pietro, il protagonista del romanzo, allorché pensa o si trova davanti all’imbarazzante bellezza di Mascia che “aveva grandi cosce, appiccicate a un corpo magro” e sulla schiena “aveva tatuato un sole stilizzato, all’interno del quale c’era un triangolo” e ancora “al suo interno c’era un occhio. Era una sorta di ‘Zeus ti vede’”. Siamo a Torino all’interno del vecchio Borgo Campidoglio, quartiere operaio sorto a fine ‘800, caratteristica isola di case basse (oggi museo a cielo aperto d’arte urbana – il MAU – per le circa 200 opere pittoriche di street – art dipinte sui muri esterni), di botteghe che sono memoria fascinosa di antichi mestieri artigianali, enoteche e caratteristiche piole dai prodotti tipici e dai semplici ma robusti e sinceri vini locali: “periferia ovest della città, dove corso Regina Margherita si perdeva nel parco della Pellerina, prima di diventare una cosa unica con la tangenziale”. E proprio qui si snoda gran parte della storia di Pietro. Quattro figli avuti da due (ex) compagne diverse, quindi due famiglie da mantenere, l’uomo lavora in un’impresa di torrefazione di Torino, fino a quando una multinazionale olandese acquisisce l’azienda e la sua vita comincia a rotolare all’ingiù. Licenziato e addirittura sospettato dell’omicidio della responsabile del personale, con la quale aveva una relazione, Pietro è condannato a giornate scandite da frustranti colloqui di lavoro e convocazioni in commissariato. Sullo sfondo la Torino ch’era un tempo città dell’auto, del caffè, della cioccolata, della birra, della penna a sfera, dell’informatica… e ora é “città sempre più fluida, inafferrabile e infida”. A sostenerlo nei vorticosi tentativi di riprendere in mano la propria vita, c’è però Mascia, giovane e provocante cameriera di una scalcinata ma accogliente trattoria di Borgo Campidoglio. “Giallo” urbano, si diceva. Ma non solo. Con questo romanzo, infatti, Riccardo Marchina intende superare la quotidiana, intricata e avvincente realtà degli eventi, sfruttati a base solida da cui partire per proporci una “riflessione sul mondo del lavoro fatto di acquisizioni aziendali e società di outplacement, di globalizzazione spinta e difesa del made in Italy, di esuberi e bandiere sindacali affisse ai cancelli delle fabbrichette, di responsabili del personale imbevuti di tecniche e filosofie aziendali e start-up come rimedio estremo all’impossibilità di ricollocarsi”. In tal senso, le parole dello scrittore (che per “Neos” cura anche la serie antologica “Spirito d’estate”) ci portano dentro, e fino al fondo di una realtà contemporanea assurda, frenetica e imprendibile, dalla quale non resta che fuggire. “Verso un posto dove Zeus non possa più vederci”.
Tre parole e il disegno di un triangolo simbolico al cui interno un grande occhio scruta e avverte minaccioso i passanti. Tre parole che danno anche il titolo all’ultimo libro (224 pagine, pubblicate da “Neos edizioni”) del torinese Riccardo Marchina, giornalista e scrittore, che già per “Neos” aveva scritto nel 2011 “L’agenzia dei segreti precari” e nel 2018 “Lo squalo delle rotaie”. E proprio quelle parole affiorano alla mente di Pietro, il protagonista del romanzo, allorché pensa o si trova davanti all’imbarazzante bellezza di Mascia che “aveva grandi cosce, appiccicate a un corpo magro” e sulla schiena “aveva tatuato un sole stilizzato, all’interno del quale c’era un triangolo” e ancora “al suo interno c’era un occhio. Era una sorta di ‘Zeus ti vede’”. Siamo a Torino all’interno del vecchio Borgo Campidoglio, quartiere operaio sorto a fine ‘800, caratteristica isola di case basse (oggi museo a cielo aperto d’arte urbana – il MAU – per le circa 200 opere pittoriche di street – art dipinte sui muri esterni), di botteghe che sono memoria fascinosa di antichi mestieri artigianali, enoteche e caratteristiche piole dai prodotti tipici e dai semplici ma robusti e sinceri vini locali: “periferia ovest della città, dove corso Regina Margherita si perdeva nel parco della Pellerina, prima di diventare una cosa unica con la tangenziale”. E proprio qui si snoda gran parte della storia di Pietro. Quattro figli avuti da due (ex) compagne diverse, quindi due famiglie da mantenere, l’uomo lavora in un’impresa di torrefazione di Torino, fino a quando una multinazionale olandese acquisisce l’azienda e la sua vita comincia a rotolare all’ingiù. Licenziato e addirittura sospettato dell’omicidio della responsabile del personale, con la quale aveva una relazione, Pietro è condannato a giornate scandite da frustranti colloqui di lavoro e convocazioni in commissariato. Sullo sfondo la Torino ch’era un tempo città dell’auto, del caffè, della cioccolata, della birra, della penna a sfera, dell’informatica… e ora é “città sempre più fluida, inafferrabile e infida”. A sostenerlo nei vorticosi tentativi di riprendere in mano la propria vita, c’è però Mascia, giovane e provocante cameriera di una scalcinata ma accogliente trattoria di Borgo Campidoglio. “Giallo” urbano, si diceva. Ma non solo. Con questo romanzo, infatti, Riccardo Marchina intende superare la quotidiana, intricata e avvincente realtà degli eventi, sfruttati a base solida da cui partire per proporci una “riflessione sul mondo del lavoro fatto di acquisizioni aziendali e società di outplacement, di globalizzazione spinta e difesa del made in Italy, di esuberi e bandiere sindacali affisse ai cancelli delle fabbrichette, di responsabili del personale imbevuti di tecniche e filosofie aziendali e start-up come rimedio estremo all’impossibilità di ricollocarsi”. In tal senso, le parole dello scrittore (che per “Neos” cura anche la serie antologica “Spirito d’estate”) ci portano dentro, e fino al fondo di una realtà contemporanea assurda, frenetica e imprendibile, dalla quale non resta che fuggire. “Verso un posto dove Zeus non possa più vederci”.
g. m.





 L’autobus sul quale erano soliti viaggiare aveva l’impianto di riscaldamento fuori uso e la sola idea di farsi più di cinquecento al freddo metteva i brividi in corpo. Contattarono all’aeroclub locale il Dwyer Flying Service e affittarono l’unico aereo disponibile, un piccolo Beechcraft Bonanza da quattro posti, compreso quello per il pilota. Quest’ultimo, Roger Peterson, di anni ne aveva ventuno e non molta esperienza di volo. I tre posti per i passeggeri erano riservati allo stesso Holly e a due membri della sua band. Ma le cose andarono diversamente. “Big Bopper” chiese a Waylon Jennings, uno dei musicisti, di barattare il proprio posto con la scusa di un’influenza che lo stava tormentando. Jennings accettò di buon grado ma gli rimase per sempre il rimorso della battuta scherzosa che accompagnò con una risata: “che possiate schiantarvi al suolo con quel trabiccolo”. Anche Ritchie Valens si ritrovò a bordo per un capriccio del destino: non avendo mai viaggiato su un aereo da turismo chiese di potersi giocare il posto con l’altro musicista, Tommy Allsup. La decisione fu presa a testa o croce, lanciando in aria una monetina da 50 cent. Buddy Holly, che all’epoca aveva solo ventidue anni, aveva pubblicato tre album ed era ormai una star del rock’n’roll dopo aver lavorato in radio e in televisione con i The Crickets, la sua band. Ritchie Valens di anni ne aveva appena diciassettenne e la canzone che aveva da poco inciso ( La Bamba) era destinata a un successo clamoroso che la sorte gli impedì di conoscere e godere. Coi suoi ventinove anni il più vecchio fra i tre era J.P. “The Big Bopper” Richardson, autore di brani celebri come Chantilly Lake, destinato a entrare nella colonna sonora di American Graffiti del 1973. Era da poco passata la mezzanotte quando i tre musicisti raggiunsero l’aereo e al momento decollo, quasi all’una, nevicava fitto e in quell’inferno bianco era praticamente impossibile orientarsi a vista. Peterson si affidò alla strumentazione di bordo pur non avendo mai conseguito la certificazione necessaria per volare esclusivamente in quel modo. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. Nell’incidente persero tutti la vita. La mattina dopo i corpi di Buddy Holly e Ritchie Valens furono trovati a pochi metri dall’aereo mentre Big Bopper e il pilota furono sbalzati più lontano. Nel ’70 il testo della canzone American Pie di Don McLean rese l’idea della tragedia che si era consumata in una notte d’inverno del 1959: “Non ricordo se ho pianto/quando ho letto della sua sposa rimasta vedova/ma qualcosa mi ha toccato nel profondo/il giorno che la musica è morta”. “Muore giovane chi è caro agli dei”: così il greco Menandro scriveva attorno al 350 a.C. per tentare di dare senso a un dolore troppo grande. La morte prematura li consegnò al mito e la loro musica, soprattutto quella di Buddy Holly, influenzò per decenni il rock, dalle band semisconosciute fino ai Beatles e ai Rolling Stones. Oltre all’immortale musicaci restano i tre memoriali eretti in loro onore, opera dell’artista Ken Paquette. Uno si trova a otto chilometri da Clear Lake e rappresenta una steel guitar accanto a tre loro dischi. Un altro è alla Riverside Ballroom di Green Lake, nel Wisconsin, dove i tre si erano esibiti due sere prima della sciagura. L’ultimo, dedicato al giovane pilota, venne inaugurato sul logo dello schianto nel cinquantesimo anniversario della sciagura.
L’autobus sul quale erano soliti viaggiare aveva l’impianto di riscaldamento fuori uso e la sola idea di farsi più di cinquecento al freddo metteva i brividi in corpo. Contattarono all’aeroclub locale il Dwyer Flying Service e affittarono l’unico aereo disponibile, un piccolo Beechcraft Bonanza da quattro posti, compreso quello per il pilota. Quest’ultimo, Roger Peterson, di anni ne aveva ventuno e non molta esperienza di volo. I tre posti per i passeggeri erano riservati allo stesso Holly e a due membri della sua band. Ma le cose andarono diversamente. “Big Bopper” chiese a Waylon Jennings, uno dei musicisti, di barattare il proprio posto con la scusa di un’influenza che lo stava tormentando. Jennings accettò di buon grado ma gli rimase per sempre il rimorso della battuta scherzosa che accompagnò con una risata: “che possiate schiantarvi al suolo con quel trabiccolo”. Anche Ritchie Valens si ritrovò a bordo per un capriccio del destino: non avendo mai viaggiato su un aereo da turismo chiese di potersi giocare il posto con l’altro musicista, Tommy Allsup. La decisione fu presa a testa o croce, lanciando in aria una monetina da 50 cent. Buddy Holly, che all’epoca aveva solo ventidue anni, aveva pubblicato tre album ed era ormai una star del rock’n’roll dopo aver lavorato in radio e in televisione con i The Crickets, la sua band. Ritchie Valens di anni ne aveva appena diciassettenne e la canzone che aveva da poco inciso ( La Bamba) era destinata a un successo clamoroso che la sorte gli impedì di conoscere e godere. Coi suoi ventinove anni il più vecchio fra i tre era J.P. “The Big Bopper” Richardson, autore di brani celebri come Chantilly Lake, destinato a entrare nella colonna sonora di American Graffiti del 1973. Era da poco passata la mezzanotte quando i tre musicisti raggiunsero l’aereo e al momento decollo, quasi all’una, nevicava fitto e in quell’inferno bianco era praticamente impossibile orientarsi a vista. Peterson si affidò alla strumentazione di bordo pur non avendo mai conseguito la certificazione necessaria per volare esclusivamente in quel modo. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. Nell’incidente persero tutti la vita. La mattina dopo i corpi di Buddy Holly e Ritchie Valens furono trovati a pochi metri dall’aereo mentre Big Bopper e il pilota furono sbalzati più lontano. Nel ’70 il testo della canzone American Pie di Don McLean rese l’idea della tragedia che si era consumata in una notte d’inverno del 1959: “Non ricordo se ho pianto/quando ho letto della sua sposa rimasta vedova/ma qualcosa mi ha toccato nel profondo/il giorno che la musica è morta”. “Muore giovane chi è caro agli dei”: così il greco Menandro scriveva attorno al 350 a.C. per tentare di dare senso a un dolore troppo grande. La morte prematura li consegnò al mito e la loro musica, soprattutto quella di Buddy Holly, influenzò per decenni il rock, dalle band semisconosciute fino ai Beatles e ai Rolling Stones. Oltre all’immortale musicaci restano i tre memoriali eretti in loro onore, opera dell’artista Ken Paquette. Uno si trova a otto chilometri da Clear Lake e rappresenta una steel guitar accanto a tre loro dischi. Un altro è alla Riverside Ballroom di Green Lake, nel Wisconsin, dove i tre si erano esibiti due sere prima della sciagura. L’ultimo, dedicato al giovane pilota, venne inaugurato sul logo dello schianto nel cinquantesimo anniversario della sciagura.







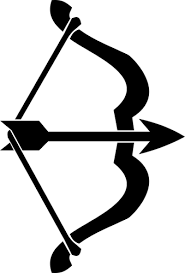 FRECCIATE
FRECCIATE


