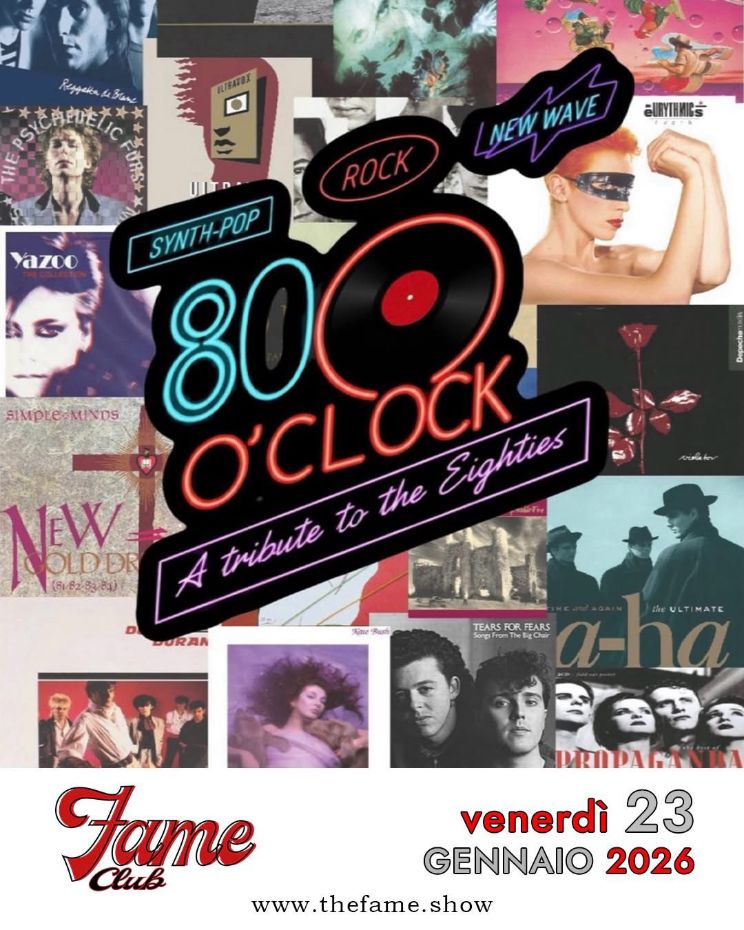In scena giovedì 22 e venerdì 23 gennaio prossimi, al teatro Astra, la pièce teatrale del drammaturgo e regista Ashkan Khatibi sull’oppressione del regime iraniano, tema più che mai attuale
Andrà in scena giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, alle ore 21, al teatro Astra, la pièce teatrale “Lui” di Ashkan Khatibi, classe 1979, drammaturgo, attore, regista, cantante, musicista e produttore iraniano. Dopo l’uccisione di Mahsa Amini, si è distinto come una delle voci più vicine alle istanze popolari contro la Repubblica Islamica. Dopo essere stato arrestato e violentemente interrogato dall’intelligence iraniana, ha lasciato il suo Paese, la famiglia e i suoi allievi, arrivando in Italia e proseguendo la sua vita artistica nel 2021.
“Lui” è molto più di una performance, rappresenta una lettera aperta al mondo libero, al centro della quale vi è la lotta per non farsi divorare dall’oscurità dei regimi totalitari oppressivi. Da considerarsi “mostro” è la dittatura e il protagonista cerca in maniera disperata di non trasformarsi in esso. Lo spettacolo è un grido per richiamare l’attenzione di chi non ha mai conosciuto la censura, e la repressione, come parte integrante del loro corpo, della loro anima e della loro opera. Il linguaggio scenico scelto fonde recitazione e video design, curato da Kinia Rahman. Khatibi, attraverso una pièce teatrale in lingua farsi, con sovratitoli in italiano, composta da 13 scene, racconta la vita di scrittori e artisti che operano all’ombra della censura. In ognuna di queste scene, l’attore interpreta un personaggio che subisce violenza fisica e psicologica. Emerge, in queste scene, l’indifferenza del potere verso l’essere umano. Nonostante il titolo paia suggerire una certa solitudine esistenziale, lo spettacolo è il risultato di un intenso lavoro di squadra, con il coordinamento di Negar Mokarram Dorri e un team creativo composto da Sadaf Baghbani e Parinaz Ghasedi alla regia, Danial M. alla scenografia. La traduzione è di Sanam Naderi.
Teatro Astra- via Rosolino Pilo 6, Torino – fondazionetpe.it
Mara Martellotta