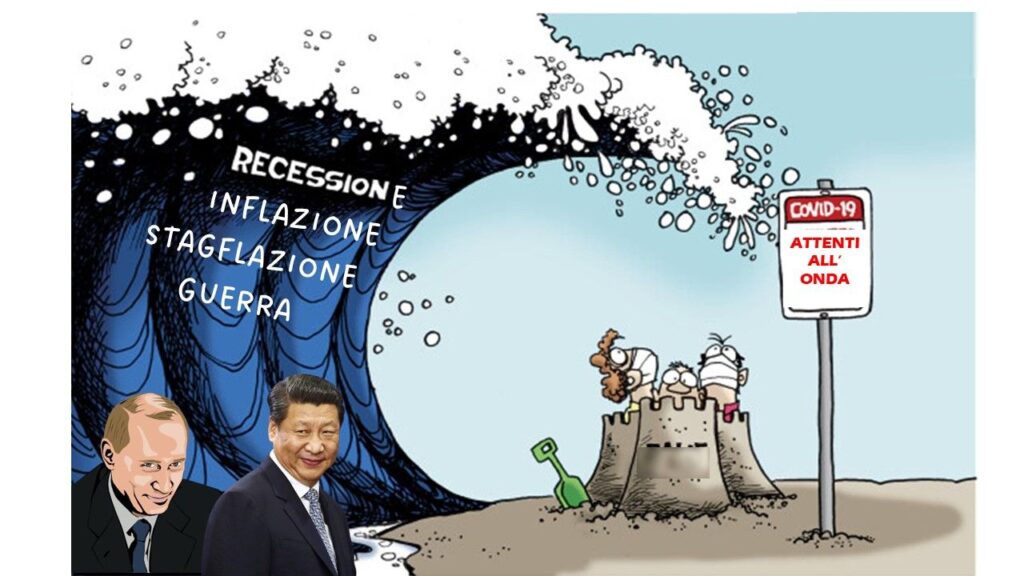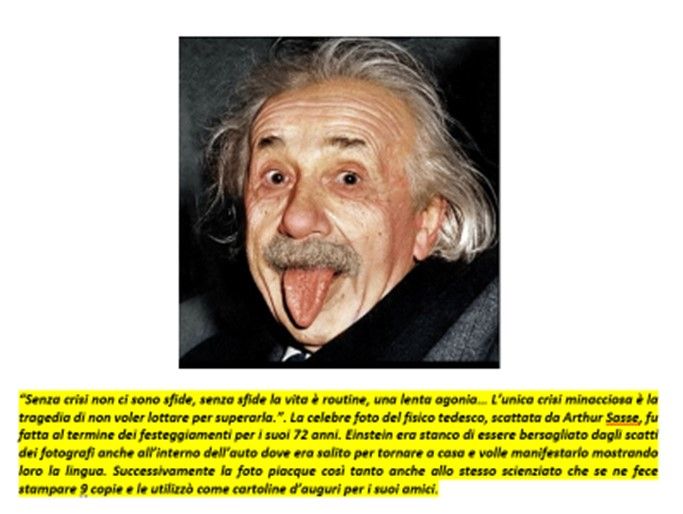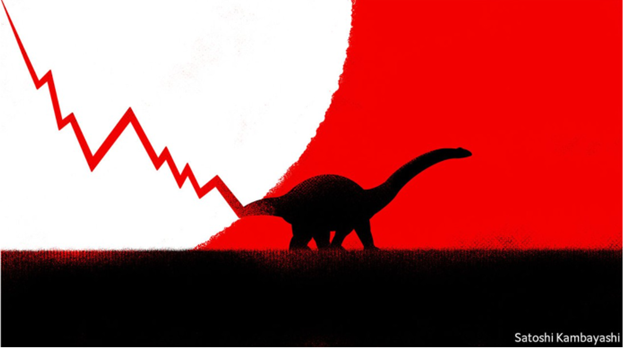IL PUNTASPILLI di Luca Martina
Tutti coloro che hanno avuto modo di effettuare un viaggio aereo avranno ben presente la sensazione di leggero disagio che accompagna l’annuncio dell’atterraggio.
Le cinture vanno allacciate, i sedili riportati in posizione e le bevande vengono ritirate dagli assistenti di volo: occorre evitare che nel momento nel quale i carrelli toccheranno la pista le vibrazioni provochino dei danni ai viaggiatori.
Molto raramente il ritorno a terra si può autenticamente definire come un “atterraggio morbido”, dove non si avverte nessuna differenza tra l’attimo prima e quello immediatamente successivo all’impatto.

La capacità del pilota di limitare i sobbalzi al momento del contatto viene spesso premiata dagli applausi dei passeggeri, finalmente sollevati.
Simili applausi, seppure in senso metaforico, saranno certamente riscossi dai banchieri centrali (Jerome Powell negli Stati Uniti e Christine Lagarde nell’area euro) se riusciranno a fare approdare l’economia su di una pista piuttosto accidentata, senza generare spiacevoli incidenti.
Il dibattito sulla probabilità che ciò possa accadere si è particolarmente animato nelle ultime settimane.
Alcuni dei maggiori esponenti del mondo finanziario hanno rilasciato dichiarazioni molto pessimiste, che lasciano poco spazio a manovre che possano evitare le peggiori conseguenze.
L’amministratore delegato della banca d’affari statunitense JP Morgan, Jamie Dimon, teme l’arrivo di un “uragano economico”; il vulcanico fondatore della Tesla, Elon Musk, esprime una “fortissima sensazione negativa”; Larry Fink, al timone di BlackRock, prevede “inflazione altissima per molti anni” e, per chiudere in bellezza, John Waldron, presidente di Goldman Sachs, mette in guardia sulla presenza di una quantità mai vista prima di potenziali shocks…
Si tratta di esternazioni che preoccupano e che lasciano ben poche speranze al futuro immediato dell’economia mondiale, avviata, secondo costoro, verso una recessione molto severa.
Esistono però anche degli elementi che possono rendere possibile un rallentamento graduale, senza troppi violenti impatti sul duro terreno, della crescita.
I dati più confortanti provengono dagli Stati Uniti, come sempre precursori delle fasi di svolta economica. L’ultima indagine congiunturale (la ISM) ha mostrato un rallentamento sia dell’industria che dei servizi ma ambedue i settori si sono mantenuti al di sopra del livello (pari a 50) al di sotto del quale scatta l’allarme (il rischio di recessione).
Il rallentamento è una condizione indispensabile per raffreddare l’inflazione in quanto la riduzione della domanda di beni e servizi provoca la riduzione dei loro prezzi (o della loro salita).
Un altro fenomeno da seguire con attenzione è il surriscaldamento del mercato del lavoro dove il numero di posti richiesti dalle aziende è attualmente superiore alle persone in cerca di occupazione.
Questo squilibrio potrebbe innescare una spirale prezzi-salari.
La richiesta di aumenti degli stipendi per compensare la perdita del potere di acquisto è uno dei maggiori timori della Fed, la banca centrale statunitense: le aziende, per proteggere i loro bilanci, sarebbero indotte poi a scaricare i maggiori costi sui prezzi dei loro prodotti (acquistati grazie anche ai maggiori salari) producendo così ulteriore inflazione.
Per fortuna qualche elemento di conforto si può anche in questo caso trovare: la disoccupazione è solo ora tornata agli stessi livelli (recuperando quanto perso) pre-pandemia e anche le pressioni provenienti dai salari, saliti meno dell’inflazione, sono per il momento contenute.
Simili considerazioni possono valere anche per il nostro continente che, per la sua maggiore dipendenza dalle importazioni di risorse energetiche, sta affrontando una congiuntura più difficile di quella americana.
Insomma, non è ancora tutto perduto e un atterraggio complicato, ma in grado di evitare l’irreparabile, è ancora possibile.
I passeggeri/investitori dovranno senza dubbio ancora affrontare delle forti turbolenze e i piloti avranno il loro bel daffare per riportarci a casa spaventati ma indenni.
Per conservare il buon umore consiglierei di rivedere il film Sully, tratto dalla storia vera del capitano Chesley Sullenberger, in grado di fare atterrare un aereo della US Airways, con ambedue i motori danneggiati dall’impatto con uno stormo di uccelli, sul letto del fiume Hudson e di portare in salvo tutte le persone a bordo.
Naturalmente non prima di avere ben allacciato le cinture!