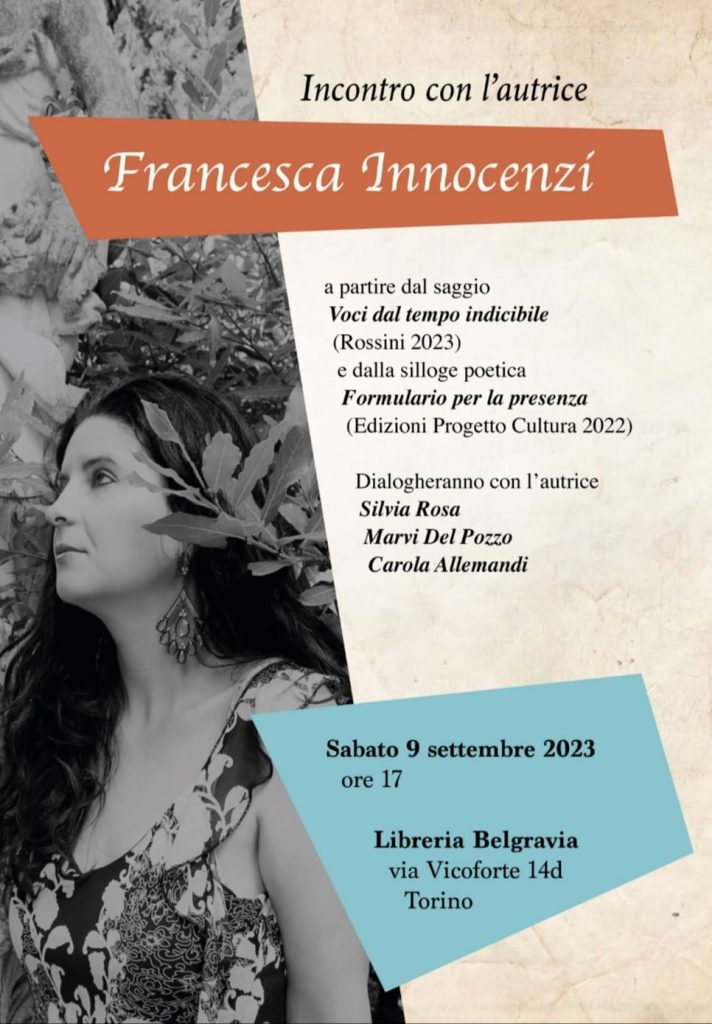GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Lunedì. Il sassofonista Pasquale Calò si esibisce al Cafè Des Arts.
Martedì. All’Osteria Rabezzana gli Umami celebrano la memoria di Salvador Allende. All’Hiroshima Mon Amour nel Sound Garden, i Rez eseguono canzoni ispirati a Pier Vittorio Tondelli. Al Blah Blah suonano i Los Peyotes. Al Jazz Club è di scena il trio di Emanuele Francesconi.
Mercoledì. Al Magazzino sul Po si esibisce Buck Meek. Al Blah Blah suonano i Pretty Boy Floyd affiancati dai Midnight Devils.
Giovedì. Al Jazz Club è di scena Gabriele Rossi. Al Carignano per il vernissage “IncluSì” canta Carmen Consoli.
Venerdì. Al Blah Blah suonano gli Isaak mentre allo Ziggy si esibiscono gli Adversor. Al Circolo della Stampa per “Set in scena, “ Elio rende omaggio a Enzo Jannacci con “Ci vuole orecchio”. All’Hiroshima si esibisce Meg. Il Festival “Culto” all’Amen presentail duo Dame Area e Francesca Heart. Al Magazzino sul Po si esibisce Petrolio e Nàresh Ran.
Sabato. Allo Ziggy suona la Ghetto Blaster Orchestra. Sulla collina di Dogliani Ludovico Einaudi presenta “Piano solo in linea d’aria”. All’Hiroshima musica per beneficenza della curva Maratona con Eugenio Cesaro, Boosta, Statuto, Beba, Madaski, Sergio Berardo. Al Magazzino sul Po suona il quartetto Lechuck. Per “Culto” alla Cavallerizza con Flavia Buttinelli , a seguire al Bunker si esibiscono gli Space Drum Meditation. Al Blah Blah si esibisce il duo The Devils. Al Conservatorio per il Festival MiTo, l’Orchestra Filarmonica di Torino con le pianiste Katia e Marielle Labèque. Oltre ad eseguire composizioni di Mozart interpretano il concerto per 2 pianoforti di Bryce Dessner.
Domenica. Al Circolo della Stampa teatro musicale con Neri Marcorè con “Gaber- Monologhi e canzoni”
Pier Luigi Fuggetta



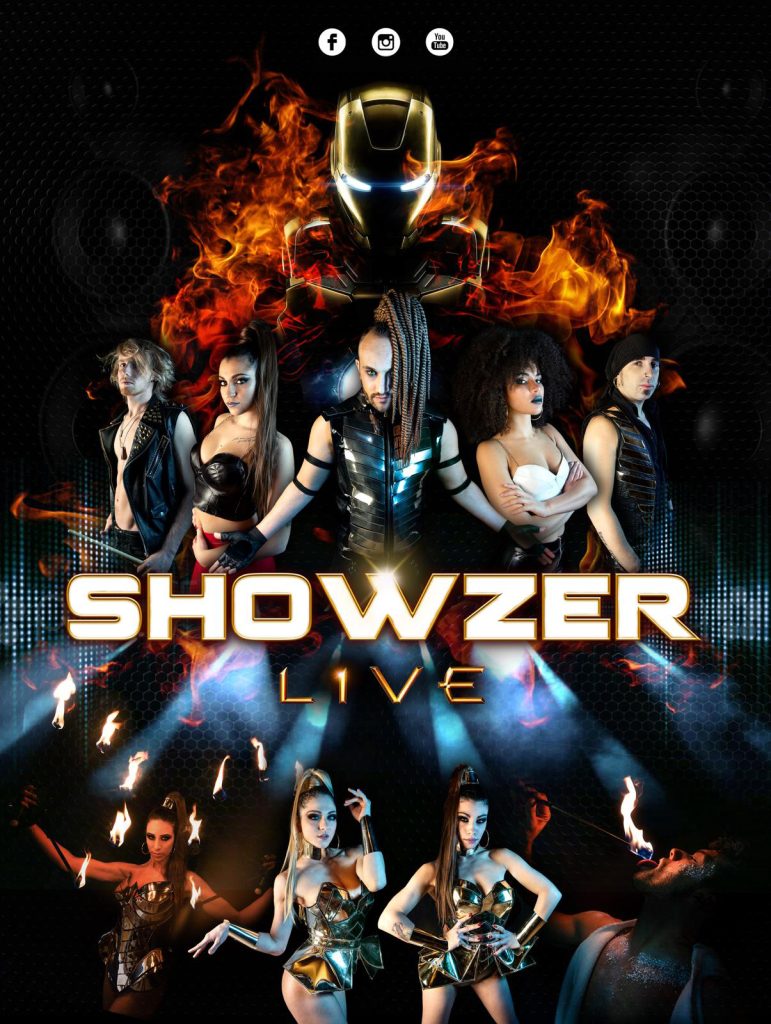



 Passano anche a Chieri, alcuni solo il tempo necessario per rifocillarsi e riprendere il cammino da poveri crociati, altri invece si fermano molto più a lungo e costruiscono, nell’attuale via Roma, una “domus” templare, la chiesa di San Leonardo, l’unico tempio in provincia di Torino posseduto dal potente Ordine medievale di monaci-cavalieri. Un tempo fu precettoria templare e poi divenne un ospedale dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i futuri cavalieri di Malta le cui croci ottagone si stagliano sulla facciata dell’edificio. Non tutto però fila liscia, templari e chieresi non sempre vanno d’accordo. Deve intervenire addirittura Federico II, l’imperatore svevo nato a Jesi, che tanto amava la nostra penisola. Cerca di fare da paciere tra il neonato comune di Chieri e i Templari per contrasti riguardanti la vendita di case e terreni. Risolve tutto e il documento firmato a Torino tra le parti nel 1245 pone fine alla disputa.
Passano anche a Chieri, alcuni solo il tempo necessario per rifocillarsi e riprendere il cammino da poveri crociati, altri invece si fermano molto più a lungo e costruiscono, nell’attuale via Roma, una “domus” templare, la chiesa di San Leonardo, l’unico tempio in provincia di Torino posseduto dal potente Ordine medievale di monaci-cavalieri. Un tempo fu precettoria templare e poi divenne un ospedale dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i futuri cavalieri di Malta le cui croci ottagone si stagliano sulla facciata dell’edificio. Non tutto però fila liscia, templari e chieresi non sempre vanno d’accordo. Deve intervenire addirittura Federico II, l’imperatore svevo nato a Jesi, che tanto amava la nostra penisola. Cerca di fare da paciere tra il neonato comune di Chieri e i Templari per contrasti riguardanti la vendita di case e terreni. Risolve tutto e il documento firmato a Torino tra le parti nel 1245 pone fine alla disputa. Con la caduta di Acri (oggi Akko in Israele) nel 1291, conquistata dai Mamelucchi, i cavalieri di San Giovanni furono costretti a fuggire dalla Terrasanta per riparare prima a Cipro e poi nell’isola di Rodi diventando i Cavalieri di Rodi. Obbligati a lasciare l’isola all’arrivo della flotta ottomana nel 1522 ottennero dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta e dal 1530 sono conosciuti come Cavalieri di Malta. Il cavaliere di Rodi Tommaso Ulitoto nei primi anni del Quattrocento fece ricostruire l’ospedale e la chiesa di San Leonardo che però cadde in uno stato di totale abbandono. Nell’Ottocento diventò perfino un’officina e il campanile fu abbattuto. Nei primi anni Trenta chiesa e domus templare furono acquistate dai salesiani e divennero parte integrante dell’attuale Oratorio di San Luigi. Della chiesa di San Leonardo è ancora visibile la piccola navata centrale ma non resta nulla dell’ospedale di Santa Croce dei Cavalieri di San Giovanni. All’interno della precettoria sono tornati alla luce, dopo lunghi restauri, preziosi affreschi del Quattrocento che illustrano la Passione di Cristo.
Con la caduta di Acri (oggi Akko in Israele) nel 1291, conquistata dai Mamelucchi, i cavalieri di San Giovanni furono costretti a fuggire dalla Terrasanta per riparare prima a Cipro e poi nell’isola di Rodi diventando i Cavalieri di Rodi. Obbligati a lasciare l’isola all’arrivo della flotta ottomana nel 1522 ottennero dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta e dal 1530 sono conosciuti come Cavalieri di Malta. Il cavaliere di Rodi Tommaso Ulitoto nei primi anni del Quattrocento fece ricostruire l’ospedale e la chiesa di San Leonardo che però cadde in uno stato di totale abbandono. Nell’Ottocento diventò perfino un’officina e il campanile fu abbattuto. Nei primi anni Trenta chiesa e domus templare furono acquistate dai salesiani e divennero parte integrante dell’attuale Oratorio di San Luigi. Della chiesa di San Leonardo è ancora visibile la piccola navata centrale ma non resta nulla dell’ospedale di Santa Croce dei Cavalieri di San Giovanni. All’interno della precettoria sono tornati alla luce, dopo lunghi restauri, preziosi affreschi del Quattrocento che illustrano la Passione di Cristo.