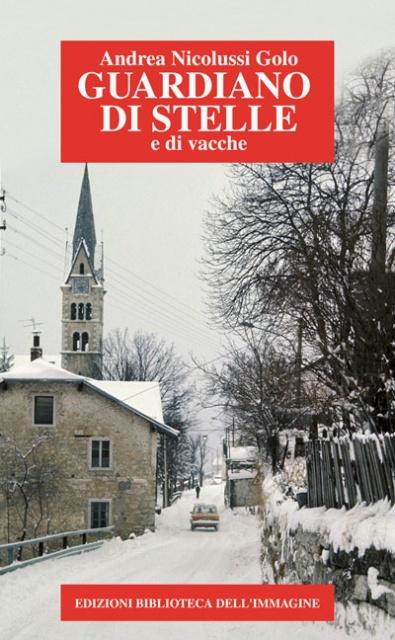indicavano solamente gli alienati o le persone affette da qualche disturbo psichico, ma anche i vagabondi, i mendicanti, i nullatenenti, gli sfaccendati, i maghi, i bestemmiatori, le donne di facili costumi, i libertini, i figli ribelli, i sifilitici, gli alcolisti, gli individui politicamente sospetti, gli eretici, e tutti quei personaggi stravaganti che potevano in un qualche modo essere fonte di instabilità sociale, pericolo per la cittadinanza o fonte di scandalo per le famiglie più abbienti. Per crudele ironia della sorte, fu proprio il re Vittorio Amedeo II, morto pazzo nel 1732, a finanziare la costruzione del primo “Spedale de’ Pazzerelli” a Torino. La struttura sorgeva tra via San Domenico, via Piave, via Bligny e via Santa Chiara, era gestita dalla Confraternita del SS. Sudario e Beata Vergine, che, in cambio, ottenne di non pagare l’acquisto dei materiali necessari per il funzionamento dell’attività, e già nel 1629, un anno dopo la sua costruzione, lo stabile era in grado di accogliere i primi degenti. All’interno della struttura i folli erano divisi dai vagabondi e dai criminali, inoltre i violenti, o coloro di più difficile gestione, erano sistemati in stanze più interne, mentre a potersi affacciare alle finestre che davano sulla normale vita cittadina, erano quelli ritenuti miti e innocui. Il buon cuore e la carità insiti nell’animo umano non tardarono a farsi sentire: all’esterno della struttura, gli abitanti delle case adiacenti al manicomio iniziarono a lamentarsi dei comportamenti scandalosi dei malati aldilà delle finestre; all’interno, invece, le condizioni di detenzione dei degenti stavano via via ulteriormente peggiorando, tanto che un esponente dei Savoia esordì con un “io qui dentro non ci metterei nemmeno i cavalli!” Il 13 maggio 1834, alla presenza di re Carlo Alberto, venne inaugurato il nuovo manicomio di Torino, che sostituì quello vecchio e sovraffollato; la nuova struttura venne indicata come l’“albergo dei due pini”, ingannevole perifrasi con cui veniva soprannominato l’orrido e temuto luogo di detenzione. Il complesso sorgeva non troppo lontano dal primo, tra via della Consolata, corso Valdocco, corso Regina Margherita e via Giulio, dove era situato l’ingresso. L’edifico era costituito da due lunghe maniche parallele interrotte al centro dal settore dei servizi, che separava il reparto femminile da quello maschile. Sulla carta, le corsie e le celle erano distribuite a seconda delle patologie e del grado di difficoltà che presentava il trattamento, vi era, inoltre, una sezione apposita per i maniaci provenienti dalle carceri. La grande innovazione di questo stabile stava nel fatto che veniva consentito ai degenti di passeggiare all’aria aperta, infatti, ad abbracciare l’edificio c’era uno spazioso giardino, a sua volta perimetrato da alte mura, divisione obbligatoria, materica ed ideologica tra il mondo dei normali e quello degli anormali. Anche un’altra innovazione coincise con l’edificazione del manicomio di via Giulio: il passaggio dei poteri dalla Confraternita ai sanitari, il periodo assistenziale gestito dai religiosi era finito, si apriva ora la fase clinica in cui il medico era il funzionario del nuovo ordinamento. Ad assumere l’incarico di primo medico interno in servizio fu Benedetto Trompeo, un dinamico trentunenne di larghe vedute, a cui si deve l’introduzione del concetto di cartella clinica e dell’ergoterapia. Grazie al suo metodo curativo, che si basava su una terapia sedativa, (salassi e bagni bollenti o congelati) e su una terapia “morale” che consisteva nel passeggiare per l’ombroso giardino, giocare alle bocce e leggere dei libri adatti, riuscì a dimettere cento pazienti come “risanati”. Gli successe Stefano Bonacosa, grande viaggiatore e studioso; egli si soffermò sull’influenza delle condizioni organiche e dell’ambiente sulla genesi della malattia mentale. Divenne primario del Regio Manicomio e il primo ad ottenere in Italia, nel 1850, la cattedra per l’insegnamento della psichiatria.
indicavano solamente gli alienati o le persone affette da qualche disturbo psichico, ma anche i vagabondi, i mendicanti, i nullatenenti, gli sfaccendati, i maghi, i bestemmiatori, le donne di facili costumi, i libertini, i figli ribelli, i sifilitici, gli alcolisti, gli individui politicamente sospetti, gli eretici, e tutti quei personaggi stravaganti che potevano in un qualche modo essere fonte di instabilità sociale, pericolo per la cittadinanza o fonte di scandalo per le famiglie più abbienti. Per crudele ironia della sorte, fu proprio il re Vittorio Amedeo II, morto pazzo nel 1732, a finanziare la costruzione del primo “Spedale de’ Pazzerelli” a Torino. La struttura sorgeva tra via San Domenico, via Piave, via Bligny e via Santa Chiara, era gestita dalla Confraternita del SS. Sudario e Beata Vergine, che, in cambio, ottenne di non pagare l’acquisto dei materiali necessari per il funzionamento dell’attività, e già nel 1629, un anno dopo la sua costruzione, lo stabile era in grado di accogliere i primi degenti. All’interno della struttura i folli erano divisi dai vagabondi e dai criminali, inoltre i violenti, o coloro di più difficile gestione, erano sistemati in stanze più interne, mentre a potersi affacciare alle finestre che davano sulla normale vita cittadina, erano quelli ritenuti miti e innocui. Il buon cuore e la carità insiti nell’animo umano non tardarono a farsi sentire: all’esterno della struttura, gli abitanti delle case adiacenti al manicomio iniziarono a lamentarsi dei comportamenti scandalosi dei malati aldilà delle finestre; all’interno, invece, le condizioni di detenzione dei degenti stavano via via ulteriormente peggiorando, tanto che un esponente dei Savoia esordì con un “io qui dentro non ci metterei nemmeno i cavalli!” Il 13 maggio 1834, alla presenza di re Carlo Alberto, venne inaugurato il nuovo manicomio di Torino, che sostituì quello vecchio e sovraffollato; la nuova struttura venne indicata come l’“albergo dei due pini”, ingannevole perifrasi con cui veniva soprannominato l’orrido e temuto luogo di detenzione. Il complesso sorgeva non troppo lontano dal primo, tra via della Consolata, corso Valdocco, corso Regina Margherita e via Giulio, dove era situato l’ingresso. L’edifico era costituito da due lunghe maniche parallele interrotte al centro dal settore dei servizi, che separava il reparto femminile da quello maschile. Sulla carta, le corsie e le celle erano distribuite a seconda delle patologie e del grado di difficoltà che presentava il trattamento, vi era, inoltre, una sezione apposita per i maniaci provenienti dalle carceri. La grande innovazione di questo stabile stava nel fatto che veniva consentito ai degenti di passeggiare all’aria aperta, infatti, ad abbracciare l’edificio c’era uno spazioso giardino, a sua volta perimetrato da alte mura, divisione obbligatoria, materica ed ideologica tra il mondo dei normali e quello degli anormali. Anche un’altra innovazione coincise con l’edificazione del manicomio di via Giulio: il passaggio dei poteri dalla Confraternita ai sanitari, il periodo assistenziale gestito dai religiosi era finito, si apriva ora la fase clinica in cui il medico era il funzionario del nuovo ordinamento. Ad assumere l’incarico di primo medico interno in servizio fu Benedetto Trompeo, un dinamico trentunenne di larghe vedute, a cui si deve l’introduzione del concetto di cartella clinica e dell’ergoterapia. Grazie al suo metodo curativo, che si basava su una terapia sedativa, (salassi e bagni bollenti o congelati) e su una terapia “morale” che consisteva nel passeggiare per l’ombroso giardino, giocare alle bocce e leggere dei libri adatti, riuscì a dimettere cento pazienti come “risanati”. Gli successe Stefano Bonacosa, grande viaggiatore e studioso; egli si soffermò sull’influenza delle condizioni organiche e dell’ambiente sulla genesi della malattia mentale. Divenne primario del Regio Manicomio e il primo ad ottenere in Italia, nel 1850, la cattedra per l’insegnamento della psichiatria. L’8 settembre del 1852 nasce il fin troppo celebre manicomio di Collegno, giorno in cui ottanta “maniaci maschi”, provenienti da via Giulio, furono trasferiti in una parte della vecchia Certosa Reale di Collegno. I nuovi ospiti risultarono un po’ troppo chiassosi per l’antico ordine monastico che viveva lì, volontariamente silenzioso e lontano dal mondo esterno, e così la convivenza finì nel 1855, anno in cui ufficialmente la Certosa di Collegno, con tutti i terreni annessi, entrò a far parte del patrimonio del Regio Manicomio. Le candide mura tennero al sicuro gli scrupoli di coscienza della gente comune fino al 4 giugno del 1998, quando l’ultimo ospite della struttura fu costretto ad andarsene. Dal punto di vista giuridico, la prima legge organica che regolamentò la materia fu la Legge 36, “Disposizione sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati”, relatore Giovanni Giolitti, approvata dal Parlamento italiano nel 1904. In questo modo la società si proteggeva dal “matto” e consentiva a chiunque di individuare un individuo “pericoloso a sé o agli altri” e chiederne l’internamento in manicomio dietro l’invio al Pretore di un certificato medico e di un atto di notorietà “nell’interesse degli infermi e della società”. Il numero dei ricoverati nei manicomi triplicò. La triste vicenda dello studio e della cura della follia continua, si complica e diventa più affollata. Con l’aumentare dei ricoverati nacquero altre strutture, nel 1913 il Ricovero di Savonera, nel 1931 l’Istituto interprovinciale Vittorio Emanuele III per infermi di mente, a Grugliasco, (dove lavorò Luisa Levi, prima donna italiana a laurearsi in Medicina e Psichiatria), tra il 1931 e il 1934 sorsero otto ville Regina Margherita per i pazienti più abbienti e, infine, nel 1966, Villa Rosa, residenza dedicata alle pazienti anziane tranquille. Tuttavia ciò che è lontano dagli occhi rimane anche lontano dal cuore, gli alienati erano comunque spettri di un altro mondo, nulla avevano da spartire con la quotidiana vita della brava gente non-matta, fino a quando la televisione non costrinse tutti a guardare: il 3 gennaio 1961 andò in onda “ I Giardini di Abele”, un servizio sul manicomio di Gorizia, a cura di Sergio Zavoli, su TV7, subito dopo il Carosello. Ora non c’erano più scuse per non vergognarsi. I protagonisti dell’inizio della fine degli ospedali psichiatrici, (chiamati così dal 1929), furono gli studenti torinesi di Architettura e di Lettere, sotto la coraggiosa guida di Franco Basaglia, brillante psichiatra veneziano, che proprio nel piccolo manicomio di Gorizia iniziò la sua rivoluzione. Il 13 maggio 1978 il Parlamento approvò la Legge 180, nota come Legge Basaglia, che impose la chiusura degli ospedali psichiatrici in cui erano state rinchiuse migliaia di persone in condizioni disumane. Successe quattro giorni dopo il ritrovamento del corpo del Presidente Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse e forse proprio per questo tale provvedimento, così rivoluzionario, passò inosservato. O forse perché ci sono delle cose che si fatica ad accettare, ci sono colpe difficili da farsi perdonare, alcuni sguardi che è impossibile sostenere. Caetano Veloso cantava “ da vicino nessuno è normale”, ma solo un matto potrebbe lasciarsi avvicinare così tanto da farsi scoprire per come è veramente.
L’8 settembre del 1852 nasce il fin troppo celebre manicomio di Collegno, giorno in cui ottanta “maniaci maschi”, provenienti da via Giulio, furono trasferiti in una parte della vecchia Certosa Reale di Collegno. I nuovi ospiti risultarono un po’ troppo chiassosi per l’antico ordine monastico che viveva lì, volontariamente silenzioso e lontano dal mondo esterno, e così la convivenza finì nel 1855, anno in cui ufficialmente la Certosa di Collegno, con tutti i terreni annessi, entrò a far parte del patrimonio del Regio Manicomio. Le candide mura tennero al sicuro gli scrupoli di coscienza della gente comune fino al 4 giugno del 1998, quando l’ultimo ospite della struttura fu costretto ad andarsene. Dal punto di vista giuridico, la prima legge organica che regolamentò la materia fu la Legge 36, “Disposizione sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati”, relatore Giovanni Giolitti, approvata dal Parlamento italiano nel 1904. In questo modo la società si proteggeva dal “matto” e consentiva a chiunque di individuare un individuo “pericoloso a sé o agli altri” e chiederne l’internamento in manicomio dietro l’invio al Pretore di un certificato medico e di un atto di notorietà “nell’interesse degli infermi e della società”. Il numero dei ricoverati nei manicomi triplicò. La triste vicenda dello studio e della cura della follia continua, si complica e diventa più affollata. Con l’aumentare dei ricoverati nacquero altre strutture, nel 1913 il Ricovero di Savonera, nel 1931 l’Istituto interprovinciale Vittorio Emanuele III per infermi di mente, a Grugliasco, (dove lavorò Luisa Levi, prima donna italiana a laurearsi in Medicina e Psichiatria), tra il 1931 e il 1934 sorsero otto ville Regina Margherita per i pazienti più abbienti e, infine, nel 1966, Villa Rosa, residenza dedicata alle pazienti anziane tranquille. Tuttavia ciò che è lontano dagli occhi rimane anche lontano dal cuore, gli alienati erano comunque spettri di un altro mondo, nulla avevano da spartire con la quotidiana vita della brava gente non-matta, fino a quando la televisione non costrinse tutti a guardare: il 3 gennaio 1961 andò in onda “ I Giardini di Abele”, un servizio sul manicomio di Gorizia, a cura di Sergio Zavoli, su TV7, subito dopo il Carosello. Ora non c’erano più scuse per non vergognarsi. I protagonisti dell’inizio della fine degli ospedali psichiatrici, (chiamati così dal 1929), furono gli studenti torinesi di Architettura e di Lettere, sotto la coraggiosa guida di Franco Basaglia, brillante psichiatra veneziano, che proprio nel piccolo manicomio di Gorizia iniziò la sua rivoluzione. Il 13 maggio 1978 il Parlamento approvò la Legge 180, nota come Legge Basaglia, che impose la chiusura degli ospedali psichiatrici in cui erano state rinchiuse migliaia di persone in condizioni disumane. Successe quattro giorni dopo il ritrovamento del corpo del Presidente Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse e forse proprio per questo tale provvedimento, così rivoluzionario, passò inosservato. O forse perché ci sono delle cose che si fatica ad accettare, ci sono colpe difficili da farsi perdonare, alcuni sguardi che è impossibile sostenere. Caetano Veloso cantava “ da vicino nessuno è normale”, ma solo un matto potrebbe lasciarsi avvicinare così tanto da farsi scoprire per come è veramente.



 Situata nel giardino Lamarmora, all’angolo tra via Bertola e via Stampatori, si innalza una massiccia struttura lapidea di forma quadrangolare. Nella parte frontale un rilievo bronzeo raffigura un manipolo di bersaglieri che muove compatto all’assalto, animato e guidato dall’allegoria alata della Patria vittoriosa. Dalla rigida struttura di pietra sporgono i corpi dei militari che, macabri e scavati, contemplano e quasi scavalcano un compagno morente completamente nudo.
Situata nel giardino Lamarmora, all’angolo tra via Bertola e via Stampatori, si innalza una massiccia struttura lapidea di forma quadrangolare. Nella parte frontale un rilievo bronzeo raffigura un manipolo di bersaglieri che muove compatto all’assalto, animato e guidato dall’allegoria alata della Patria vittoriosa. Dalla rigida struttura di pietra sporgono i corpi dei militari che, macabri e scavati, contemplano e quasi scavalcano un compagno morente completamente nudo.






 Una ricetta insolita un dolce a base di zucchine, vero? Il risultato credetemi vi stupira’
Una ricetta insolita un dolce a base di zucchine, vero? Il risultato credetemi vi stupira’