 Fu un intellettuale libero, colto, equilibrato. Più scozzese che italiano
Fu un intellettuale libero, colto, equilibrato. Più scozzese che italiano
Di Pier Franco Quaglieni
.
A dieci anni dalla morte di Alberto Ronchey, voglio ricordare l’amico e il maestro. Il suo giornalismo che non ha fatto scuola perché era troppo alto ed era irripetibile, merita di essere ricordato soprattutto oggi di fronte ai giornalistini e anche ai direttorini che si dedicano più alla Tv che ai giornali.
Anche il saggista Ronchey non è invecchiato ed è diventato un classico perché seppe guardare lontano anche nell’analisi lucidissima del presente e nella ricostruzione rigorosa del passato. E’ stato una delle più alte intelligenze che io abbia frequentato nella mia vita. Vorrei ricordarlo, tentando di delinearne la poliedrica figura in cui manifestò sempre il suo originario rigore scozzese .Era nato a Roma nel 1926,ma l’ambiente romano gli fu sempre estraneo. Era uno che aveva viaggiato moltissimo ed era vissuto molto all’estero: uno dei pochi italiani davvero cosmopoliti che guardavano alla politica con occhi diversi rispetto al provincialismo ideologizzante nostrano. Parto da un ricordo del 1968,propedeutico al nostro incontro torinese dell’anno successivo e che ne costituisce la premessa.
Ha scritto Gabriella Poli che fu l’unica donna a capo della Cronaca del quotidiano “La Stampa”:
Ricordo quella sera primaverile del ’68 come se fosse ieri. Palazzo Campana era chiuso, altre facoltà occupate. Per via Roma stava passando uno dei soliti cortei che quasi ogni giorno a quell’ora irrompevano nelle strade del centro […]. Davanti a me, una voce appena un po’ più alta di tono per vincere il fracasso e le urla, un giovanissimo professore parlava di primato della ragione e della cultura, parlava di Pannunzio…
Quel giovanissimo professore ero io.In effetti non ero ancora professore,ma Gabriella mi volle promuovere sul campo forse perché ero tanto lontano dai contestatori cappelloni e scravattati. Di fondamentale importanza fu poi il rapporto con Ferruccio Borio ,il mitico capo cronista del giornale,con cui nacque un’amicizia inossidabile nel tempo. Gabriella scrisse una davvero bellissima testimonianza di quel primo incontro voluto da Giulio De Benedetti, ma il momento decisivo fu nel 1969 con il nuovo direttore de “La Stampa” Alberto Ronchey che aveva collaborato al “Mondo” ed era stato amico di Pannunzio. All’incontro partecipò anche Carlo Casalegno, vicedirettore di Ronchey destinato a diventare un altro grande amico della mia vita.Mi era già capitato di incontrarlo di sfuggita a Roma a casa Carandini in via XXIV Maggio, ma al suo arrivo a Torino chiesi un appuntamento alla “Stampa” come feci con molti direttori che lo seguirono. Mi capitò di non avere rapporti solo con Ezio Mauro e Carlo Rossella.
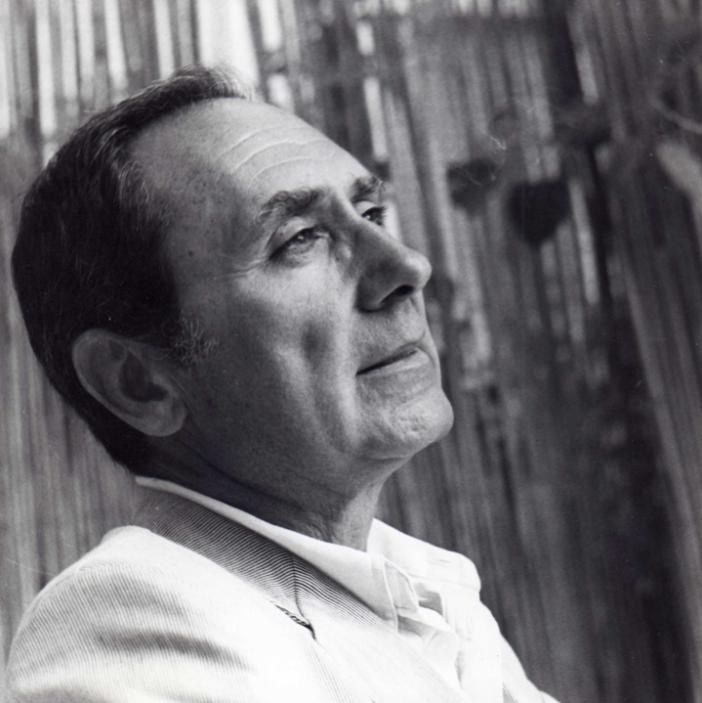 Mi ricevette la sera stessa, si compiacque per l’idea di ricordare Pannunzio a Torino e si dichiarò disponibile ad aiutarci. Finché fu direttore, volle che gli facessi recapitare direttamente i comunicati stampa relativi alle attività. Con Ronchey ci si vedeva anche in piazza San Carlo dove abitava e qualche domenica al “Cambio” dove amava andare a pranzare.Apprezzava il vecchio ristorante di Cavour e del Risorgimento ,tanto diverso da quello attuale.Specie la domenica ,c’era un clima vellutato che ci faceva immergere nell’’800,malgrado fossimo immersi nei frenetici e terribili Anni ’70. In quelle due salette tutti parlavano sottovoce quasi fossimo in un museo anziché in un ristorante. Ronchey è stato sicuramente uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento. Come direttore de “La Stampa”, succedendo a Giulio De Benedetti che governò il giornale per un ventennio, seppe modernizzare il quotidiano, facendone uno dei più autorevoli anche all’estero. Anche la stessa grafica venne modificata attraverso un’impaginazione piacevole e rigorosa insieme.
Mi ricevette la sera stessa, si compiacque per l’idea di ricordare Pannunzio a Torino e si dichiarò disponibile ad aiutarci. Finché fu direttore, volle che gli facessi recapitare direttamente i comunicati stampa relativi alle attività. Con Ronchey ci si vedeva anche in piazza San Carlo dove abitava e qualche domenica al “Cambio” dove amava andare a pranzare.Apprezzava il vecchio ristorante di Cavour e del Risorgimento ,tanto diverso da quello attuale.Specie la domenica ,c’era un clima vellutato che ci faceva immergere nell’’800,malgrado fossimo immersi nei frenetici e terribili Anni ’70. In quelle due salette tutti parlavano sottovoce quasi fossimo in un museo anziché in un ristorante. Ronchey è stato sicuramente uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento. Come direttore de “La Stampa”, succedendo a Giulio De Benedetti che governò il giornale per un ventennio, seppe modernizzare il quotidiano, facendone uno dei più autorevoli anche all’estero. Anche la stessa grafica venne modificata attraverso un’impaginazione piacevole e rigorosa insieme.
Diceva di aver iniziato a scrivere sui giornali clandestini della Resistenza, per poi fare il cronista, il redattore capo, il corrispondente, l’inviato, il direttore. Fece esperienza alla “Voce repubblicana”, un giornale assai poco letto, organo del Pri, fucina di giornalisti destinati a diventare famosi, da Stefano Folli a Maurizio Molinari. Sicuramente in Ronchey quell’esperienza non lasciò traccia significativa perché il suo modo di intendere il giornalismo non fu mai di parte, ma sempre distaccato e spassionato, quasi maniacale per l’ordine, la precisione, le cifre. “Fortebraccio” lo definiva l’ing. Ronchey per la accuratissima documentazione dei suoi articoli e per il linguaggio asciutto, quasi da ingegnere. Coniò espressioni come “lottizzazione” che sono entrate nell’uso comune.Ma Ronchey fu anche autore di saggi di grande importanza; ne ricordo uno per tutti, quell’Atlante ideologico del 1973 che ci ha consentito di superare i furori delle ideologie. Una rassegna di fatti inoppugnabili, ricavati dai suoi viaggi e dalle sue vastissime letture che avrebbe dovuto far riflettere quelli che la moglie Vittoria definiva i “marxisti immaginari” in un suo libro di successo, ma non sufficientemente meditato dai docenti e dai genitori italiani.
Le fughe in avanti delle ideologie vengono in quel saggio di Ronchey smentite dai ragionamenti suffragati da prove inoppugnabili, riprendendo in chiave contemporanea il realismo del Machiavelli che egli oppose ai sogni velleitari dei nostri tempi. Quel volume venne a presentarlo nella disadorna sede di piazza Castello a Torino dov’era di casa e venne ad ascoltare Arrigo Benedetti nel primo ricordo di Pannunzio di cui Ronchey affidò la cronaca in III pagina al grande Stefano Reggiani che in una sua rubrica pubblicata sulla Cronaca de “La Stampa” ambientava spesso i suoi racconti immaginari presso la sede del Centro “Pannunzio”, dove si incontravano Cavour e il re Vittorio Emanuele. Una realtà dell’altro mondo,vista la livida indifferenza che quel giornale riserva al Centro “Pannunzio” che allora era nato da pochissimo tempo e non aveva l’importanza di oggi.

A distanza di molti decenni quel saggio di Ronchey ne rivela la statura di studioso. Ha scritto Pierluigi Battista autore del libro-conversazione con lui Fattore R: «Alberto non sbaglia mai: non una cifra fuori posto, una data inesatta un riferimento fattuale impreciso, una citazione zoppicante». Un esempio di giornalismo di altissima qualità intellettuale che tende al saggio. Non senza ragione insegnò per un certo periodo Sociologia a Ca’ Foscari di Venezia, indotto anche dal suo amore per quella città. Una volta o due ci incontrammo anche da “Altanella” alla Giudecca ,la mitica,semplice e pur affascinante trattoria della famiglia Stradella,dove amava andare anche Gabriele d’Annunzio. Nel 1976 fu tra i promotori di una lista laica alle elezioni politiche insieme a Cesare Zappulli ed Enzo Bettiza. Negli anni in cui si stava cercando di varare il compromesso storico, Ronchey, unico dei tre che non venne eletto, volle indicare la strada dell’alleanza laica tra Pri, Pli, Psdi, malgrado la riluttanza dei loro vertici. Fu un esperimento che, se fosse stato seguito, forse avrebbe inciso sulla politica italiana; era una proposta che partiva da lontano, dal “Mondo” di Pannunzio. Il 1976 invece fu l’anno in cui comparvero in Parlamento per la prima volta i radicali di Marco Pannella.
Ronchey fu anche ministro per i Beni Culturali dal 1992 al 1994. Dopo la nomina rimase in silenzio per due mesi, poi con una mossa a sorpresa vietò piazza San Marco al galà di chiusura del Festival del Cinema di Venezia. Fino ad allora, se escludiamo Spadolini, i ministri dei Beni culturali erano, di norma, personaggi politici assai marginali, non supportati dalla cultura necessaria per esercitare il mandato loro affidatogli. Dopo Ronchey continuò la passerella di personaggi non sempre all’altezza. Nel poco tempo in cui fu ministro varò la cosiddetta Legge Ronchey concernente la gestione dei servizi aggiuntivi negli istituti d’arte e antichità dello Stato e si preoccupò di una piaga che divenne sempre più grave: le scritte e i disegni sui muri anche dei palazzi storici. Cercò in tutti i modi di sensibilizzare al problema che dopo di lui non solo rimase irrisolto, ma assunse dimensioni non più controllabili e non più controllate. Si preoccupò del problema del personale dei musei e dei privilegi incomprensibili che ne regolano il lavoro. Volle incentivare un uso più ampio e mirato dei volontari nei musei e mi chiese dell’esperienza fatta dal Centro “Pannunzio” nel 1975 quando promosse la mostra dei disegni di Leonardo a Torino. Vide i pericoli insiti negli sponsor privati, dicendo che «i privati,com’è normale, tendono ad investire denaro solo su grandi opere che danno un grande ritorno di immagine». Si interessò delle istituzioni culturali, anche quelle che avevano scelto di restare associazioni non riconosciute, volendo mantenere totale la propria autonomia. Preciso che al Ministro Ronchey il Centro “Pannunzio” non chiese mai neppure un quattrino.
Anche nell’esercizio delle sue funzioni di ministro ebbe una capacità di vedere i problemi in una dimensione internazionale come seppe fare nel giornalismo e nella saggistica. Nel 1997 gli venne assegnato il Premio “Pannunzio”. In quell’occasione accadde un episodio spiacevole. Prima che Ronchey ricevesse il Premio, il Gabibbo di “Striscia la notizia” interruppe la manifestazione chiedendogli pubblicamente ragione del fatto che, come presidente della Rizzoli, stesse per chiudere “Il Mondo” un giornale economico finanziario che solo formalmente riprendeva la testata di Pannunzio. Il Gabibbo chiese a Ronchey se non si sentisse imbarazzato nel ricevere il Premio intitolato a chi aveva fondato il giornale che lui intendeva chiudere. Con calma assoluta smontò ogni accusa, dimostrando l’infondatezza della tesi e rassicurando comunque che non avrebbe chiuso il settimanale. E così fu. Morì il 5 marzo 2010, lo stesso giorno in cui Pannunzio era nato cent’anni prima. C’era la solenne presentazione del francobollo di Poste italiane dedicato a Pannunzio in occasione del centenario e non mi fu possibile partecipare ai suoi funerali. Egli è stato uno di quei maestri che non si possono dimenticare: la «moralità delle sue opere crocianamente parlano e continuano a parlare per lui». Cito volutamente le parole da lui usate nel ricordare Pannunzio su “La Stampa” quando nel 1968 il giornalista morì.Quelle parole valgono più che mai oggi ,dopo dieci anni. Intellettuali colti ,equilibrati, liberi come lui in Italia mancano totalmente e il vuoto che ha lasciato resta davvero incolmabile. Non poter contare più sulle sue opinioni autorevoli e spassionate ci rende tutti più poveri.




 Marzo leva la mano sinistra: accenna un gesto di saluto. Come la primavera, attesa da tutti a marzo, arriva, sicura di sé, tra persone che stanno aspettando il suo ritorno. Come sapete, per questa uscita sulla Fontana dei Mesi di Torino, la rubrica dedicata ad analizzare le dodici statue allegorie dei mesi a fattezze femminili che compongono la corona della Fontana al parco del Valentino, più belle che mai dopo la fine dei lavori di restauro del marzo scorso (2019), tratteremo del mese di marzo
Marzo leva la mano sinistra: accenna un gesto di saluto. Come la primavera, attesa da tutti a marzo, arriva, sicura di sé, tra persone che stanno aspettando il suo ritorno. Come sapete, per questa uscita sulla Fontana dei Mesi di Torino, la rubrica dedicata ad analizzare le dodici statue allegorie dei mesi a fattezze femminili che compongono la corona della Fontana al parco del Valentino, più belle che mai dopo la fine dei lavori di restauro del marzo scorso (2019), tratteremo del mese di marzo



 Prende il via sotto il segno di Giambattista Bodoni nel giorno dei sui 280 anni la collaborazione tra le città di Saluzzo e di Parma siglato nel 2019 da un protocollo di che guarda agli eventi dell’anno in cui la città emiliana è Capitale italiana della cultura.
Prende il via sotto il segno di Giambattista Bodoni nel giorno dei sui 280 anni la collaborazione tra le città di Saluzzo e di Parma siglato nel 2019 da un protocollo di che guarda agli eventi dell’anno in cui la città emiliana è Capitale italiana della cultura.

 mie ultime volontà come di seguito espresse…).
mie ultime volontà come di seguito espresse…).  Domodossola a Briga, si fregiava di essere la più lunga galleria ferroviaria del mondo. D’indole ribelle, era cresciuta in una famiglia di fede repubblicana. Il padre era stato anche segretario, in gioventù, del più antico partito politico italiano in una località limitrofa, Talamello. Quel nome e il simbolo della foglia d’edera, in Romagna, spiccavano fieramente su fiammanti bandiere rosse e gli aderenti cantavano feroci canzoni contro i Savoia e tutte le teste coronate. La giovane Lucrezia, cresciuta con il mito dei “tre Giuseppe” (Mazzini, Garibaldi e Verdi) stravedeva per il padre che, al posto delle favole, le leggeva brani della Costituzione della Repubblica romana, che Aurelio Saffi , romagnolo purosangue, aveva contributo a scrivere con gli altri due membri del “triumvirato”, Armellini e Mazzini, dopo aver sottratto il potere al Pontefice, al tempo Pio IX. Papà Dolcini, rimasto vedovo, crebbe la sua unica figlia con amore, mettendola in guardia sulle fatiche della vita. Per rappresentarle meglio, usava un’immagine piuttosto forte, presa in prestito dal poeta Olindo Guerrini, in arte “Stecchetti”, anch’esso romagnolo: “La vita l’è coma la schèla de puler: cùrta, in salìda e pìna ad merda” (la vita è come la scala del pollaio: corta in salita e piena di sterco). Così, lavorando sodo, con il magro guadagno riuscì anche a
Domodossola a Briga, si fregiava di essere la più lunga galleria ferroviaria del mondo. D’indole ribelle, era cresciuta in una famiglia di fede repubblicana. Il padre era stato anche segretario, in gioventù, del più antico partito politico italiano in una località limitrofa, Talamello. Quel nome e il simbolo della foglia d’edera, in Romagna, spiccavano fieramente su fiammanti bandiere rosse e gli aderenti cantavano feroci canzoni contro i Savoia e tutte le teste coronate. La giovane Lucrezia, cresciuta con il mito dei “tre Giuseppe” (Mazzini, Garibaldi e Verdi) stravedeva per il padre che, al posto delle favole, le leggeva brani della Costituzione della Repubblica romana, che Aurelio Saffi , romagnolo purosangue, aveva contributo a scrivere con gli altri due membri del “triumvirato”, Armellini e Mazzini, dopo aver sottratto il potere al Pontefice, al tempo Pio IX. Papà Dolcini, rimasto vedovo, crebbe la sua unica figlia con amore, mettendola in guardia sulle fatiche della vita. Per rappresentarle meglio, usava un’immagine piuttosto forte, presa in prestito dal poeta Olindo Guerrini, in arte “Stecchetti”, anch’esso romagnolo: “La vita l’è coma la schèla de puler: cùrta, in salìda e pìna ad merda” (la vita è come la scala del pollaio: corta in salita e piena di sterco). Così, lavorando sodo, con il magro guadagno riuscì anche a  far studiare la figlia e Lucrezia, tra un sacrificio e l’altro, si diplomò maestra e insegnò a leggere e scrivere nella scuola elementare di uno dei più popolosi rioni di Domodossola. Lo fece riponendo nel suo lavoro la stessa passione con cui, alla sera, partecipava agli incontri e alle iniziative promosse dal sindacato e dai partiti progressisti. Se c’era da predisporre un manifesto pubblico o organizzare una serata di solidarietà con le famiglie degli operai in sciopero di questa o di quell’altra fabbrica, la “maestra Lucrezia” non si tirava mai indietro, offrendo impegno e tempo senza nulla pretendere in cambio. Per questo era benvoluta e stimata in tutta la valle. E la notizia del suo decesso era stata accolta con tristezza e dolore. Chi poteva porgerle l’ultimo saluto? Carletto Barelli ebbe un’idea: “si potrebbe chiedere a Germinale Festelli, il maremmano. Che ne dite? ”. Convennero tutti che l’idea era ottima e venne incaricato Libero Fusini, che lavorava con Germinale all’acciaieria della “Pietro Maria Ceretti“.
far studiare la figlia e Lucrezia, tra un sacrificio e l’altro, si diplomò maestra e insegnò a leggere e scrivere nella scuola elementare di uno dei più popolosi rioni di Domodossola. Lo fece riponendo nel suo lavoro la stessa passione con cui, alla sera, partecipava agli incontri e alle iniziative promosse dal sindacato e dai partiti progressisti. Se c’era da predisporre un manifesto pubblico o organizzare una serata di solidarietà con le famiglie degli operai in sciopero di questa o di quell’altra fabbrica, la “maestra Lucrezia” non si tirava mai indietro, offrendo impegno e tempo senza nulla pretendere in cambio. Per questo era benvoluta e stimata in tutta la valle. E la notizia del suo decesso era stata accolta con tristezza e dolore. Chi poteva porgerle l’ultimo saluto? Carletto Barelli ebbe un’idea: “si potrebbe chiedere a Germinale Festelli, il maremmano. Che ne dite? ”. Convennero tutti che l’idea era ottima e venne incaricato Libero Fusini, che lavorava con Germinale all’acciaieria della “Pietro Maria Ceretti“.  aveva bisogno, si faceva in quattro per dargli l’aiuto necessario ma se qualcuno gli faceva saltare la mosca al naso erano guai e dolori. “Quando Germinale diventa brusco è come il temporale che si scatena in agosto”, dicevano in fabbrica, alludendo ai fulmini e alle saette che accompagnavano le sfuriate del “toscanaccio” quando aveva la luna storta. Il Festelli, livornese di Cecina, saputo della morte di Lucrezia, sbottò con un solenne: “Maremma maiala! Che triste notizia mi date! L’era una donna decisa come l’omo. C’aveva dù ‘oglioni!”. Sinceramente dispiaciuto, non esitò a dare l’assenso alla richiesta che Libero gli sottopose a nome delle sezioni comunista e socialista, della Fiom e della Camera del Lavoro, oltre che di alcuni dei vecchi repubblicani che erano rimasti fedeli alle loro origini. Il funerale si sarebbe svolto due giorni dopo, partendo dall’abitazione di Lucrezia, alla Noga, di fianco all’edificio seicentesco
aveva bisogno, si faceva in quattro per dargli l’aiuto necessario ma se qualcuno gli faceva saltare la mosca al naso erano guai e dolori. “Quando Germinale diventa brusco è come il temporale che si scatena in agosto”, dicevano in fabbrica, alludendo ai fulmini e alle saette che accompagnavano le sfuriate del “toscanaccio” quando aveva la luna storta. Il Festelli, livornese di Cecina, saputo della morte di Lucrezia, sbottò con un solenne: “Maremma maiala! Che triste notizia mi date! L’era una donna decisa come l’omo. C’aveva dù ‘oglioni!”. Sinceramente dispiaciuto, non esitò a dare l’assenso alla richiesta che Libero gli sottopose a nome delle sezioni comunista e socialista, della Fiom e della Camera del Lavoro, oltre che di alcuni dei vecchi repubblicani che erano rimasti fedeli alle loro origini. Il funerale si sarebbe svolto due giorni dopo, partendo dall’abitazione di Lucrezia, alla Noga, di fianco all’edificio seicentesco  della vecchia parrocchiale, dedicata alla Vergine del Rosario. Il corteo, prima di raggiungere il cimitero, avrebbe fatto una sosta in piazza Mercato dove avrebbero preso la parola Carletto Barelli e , soprattutto, Germinale Festelli, l’oratore ufficiale. Il cecinese preparò con cura il discorso, deciso a non farsi prendere la mano dall’ardore della passione che l’avrebbe, senza alcun dubbio, portato all’esagerazione. Scrivendo, cancellando, aggiungendo arrivò a quella che, per lui, era la perfezione possibile: un’orazione civile che si proponeva di omaggiare la memoria di Lucrezia, toccando le corde dei sentimenti più veri. Provò più volte il discorso davanti allo specchio, calcolando con l’orologio quanto tempo gli era necessario per leggere quel testo senza andar troppo piano, strascicando le parole, e neppure troppo veloce, con il rischio di mangiarsele. Cronometro ventitre minuti esatti. Né troppo, né troppo poco. Sì, poteva andare.
della vecchia parrocchiale, dedicata alla Vergine del Rosario. Il corteo, prima di raggiungere il cimitero, avrebbe fatto una sosta in piazza Mercato dove avrebbero preso la parola Carletto Barelli e , soprattutto, Germinale Festelli, l’oratore ufficiale. Il cecinese preparò con cura il discorso, deciso a non farsi prendere la mano dall’ardore della passione che l’avrebbe, senza alcun dubbio, portato all’esagerazione. Scrivendo, cancellando, aggiungendo arrivò a quella che, per lui, era la perfezione possibile: un’orazione civile che si proponeva di omaggiare la memoria di Lucrezia, toccando le corde dei sentimenti più veri. Provò più volte il discorso davanti allo specchio, calcolando con l’orologio quanto tempo gli era necessario per leggere quel testo senza andar troppo piano, strascicando le parole, e neppure troppo veloce, con il rischio di mangiarsele. Cronometro ventitre minuti esatti. Né troppo, né troppo poco. Sì, poteva andare.  bandiere rosse, Germinale avvertiva su di sé tutto il peso della responsabilità. In piazza, dopo il telegrafico intervento del segretario della Camera del Lavoro, il Festelli s’avvicinò al microfono. Con un colpo di tosse si schiarì la voce e alzando lo sguardo sulla folla, appoggiò la mano sinistra sul feretro coperto da una bandiera sulla quale spiccava il simbolo dell’edera e fece per prendere i fogli dalla tasca. In quel momento, vuoi per l’emozione, vuoi perché non aveva toccato cibo dal giorno prima, gli si annebbiò la vista e – per un istante – si sentì mancare la terra sotto i piedi. Rendendosi conto che non era in condizione di leggere, prese coraggio e pronunciò, con voce di tuono, una delle più brevi orazioni funebri della storia: “ Oh, Lucrezia. Noi ci s’ha fatto le lotte insieme e ora siamo più soli. L’è ‘nda’ via una compagna che valeva, maremma maiala ‘mpestaha ‘hane. E mi domando: oh, Lucrezia, perché sei morta se cinque minuti prima di morire, eri così piena di vita ?”. Dopo qualche attimo di smarrimento iniziarono i primi applausi e, in breve, l’intera piazza tributò l’ultimo, caloroso addio alla “maestra Lucrezia”, senza però trovare una risposta alla domanda di Germinale.
bandiere rosse, Germinale avvertiva su di sé tutto il peso della responsabilità. In piazza, dopo il telegrafico intervento del segretario della Camera del Lavoro, il Festelli s’avvicinò al microfono. Con un colpo di tosse si schiarì la voce e alzando lo sguardo sulla folla, appoggiò la mano sinistra sul feretro coperto da una bandiera sulla quale spiccava il simbolo dell’edera e fece per prendere i fogli dalla tasca. In quel momento, vuoi per l’emozione, vuoi perché non aveva toccato cibo dal giorno prima, gli si annebbiò la vista e – per un istante – si sentì mancare la terra sotto i piedi. Rendendosi conto che non era in condizione di leggere, prese coraggio e pronunciò, con voce di tuono, una delle più brevi orazioni funebri della storia: “ Oh, Lucrezia. Noi ci s’ha fatto le lotte insieme e ora siamo più soli. L’è ‘nda’ via una compagna che valeva, maremma maiala ‘mpestaha ‘hane. E mi domando: oh, Lucrezia, perché sei morta se cinque minuti prima di morire, eri così piena di vita ?”. Dopo qualche attimo di smarrimento iniziarono i primi applausi e, in breve, l’intera piazza tributò l’ultimo, caloroso addio alla “maestra Lucrezia”, senza però trovare una risposta alla domanda di Germinale.
 Sicuramente non era intenzione di Curto scalpellare via il nome dei Savoia da una storia che appartiene al Piemonte e che nessuno può disconoscere. Curto è infatti uno studioso che perpetua la tradizione di suo padre, nobilmente espressa al Museo Egizio, anch’esso voluto dai Savoia, e come tale si è comportato anche questa volta.
Sicuramente non era intenzione di Curto scalpellare via il nome dei Savoia da una storia che appartiene al Piemonte e che nessuno può disconoscere. Curto è infatti uno studioso che perpetua la tradizione di suo padre, nobilmente espressa al Museo Egizio, anch’esso voluto dai Savoia, e come tale si è comportato anche questa volta.
 L’intervento del gruppo Palazzetti. Nel Salone delle Guardie Svizzere a Palazzo Reale
L’intervento del gruppo Palazzetti. Nel Salone delle Guardie Svizzere a Palazzo Reale attraverso le sale del palazzo. Una dignità che, finalmente, torna a parlarci del nostro territorio e della sua ricchezza, rimettendo a vista, dopo un restauro durato tre mesi e per cui sono occorse 774 ore di lavoro, la bellezza dei marmi usati (di “musicalità di colori” parla ancora Pagella), taluni oggi scomparsi. Dieci persone all’opera, sotto la guida di Annarosa Nicola, le radici ad Aramengo, la competenza e la passione riunite in una sola famiglia ed in un gruppo vincente, un accanito lavoro di pulizia, una webcam a riprendere giorno dopo giorno le tante tappe dei risultati raggiunti, la salvaguardia di questo piccolo gioiello ma imponente e prezioso, l’alternarsi di marmi policromi e di pietre dure, una struttura nobilitata da colonne binate, dai putti di Quadri (forse un riciclo di epoca più antica) e dai busti antichi di imperatori romani (Giulio Cesare al centro, di sapore ellenistico quello a destra di chi guarda), in marmo bianco di Carrara, l’eleganza e il gusto modernamente legati alla corte da Carlo Emanuele II, sovrano mecenate pronto a riunire a Torino quelle opere antiche che andava acquistando durante i suoi viaggi a Roma.
attraverso le sale del palazzo. Una dignità che, finalmente, torna a parlarci del nostro territorio e della sua ricchezza, rimettendo a vista, dopo un restauro durato tre mesi e per cui sono occorse 774 ore di lavoro, la bellezza dei marmi usati (di “musicalità di colori” parla ancora Pagella), taluni oggi scomparsi. Dieci persone all’opera, sotto la guida di Annarosa Nicola, le radici ad Aramengo, la competenza e la passione riunite in una sola famiglia ed in un gruppo vincente, un accanito lavoro di pulizia, una webcam a riprendere giorno dopo giorno le tante tappe dei risultati raggiunti, la salvaguardia di questo piccolo gioiello ma imponente e prezioso, l’alternarsi di marmi policromi e di pietre dure, una struttura nobilitata da colonne binate, dai putti di Quadri (forse un riciclo di epoca più antica) e dai busti antichi di imperatori romani (Giulio Cesare al centro, di sapore ellenistico quello a destra di chi guarda), in marmo bianco di Carrara, l’eleganza e il gusto modernamente legati alla corte da Carlo Emanuele II, sovrano mecenate pronto a riunire a Torino quelle opere antiche che andava acquistando durante i suoi viaggi a Roma.

