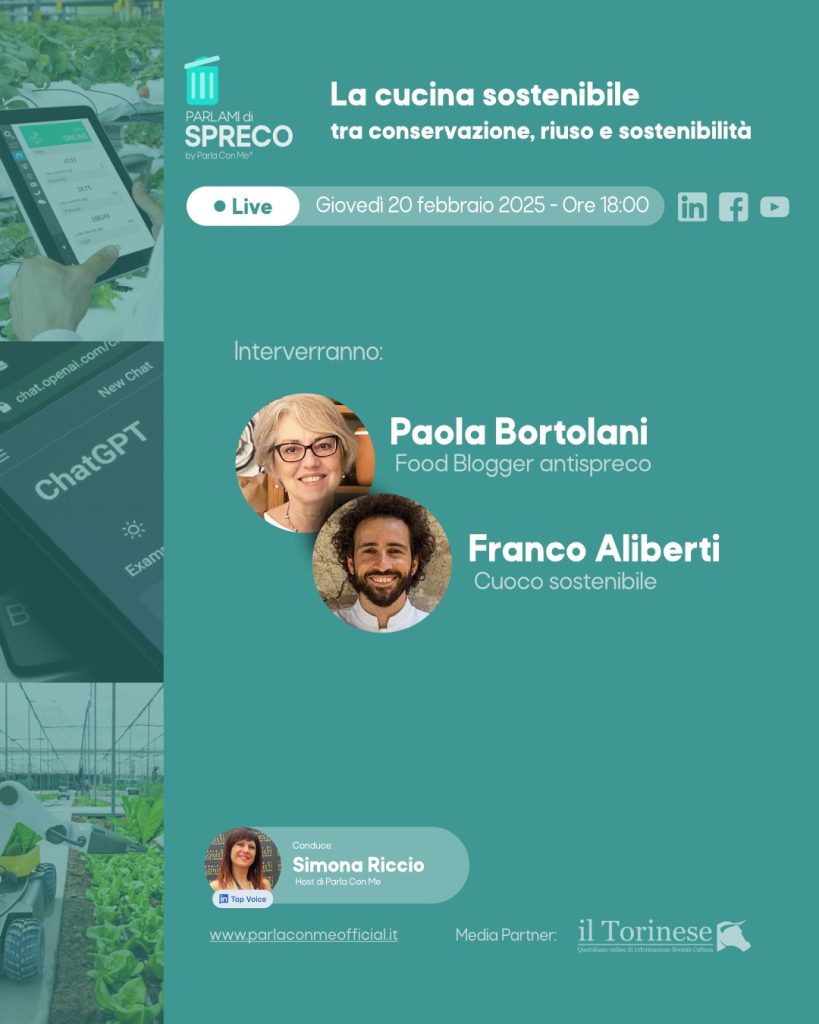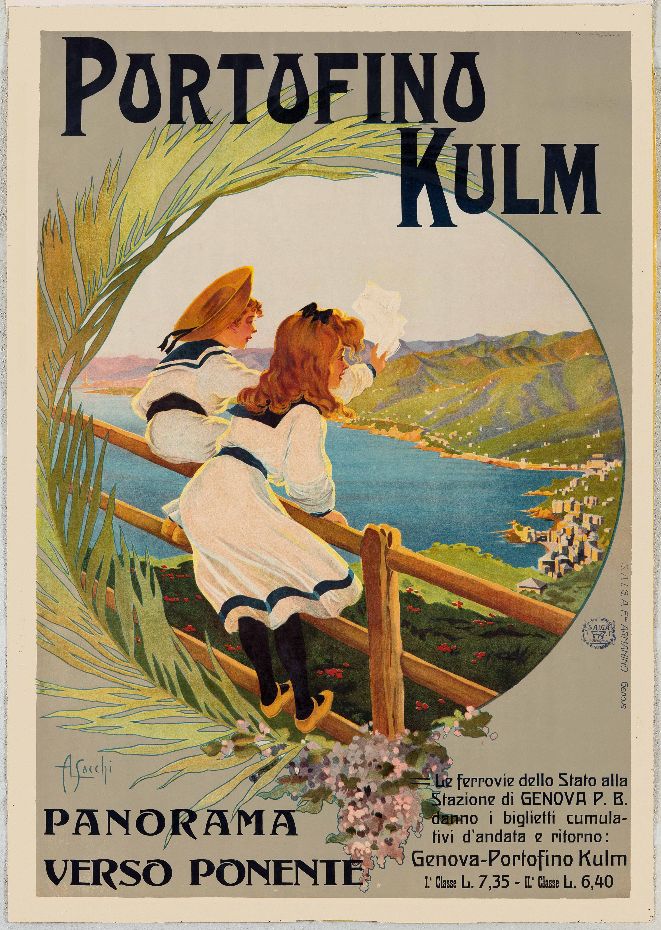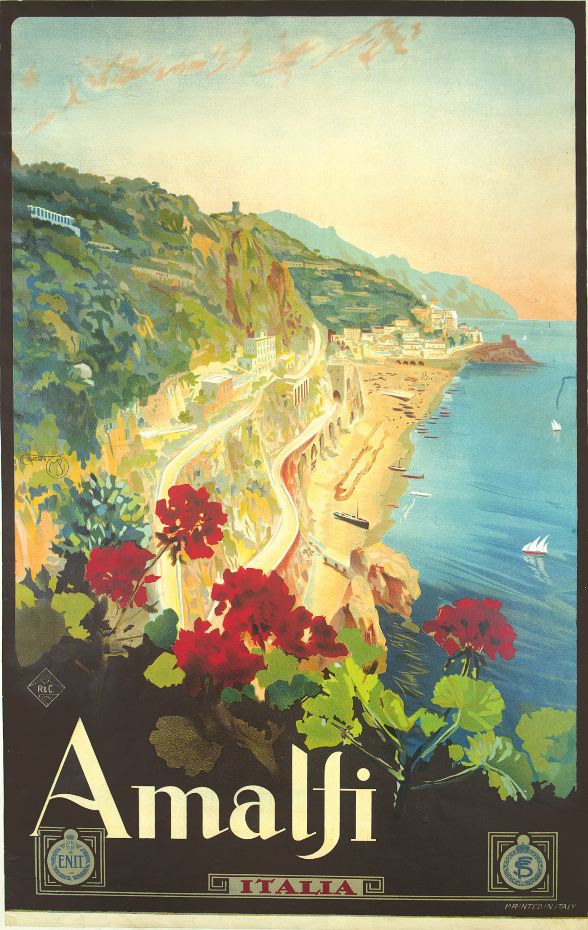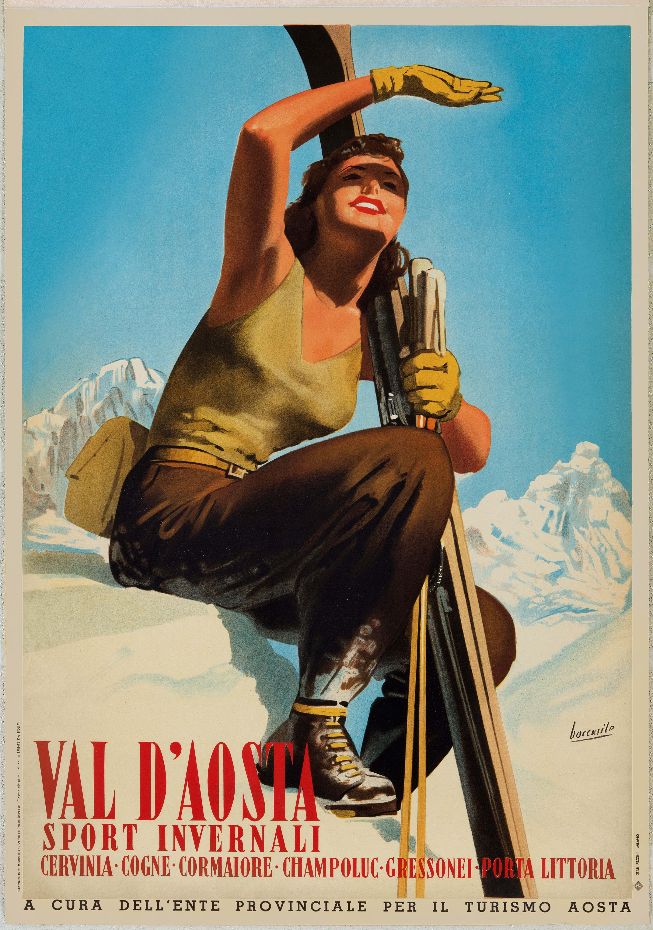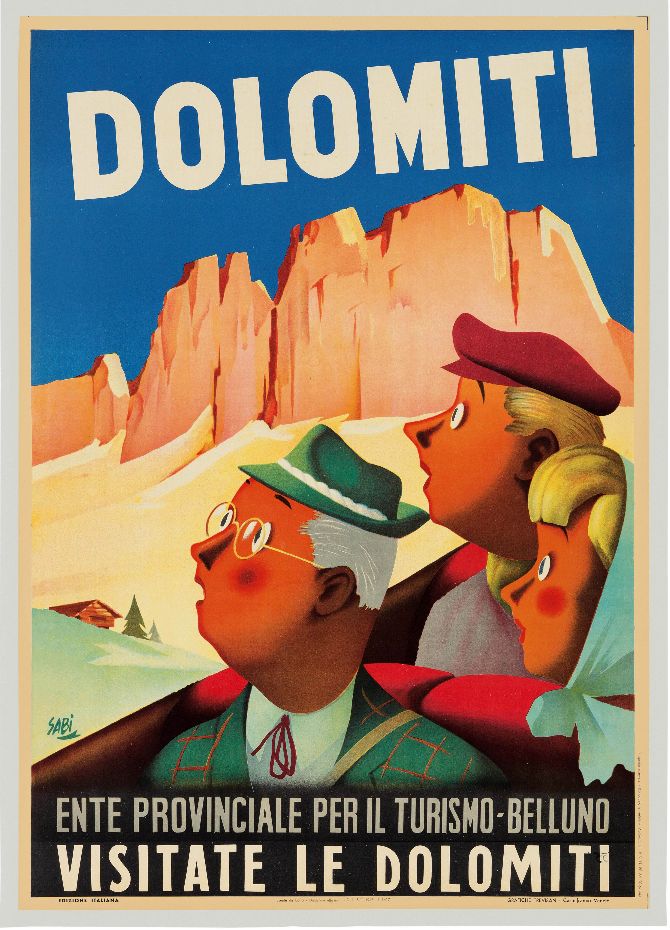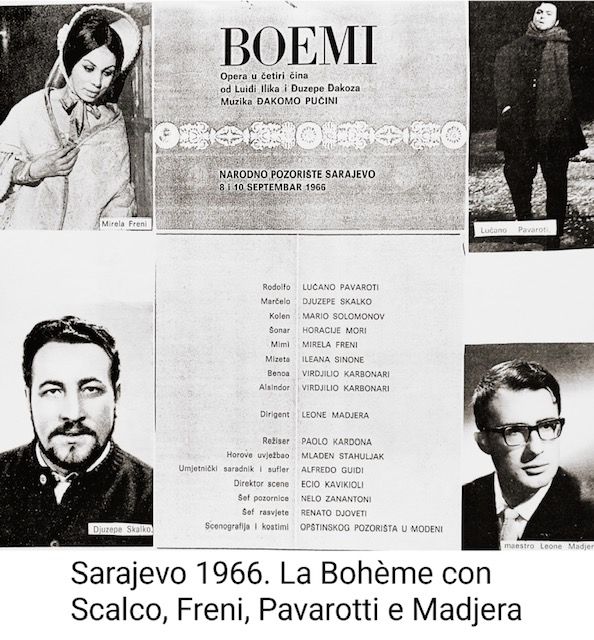Con una partecipata festa al castello di Grinzane Cavour, è stato presentato insieme al Comune il programma della X edizione di Attraverso Festival. In scena dall’11 luglio al 10 settembre prossimo tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino piemontese. Si tratta di un traguardo importante per questo progetto, nato per questa scommessa, e che oggi, 10 anni dopo, è diventato un punto di riferimento culturale per il sud del Piemonte.
È tanta la soddisfazione per il percorso costruito con costanza e passione, per la rete di Comuni e persone che ogni anno si allarga, per il pubblico affezionato che segue tappa dopo tappa e per i tanti artisti che hanno scelto Attraverso come luogo di incontro in territori autentici e profondamente umani. Guardando al futuro, la sfida è quella di mantenere intatto lo spirito originario che è quello di una manifestazione sostenibile e in ascolto, capace di crescere in sintonia con i paesi che la ospitano e valorizzarne identità, ritmi ed energie. Per questa decima edizione il programma intreccia oltre 40 appuntamenti pensati ad hoc per le specificità architettoniche e paesaggistiche dei luoghi. È u Festival che si attraversa, geograficamente e emotivamente, costruendo un dialogo tra generazioni, linguaggi e sensibilità.
Tra i tanti protagonisti Goran Bregović, con la Wedding and Funeral Band, nel parco della Zizzola, a Bra; il jazz raffinato di Paolo Fresu & Omar Sosa, a Novi Ligure e Cherasco; l’omaggio a Calvino di Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo, ad Alba; la poesia civile di Franco Arminio a Bergolo e Maurizio Lastrico con il suo monologo ironico e toccante a Saluzzo.
Nel cuore dell’astigiano, Lella Costa dà voce alla figura storica di Giovanna d’Arco, a Canelli; Arianna Porcelli Safonov porta in scena la sua satira sull’ossessione per il cibo, a Nizza Monferrato, dove sarà ospite anche Alessandro Barbero, con una delle sue amate lezioni-spettacolo. Sempre ad Asti, Pablo Trincia guiderà il pubblico in un’intensa riflessione sul potere delle storie vere, tra Nizza e Saluzzo. La provincia di Alessandria si conferma fra le più vivaci: a Serravalle Scrivia, Manuel Agnelli propone un viaggio tra parole e silenzi nella Tenuta La Bollina; a Gavi, Elio tornerà con uno spettacolo ispirato alla comicità milanese, e sarà anche protagonista a Grinzane Cavour, in una versione intima, per piano e voce. Il pensiero filosofico sarà affidato a Umberto Galimberti, a Mornese, e la narrazione teatrale a Stefano Massini, a Castellazzo Bormida. Ancora, al Forte di Gavi, sarà protagonista Wu Ming 4; Gianrico Carofiglio a Rocca Grimalda, Vera Gheno, Fabio Geda, Raffaella Romagnolo, con le loro storie, a Ovada e Gamalero, insieme a giovani voci come Edoardo Prati e Gianluca Gotto. Sul versante più comico e contemporaneo, la stand up di Turbo Paolo “Mamma di merda”; Stefano Rapone coinvolgerà un pubblico trasversale, curioso e partecipe.
Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia.
“Siamo orgogliose di essere arrivate a questa decima edizione di Attraverso Festival – affermano le direttrici del Festival Paola Farinetti e Simona Ressico – è il risultatomdinuna costruzione certosina, e soprattutto di una grande passione, di un mettersi in ascolto nei confronti delle esigenze s aspettative di ciascun Comune, pur restando fedeli alla nostra linea guida, che è quella di proporre un programma di qualità attento alle problematiche della contemporaneità. È segno di una crescita e un consolidamento costruito negli anni di un Festival che ha trovato il suo solido posto nell’estate piemontese che, pur nel suo essere atipico, con una durata che sfiora i due mesi e il coinvolgimento di molti Comuni grandi e piccoli, la proposta di generi diversi, il teatro, senza dubbio, ma anche la musica e i talk, ha trovato il suo giusto equilibrio ed è diventato un avvenimento atteso ogni anno”.
Fin dalla sua prima edizione, Attraverso porta la sua proposta culturale e artistica in paesi e città del Piemonte meridionale e, negli anni, è riuscito ad abbattere frontiere immaginarie e reali tra province, intessendo rapporti forti e duraturi con ognuno dei Comuni coinvolti, e che del Festival sono l’anima e l’ossatura, riuscendo a sviluppare senso di appartenenza e comunità nel segno della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico.
Un risultato importante con numero tondo da festeggiare è, per questa felice ricorrenza, dopo Resistenze, Parole nuove e Comunità, il tema della della decima edizione è “#Dieci”, un numero che ricorda il compleanno e che diventa inevitabilmente un momento di bilanci e rilanci.
200 km di territorio di Basso Piemonte, dalle Alpi agli Appennini, passando per le dolci colline delle Langhe, del Monferrato e del Roero, oltre 40 appuntamenti di incontri e spettacoli con un’integrazione armonica con le iniziative che già venivano programmate in queste zone, dalla Pedalata Wine & Bike tra le colline del Gavi alla Festa della Vendemmia nella tenuta di Fontanafredda di Serralunga d’Alba, a Cuneo, vera chiusura dell’estate.
“Attraverso è un Festival intenso, emozionale e originale – concludono le direttrici – di quelli che hanno l’ambizione di radicarsi al luogo in cui nascono. Un festival fatto di relazioni che durano tutto l’anno, che nasce dal territorio e non sul territorio, dal basso e non calato dall’alto, con un programma artistico originale pensato ad hoc, che cerca di unire la qualita della proposta al giusto tasso di popolarità, e si declina perfettamente ai luoghi che lo ospitano, perché accanto a noi ci sono centinaia di persone, amministratori, operatori turistici, vignaioli, volontari, associazioni locali e amanti del territorio”.
Mara Martellotta














 Il consigliere comunale Silvio Viale con la ben nota intempestività (la malattia del Papa preoccupa tanti, non solo i cattolici) fa la sua ennesima esibizione, che non meriterebbe una citazione, sul crocifisso nell’Aula del consiglio comunale. Dopo le tante provocazioni fuori luogo di Viale la presidente del Consiglio Comunale Grippo ha giustamente sospeso i lavori del consiglio, non potendosi tollerare una mina vagante che vorrebbe essere anticonformista, che perfino con i suoi abiti vuole esibire se stesso, appigliandosi ad ogni scusa. Viale smetta di dirsi radicale, Pannella ripudierebbe i suoi sistemi. Ma soprattutto sono i laici rispettosi di ogni fede che rifiutano Viale che dovrebbe in primis chiarire la sua posizione con le sue pazienti. E’ strano che l’Ordine dei medici e l’ospedale non l’abbiano cautelativamente sospeso. Per uno sguardo ad una studentessa che non ha fatto esposti, il prof. Vercellone nel silenzio codardo di tutti di fatto ha perso il diritto di insegnare.
Il consigliere comunale Silvio Viale con la ben nota intempestività (la malattia del Papa preoccupa tanti, non solo i cattolici) fa la sua ennesima esibizione, che non meriterebbe una citazione, sul crocifisso nell’Aula del consiglio comunale. Dopo le tante provocazioni fuori luogo di Viale la presidente del Consiglio Comunale Grippo ha giustamente sospeso i lavori del consiglio, non potendosi tollerare una mina vagante che vorrebbe essere anticonformista, che perfino con i suoi abiti vuole esibire se stesso, appigliandosi ad ogni scusa. Viale smetta di dirsi radicale, Pannella ripudierebbe i suoi sistemi. Ma soprattutto sono i laici rispettosi di ogni fede che rifiutano Viale che dovrebbe in primis chiarire la sua posizione con le sue pazienti. E’ strano che l’Ordine dei medici e l’ospedale non l’abbiano cautelativamente sospeso. Per uno sguardo ad una studentessa che non ha fatto esposti, il prof. Vercellone nel silenzio codardo di tutti di fatto ha perso il diritto di insegnare.