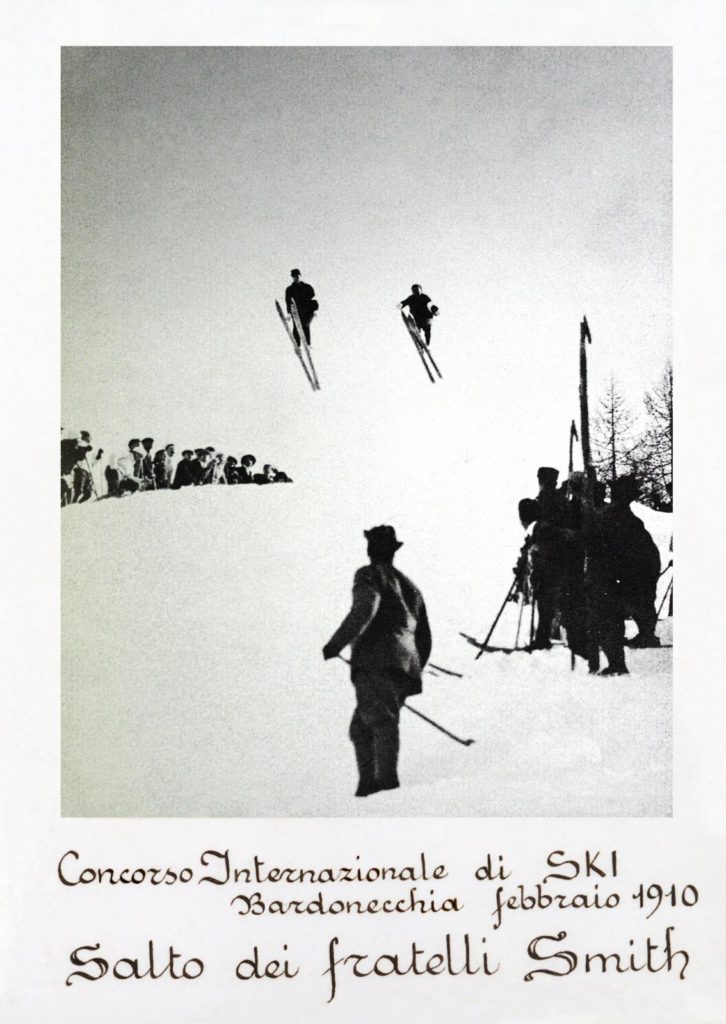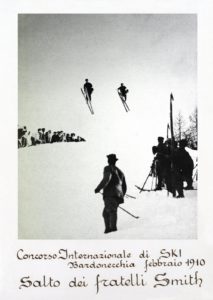Al Ristorante Sol Levante Fusion di Via Nizza 1
Informiamo che Go Wine promuove in Torino, presso il Ristorante Sol Levante Fusion di Via Nizza 1 (sollevantetorino.it), a partire da fine gennaio, un nuovo corso di degustazione base dedicato alla conoscenza e alla degustazione del vino. Il corso si sviluppa in cinque serate e avrà inizio martedì 29 gennaio: si propone di sviluppare il rapporto tra vitigno-vite-territorio, con un messaggio di carattere divulgativo che possa fornire nozioni utili anche per riconoscere e valutare le diverse tipologie di vino. Nel corso di ogni appuntamento si potranno degustare 5 tipologie di vini a seconda del tema trattato: protagonisti delle serate vini bianchi, vini rossi, grandi rossi italiani (alla presenza di un produttore) e vini da meditazione. Il costo di partecipazione è di euro 150,00 e comprende, oltre al corso con tutte le lezioni e le degustazioni, l’iscrizione all’Associazione Go Wine valevole fino al 31 dicembre 2019, 6 bicchieri da degustazione mod. Carrè ed il volume “Cantine d’Italia”.
Di seguito il programma generale del corso
–Prima serata: martedì 29 gennaio 2019 ore 20.30
INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE
–Seconda serata: martedì 5 febbraio 2019 ore 20.30
IL RAPPORTO VITIGNO–VINO–TERRITORIO; VINI BIANCHI
–Terza serata: martedì 12 febbraio 2019 ore 20.30
IL LAVORO IN VIGNA; VINI ROSSI
–Quarta serata: martedì 19 febbraio 2019 ore 20.30
IL LAVORO IN CANTINA; GRANDI ROSSI ITALIANI; INCONTRO CON UN PRODUTTORE
–Quinta serata: martedì 26 febbraio 2019 ore 20.30
IL TURISMO DEL VINO; VINI DA MEDITAZIONE
Per informazioni e iscrizioni:
Associazione Go Wine – Ufficio Corsi – tel. 0173 364631 – fax 0173 361147
ufficio.corsi@gowinet.it – www.gowinet.it


 Linguine fave e salsiccia.
Linguine fave e salsiccia.






 misteriosa sparizione di una barca a motore dalle rive del Sirio ma non c’erano prove sufficienti per dimostrare un suo coinvolgimento. Così Antonio Brodino diventò, grazie ai “meriti” acquisiti sul campo, Toni “Fuoribondo”, compiacendosi di quel suo soprannome. Lui e Marinetta si conobbero in una serata di tanghi e mazurke all’Imperial, un dancing all’aperto della riviera di Viverone. Tra musica e zanzare, birre e coregoni alla griglia, scattò la scintilla tra i due e sbocciò l’amore. Come travolti da un temporale d’estate, unirono le vite e le abitudini, trasformandosi in breve tempo in una sorta di Bonnie & Clide a cavallo tra la Serra, le risaie e i monti. Lei si specializzò in piccole truffe, lui aggiunse alle imbarcazioni anche delle motoseghe e qualche calesse. Di questi ultimi ne rubò un paio tra Torre Balfredo e San Bernardo, abbandonandoli in aperta campagna dopo aver realizzato di non poterli rivendere e nemmeno ottenere dai legittimi proprietari un seppur minimo riscatto. Fu il maresciallo Caramboli a porre fine alle imprese truffaldine dei due. Le indagini furono piuttosto lunghe e meticolose ma, grazie a una soffiata, i due furono pizzicati nei campi tra Maglione e Moncrivello dove avevano alleggerito di una mezza dozzina di oche un contadino della zona. In realtà Toni e Marinetta una possibilità di fuggire l’avevano avuta ma non si fidarono a percorrerla per colpa di uno spaventapasseri.
misteriosa sparizione di una barca a motore dalle rive del Sirio ma non c’erano prove sufficienti per dimostrare un suo coinvolgimento. Così Antonio Brodino diventò, grazie ai “meriti” acquisiti sul campo, Toni “Fuoribondo”, compiacendosi di quel suo soprannome. Lui e Marinetta si conobbero in una serata di tanghi e mazurke all’Imperial, un dancing all’aperto della riviera di Viverone. Tra musica e zanzare, birre e coregoni alla griglia, scattò la scintilla tra i due e sbocciò l’amore. Come travolti da un temporale d’estate, unirono le vite e le abitudini, trasformandosi in breve tempo in una sorta di Bonnie & Clide a cavallo tra la Serra, le risaie e i monti. Lei si specializzò in piccole truffe, lui aggiunse alle imbarcazioni anche delle motoseghe e qualche calesse. Di questi ultimi ne rubò un paio tra Torre Balfredo e San Bernardo, abbandonandoli in aperta campagna dopo aver realizzato di non poterli rivendere e nemmeno ottenere dai legittimi proprietari un seppur minimo riscatto. Fu il maresciallo Caramboli a porre fine alle imprese truffaldine dei due. Le indagini furono piuttosto lunghe e meticolose ma, grazie a una soffiata, i due furono pizzicati nei campi tra Maglione e Moncrivello dove avevano alleggerito di una mezza dozzina di oche un contadino della zona. In realtà Toni e Marinetta una possibilità di fuggire l’avevano avuta ma non si fidarono a percorrerla per colpa di uno spaventapasseri.  quello li stava squadrando con un fare tutt’altro che benevolo. Toni gli gridò: “Facci passare, brutto demonio. Siamo armati e non sai cosa ti potrà accadere. Fatti da parte!”. Ma quello niente. Muto e ostinato se ne stava lì, con le braccia larghe, pronto a ghermirli. Marinetta era ammutolita dalla paura e Toni tentò un ultima volta di far spostare l’uomo, minacciandolo: “Ti sparo! Adesso ti scarico la pistola addosso!”. Ovviamente i due non avevano nessuna arma e mai ne avevano avute, essendo sì ladri e truffatori ma del tutto incapaci di far del male al prossimo. Di fronte all’immobilità caparbia e risoluta di quel tipo che non parlava, non si muoveva e stava lì davanti a loro, fuggirono in direzione opposta finendo così tra le braccia dei carabinieri. Processati e condannati per direttissima ad una pena nemmeno troppo severa, uscirono di galera un paio d’anni dopo. Marinetta mise la testa a posto, sposò Ubaldo Sgarroni, sacrestano di San Grato, e aiutò come perpetua il vecchio Don Germano, facendosi perdonare per gli scherzi delle rane di quand’era ragazzina. Toni trovò anch’esso un lavoro. Meccanico motorista all’imbarcadero di Viverone. Così poteva occuparsi dei fuoribordo senza per questo macchiarsi la fedina penale com’era accaduto nella sua vita precedente. In cuor suo rimase fedele a Marinetta e non ebbe altre storie. Anzi, a dire il vero, conobbe una signora, rimasta vedova. Abitava in una cascina di Borgomasino. Non se ne fece niente, però. Tra i campi lì attorno c’erano diversi spaventapasseri. Troppi per Toni che preferì abbandonare i possibili affetti, evitando nuovi e spiacevoli incontri.
quello li stava squadrando con un fare tutt’altro che benevolo. Toni gli gridò: “Facci passare, brutto demonio. Siamo armati e non sai cosa ti potrà accadere. Fatti da parte!”. Ma quello niente. Muto e ostinato se ne stava lì, con le braccia larghe, pronto a ghermirli. Marinetta era ammutolita dalla paura e Toni tentò un ultima volta di far spostare l’uomo, minacciandolo: “Ti sparo! Adesso ti scarico la pistola addosso!”. Ovviamente i due non avevano nessuna arma e mai ne avevano avute, essendo sì ladri e truffatori ma del tutto incapaci di far del male al prossimo. Di fronte all’immobilità caparbia e risoluta di quel tipo che non parlava, non si muoveva e stava lì davanti a loro, fuggirono in direzione opposta finendo così tra le braccia dei carabinieri. Processati e condannati per direttissima ad una pena nemmeno troppo severa, uscirono di galera un paio d’anni dopo. Marinetta mise la testa a posto, sposò Ubaldo Sgarroni, sacrestano di San Grato, e aiutò come perpetua il vecchio Don Germano, facendosi perdonare per gli scherzi delle rane di quand’era ragazzina. Toni trovò anch’esso un lavoro. Meccanico motorista all’imbarcadero di Viverone. Così poteva occuparsi dei fuoribordo senza per questo macchiarsi la fedina penale com’era accaduto nella sua vita precedente. In cuor suo rimase fedele a Marinetta e non ebbe altre storie. Anzi, a dire il vero, conobbe una signora, rimasta vedova. Abitava in una cascina di Borgomasino. Non se ne fece niente, però. Tra i campi lì attorno c’erano diversi spaventapasseri. Troppi per Toni che preferì abbandonare i possibili affetti, evitando nuovi e spiacevoli incontri.