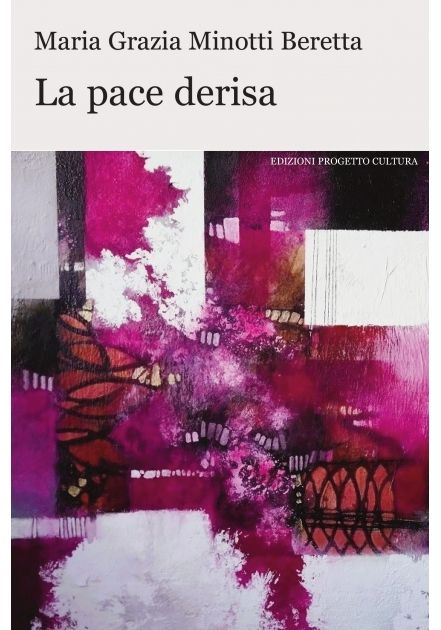Il Bastion Verde di Torino, anche chiamato “degli angeli” è un luogo dove la storia militare si fonde armoniosamente con la bellezza naturale. Situato all’interno dei Giardini Reali di Torino, è una delle ultime testimonianze di quella che fu la consistente cinta fortificata della città, oggi trasformata in un’area di svago e relax, ma che conserva ancora tutto il fascino della sua origine: 800 metri lineari di mura a pochi passi dal Palazzo Reale progettato dal geniale architetto cinquecentesco Ascanio Vitozzi. Il suo nome deriva dal fatto che Vittorio Emanuele II lo fece dipingere di verde e ricoprire di edera, in omaggio a sua moglie.

Il Bastion Verde è parte del sistema difensivo che, a partire dal XVII secolo, venne costruito Per proteggere Torino dalle invasioni. La cittadella fortificata, che comprendeva bastioni, mura e torri, si estendeva lungo le colline che sovrastano il fiume Po e rappresentava uno degli esempi più significativi della fortificazione barocca in Italia. Torino, allora capitale del Ducato di Savoia, aveva una posizione strategica e un apparato difensivo che rispondeva alle esigenze di protezione contro minacce provenienti sia da sud (dalla Francia) che da altre direzioni. Come gli altri bastioni della città, faceva parte di una serie di fortificazioni che vennero realizzate tra il 1668 e il 1700, con il progetto di Amedeo di Castellamonte, uno degli architetti più influenti dell’epoca. La struttura doveva garantire un buon punto di osservazione e difesa, ma allo stesso tempo integrarsi nel contesto urbanistico e paesaggistico che Torino stava sviluppando. Oggi, il bastione è circondato da un ampio parco verde che ne attenua la severità militare originaria, donando al sito un aspetto più accogliente e rilassante, ma senza perdere la sua forte identità storica. Con il tempo, le funzioni militari del Bastion Verde sono venute meno e l’area ha subito un processo di recupero e valorizzazione che ha permesso di restituirla alla cittadinanza come un parco pubblico ben curato, dotato di panchine, vialetti e ampie zone ombreggiate che rendono l’area perfetta per passeggiate e relax. L’elemento più interessante del parco è la sua capacità di mescolare il verde con la storia. Una delle caratteristiche più apprezzate del Bastion Verde è la sua posizione sopraelevata rispetto alla città. Dal bastione, infatti, si gode di una vista spettacolare su Torino e sulla collina torinese che si estende dalle Alpi all’orizzonte, con una prospettiva che lo rende un luogo privilegiato per osservare la città dall’alto, in particolare al tramonto, quando la luce dorata avvolge il panorama.




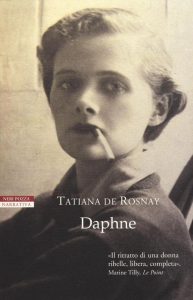 In queste oltre 400 incantevoli pagine ci si ritrova piacevolmente catapultati dentro la vita della Du Maurier; immersi in una biografia dove è tutto vero, da leggere con la stessa scorrevolezza di un accattivante romanzo.
In queste oltre 400 incantevoli pagine ci si ritrova piacevolmente catapultati dentro la vita della Du Maurier; immersi in una biografia dove è tutto vero, da leggere con la stessa scorrevolezza di un accattivante romanzo.

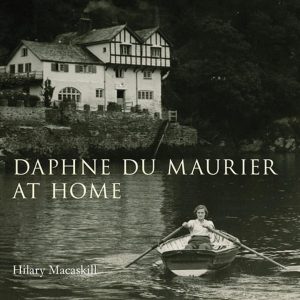 Questo splendido libro pubblicato nel 2013 in lingua inglese e corredato da un ricco apparato fotografico è pieno di informazioni sulla vita e il lavoro di Daphne Du Maurier .
Questo splendido libro pubblicato nel 2013 in lingua inglese e corredato da un ricco apparato fotografico è pieno di informazioni sulla vita e il lavoro di Daphne Du Maurier .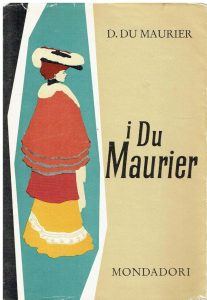 Questa è la ricostruzione accurata della storia di un secolo delle vicende della famiglia Du Maurier che Daphne ripercorre al limite tra cronaca e romanzo, storie e avventure realmente vissute dai suoi antenati trasposte dalla fantasia della scrittrice.
Questa è la ricostruzione accurata della storia di un secolo delle vicende della famiglia Du Maurier che Daphne ripercorre al limite tra cronaca e romanzo, storie e avventure realmente vissute dai suoi antenati trasposte dalla fantasia della scrittrice.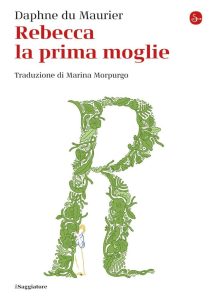 E’ un romanzo che ti afferra alla prima riga e non ti lascia andare neanche dopo l’ultima, perché racchiude magia, misteri, fascino a dismisura e ti resta nei pensieri anche dopo avere finito di leggerlo.
E’ un romanzo che ti afferra alla prima riga e non ti lascia andare neanche dopo l’ultima, perché racchiude magia, misteri, fascino a dismisura e ti resta nei pensieri anche dopo avere finito di leggerlo.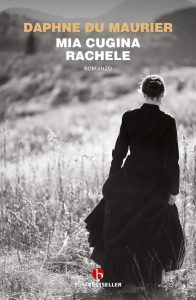 Il dubbio e l’ambiguità serpeggiano lungo le pagine del romanzo e fanno da sfondo a questo sottile noir che la Du Maurier ambientò in Cornovaglia a metà Ottocento.
Il dubbio e l’ambiguità serpeggiano lungo le pagine del romanzo e fanno da sfondo a questo sottile noir che la Du Maurier ambientò in Cornovaglia a metà Ottocento. 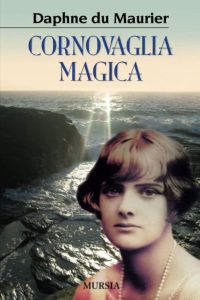 In queste splendide pagine c’è il cuore del legame tra la Du Maurier e la Cornovaglia, terra che lei amò incondizionatamente e comprese a fondo, riuscendo a raccontarla in modo coinvolgente.
In queste splendide pagine c’è il cuore del legame tra la Du Maurier e la Cornovaglia, terra che lei amò incondizionatamente e comprese a fondo, riuscendo a raccontarla in modo coinvolgente.
 È un momento qualsiasi, è l’esaltazione del quotidiano che cela l’essenza delle cose. Nella poesia citata l’eleganza torinese è presa alla sprovvista, colta in flagrante mentre si tramuta in semplice golosità. Ma Gozzano sfalsa i piani e costringe il lettore a seguirlo nel suo ironizzare continuo, quasi non prendendo mai niente sul serio, ma facendo riflettere sempre sulla verità di ciò che asserisce. Se con “Le golose” Guido si concentra su una specifica situazione, con la poesia “Torino”, dimostra apertamente tutto il suo amore per il luogo in cui è venuto alla luce.
È un momento qualsiasi, è l’esaltazione del quotidiano che cela l’essenza delle cose. Nella poesia citata l’eleganza torinese è presa alla sprovvista, colta in flagrante mentre si tramuta in semplice golosità. Ma Gozzano sfalsa i piani e costringe il lettore a seguirlo nel suo ironizzare continuo, quasi non prendendo mai niente sul serio, ma facendo riflettere sempre sulla verità di ciò che asserisce. Se con “Le golose” Guido si concentra su una specifica situazione, con la poesia “Torino”, dimostra apertamente tutto il suo amore per il luogo in cui è venuto alla luce. Ma torniamo a Torino, la sua città natale, la amata Torino, che è sempre nei suoi pensieri: “la metà di me stesso in te rimane/ e mi ritrovo ad ogni mio ritorno”. Torino raccoglie tutti i suoi ricordi più mesti, ma è anche l’ambiente concreto ed umano al quale egli sente di appartenere. Accanto alla Torino a lui contemporanea, (“le dritte vie corrusche di rotaie”), appare nei suoi scritti una Torino dei tempi antichi, un po’ polverosa che suscita nel poeta accenti lirici carichi di nostalgia. “Non soffre. Ama quel mondo senza raggio/ di bellezza, ove cosa di trastullo/ è l’Arte. Ama quei modi e quel linguaggio/ e quell’ambiente sconsolato e brullo.” Con tali parole malinconiche Gozzano parla di Torino, e richiama alla memoria “certi salotti/ beoti assai, pettegoli, bigotti” che tuttavia sono cari al per sempre giovane scrittore. “Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca/ tuttavia d’un tal garbo parigino”, questa è la Torino di Gozzano, e mentre lui scrive è facile immaginare il Po che scorre, i bei palazzi del Lungo Po che si specchiano nell’acqua in movimento, la Mole che svetta su un cielo che difficilmente è di un azzurro limpido.
Ma torniamo a Torino, la sua città natale, la amata Torino, che è sempre nei suoi pensieri: “la metà di me stesso in te rimane/ e mi ritrovo ad ogni mio ritorno”. Torino raccoglie tutti i suoi ricordi più mesti, ma è anche l’ambiente concreto ed umano al quale egli sente di appartenere. Accanto alla Torino a lui contemporanea, (“le dritte vie corrusche di rotaie”), appare nei suoi scritti una Torino dei tempi antichi, un po’ polverosa che suscita nel poeta accenti lirici carichi di nostalgia. “Non soffre. Ama quel mondo senza raggio/ di bellezza, ove cosa di trastullo/ è l’Arte. Ama quei modi e quel linguaggio/ e quell’ambiente sconsolato e brullo.” Con tali parole malinconiche Gozzano parla di Torino, e richiama alla memoria “certi salotti/ beoti assai, pettegoli, bigotti” che tuttavia sono cari al per sempre giovane scrittore. “Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca/ tuttavia d’un tal garbo parigino”, questa è la Torino di Gozzano, e mentre lui scrive è facile immaginare il Po che scorre, i bei palazzi del Lungo Po che si specchiano nell’acqua in movimento, la Mole che svetta su un cielo che difficilmente è di un azzurro limpido.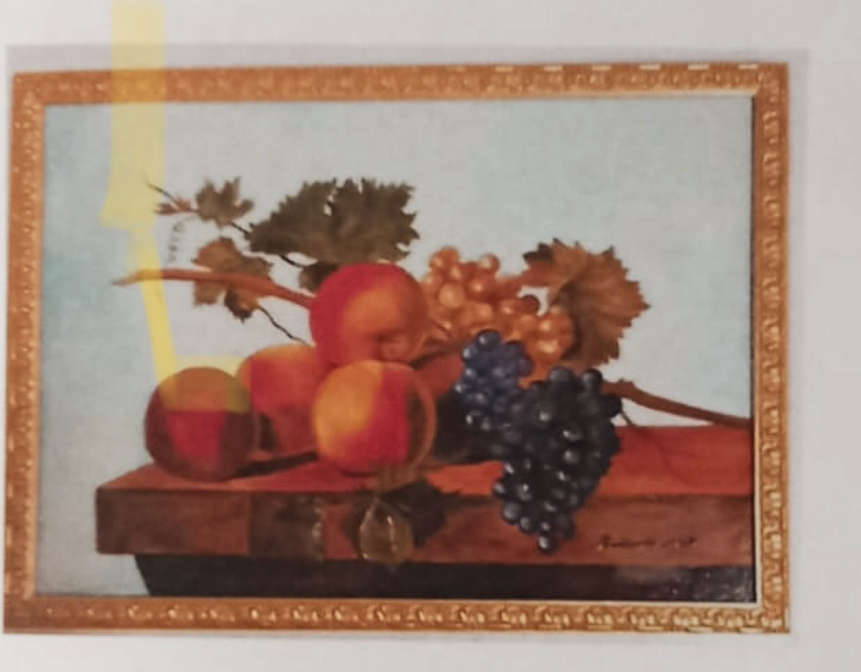
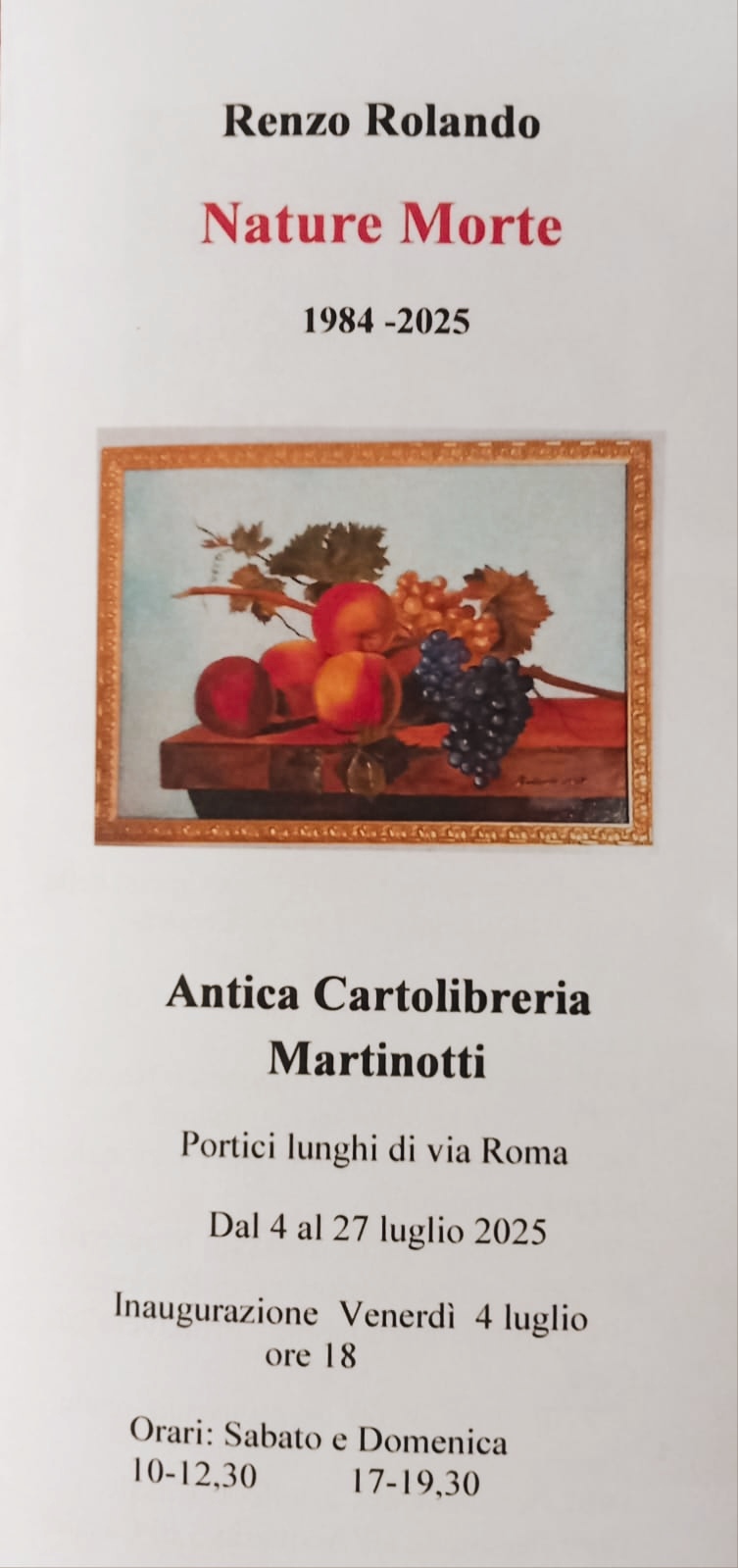


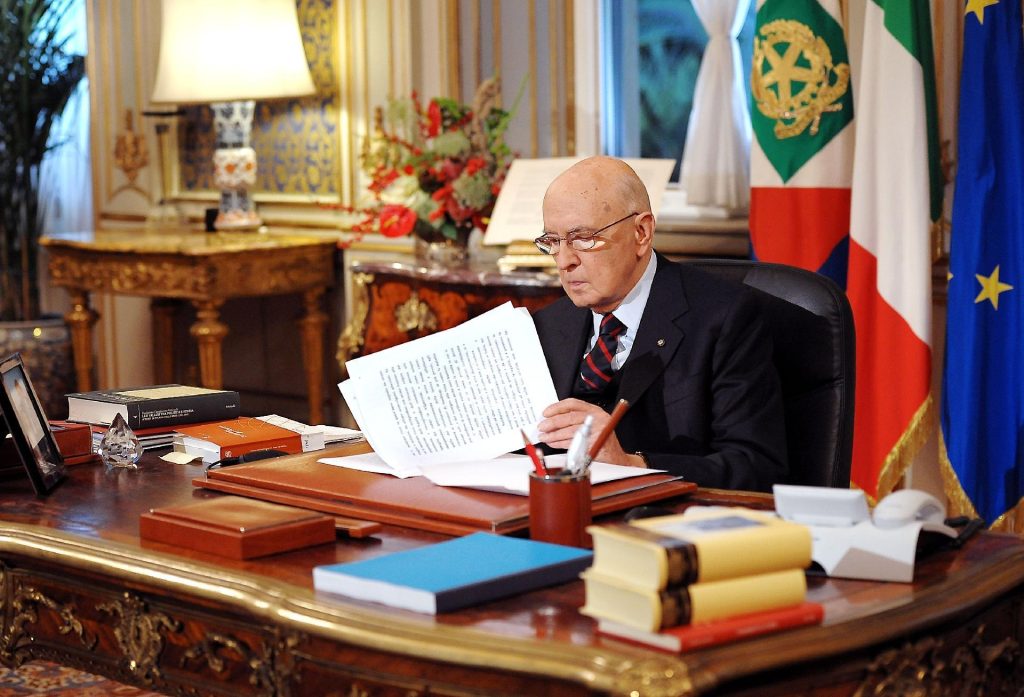






 Articolo 9.
Articolo 9.  succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.
succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.