|
|
|
|
La Sacra di San Michele è un’abbazia maestosa. A tal luogo è legata una leggenda: in un tempo lontano arrivarono nella valle dei mercenari dediti a ogni sorta di razzia.
Leggi l’articolo su piemonteitalia.eu: https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/la-bella-alda-la-leggenda-della-sacra-di-san-michele
Di Renato Verga
Per la terza volta in pochi mesi un concerto sinfonico si apre con un’ouverture di Carl Maria von Weber. Dopo Der Freischütz diretto da Riccardo Minasi con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e Oberon eseguito dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Manfred Honeck, è ancora Oberon a inaugurare il programma del dodicesimo concerto della stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, all’Auditorium Arturo Toscanini. Sul podio, in sostituzione del previsto Andrés Orozco-Estrada, sale Emmanuel Tjeknavorian.
Nato a Vienna nel 1995 in una famiglia di musicisti di origini armene e iraniane, Tjeknavorian ha iniziato giovanissimo lo studio del violino, per poi orientarsi progressivamente verso la direzione d’orchestra. Figlio del compositore e direttore Loris Tjeknavorian e di una pianista, ha costruito in breve tempo una carriera intensa, culminata nel 2024 con la nomina a Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano e con il Premio Abbiati 2025 come Miglior direttore d’orchestra. Nell’ouverture weberiana, tuttavia, la sua energia non si impone subito: l’esecuzione è solida ed efficace, ma l’elemento fiabesco e soprannaturale della partitura avrebbe forse richiesto maggiore leggerezza e un senso più pronunciato dell’incanto.
È con il Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore K 467 di Mozart che il concerto cambia decisamente passo. Qui emerge con chiarezza la qualità del dialogo instaurato dal direttore con l’orchestra, che trova una risposta ideale nella partecipazione del solista Mao Fujita. Nato a Tokyo nel 1998, Fujita ha iniziato a studiare pianoforte a tre anni e si è imposto negli ultimi anni come uno degli interpreti più interessanti della sua generazione. Nel celebre K 467 offre una lettura di grande equilibrio, in cui la trasparenza del suono e la chiarezza del fraseggio si uniscono a una profonda naturalezza stilistica. L’Andante, celeberrimo per la sua cantabilità sospesa, rappresenta il vertice espressivo dell’esecuzione, grazie a un controllo del tempo e del colore che evita ogni compiacimento. Il virtuosismo, mai ostentato, emerge nelle ampie cadenze dei movimenti estremi, affrontate con sicurezza tecnica e autentico senso musicale.
Il successo è tale da spingere il pianista a concedere due bis inattesi: la Fugue sur le nom d’Haydn di Charles-Marie Widor e l’Hommage à Haydn di Claude Debussy, entrambi composti nel 1909 per il centenario della morte del compositore. Si tratta di brani costruiti sulla trasposizione musicale del nome HAYDN, secondo un sistema di corrispondenze alfabetiche elaborato dalla Société Internationale de Musique. Due pagine rare e curiose, eseguite da Fujita con aplomb e precisione, che aggiungono una nota di raffinata eccentricità alla serata.
La seconda parte del concerto è interamente dedicata a Johannes Brahms e alla sua Sinfonia n. 1 in do minore op. 68, opera che rappresenta uno dei momenti più complessi e sofferti della storia della sinfonia ottocentesca. Brahms impiegò decenni prima di affrontare il genere, consapevole del peso esercitato dal modello beethoveniano. Quando la sinfonia fu finalmente presentata a Karlsruhe nel 1876, il compositore aveva già superato i quarant’anni ed era ormai una figura affermata, ma non ancora “consacrata” dal confronto con la forma sinfonica.
L’accoglienza fu clamorosa e non priva di fraintendimenti: Eduard Hanslick parlò di una diretta continuità con Beethoven, dando origine al celebre cliché della “Decima sinfonia”. In realtà, la Prima di Brahms guarda meno al progresso attraverso il conflitto tipico di Beethoven e più a un tono di ballata romantica, evidente soprattutto nel complesso primo movimento, costruito su una fitta rete tematica dal carattere prevalentemente tragico. Anche le apparenti somiglianze del finale con la Nona beethoveniana restano più evocazioni superficiali che reali parentele strutturali.
In questa pagina Brahms afferma una voce personale, densa e severa, che Tjeknavorian sembra sentire come particolarmente congeniale. La sua lettura mette in luce la solidità dell’impianto formale e la tensione drammatica della partitura, confermando come il giovane direttore trovi proprio nel grande repertorio sinfonico ottocentesco uno dei terreni più convincenti della propria maturazione artistica.
È il Metaphōnê Chamber Consort dell’OSN Rai, guidato da Andrea Ravizza, il protagonista del ciclo di concerti cameristici “Domeniche dell’Auditorium”, in programma domenica 8 febbraio prossimo, alle 10.30, presso l’Auditorium Arturo Toscanini di Torino. Il concerto sarà registrato da Radio 3, che lo trasmetterà domenica 15 febbraio alle 20.30. L’appuntamento sarà preceduto da esponenti dell’associazione Libera di Don Ciotti, parte di un percorso d’avvicinamento al 21 marzo, che a Torino vedrà tenersi la manifestazione della Giornata Nazionale dedicata alla Memoria delle vittime innocenti delle mafie. In apertura la formazione proporrà la Sonata per pianoforte Sz80 (BB88) di Bela Bartók, presentata nell’adattamento per gruppo da camera. Composta nel 1926, la pagina segna l’ingresso del compositore in una fase neoclassica, ma caratterizzata da una scrittura nitida, percussiva e di grande vigore ritmico. A seguire, Doppelgänger, firmato dallo stesso Ravizza nel 2025 per eufonio solista, ensemble e live elettronics. Dedicato all’eufonista Devid Ceste, che, dopo la prima esecuzione assoluta dello scorso settembre 2025 al Festival Classiche Armonie, lo esegue anche a Torino, il pezzo dialoga con la tradizione del doppdiario autori come Pierre Boulez, Bruno Maderna e Steve Reich. A concludere il concerto sarà il Preludio e tripla fuga in mi bemolle maggiore BWV 552 di J.S. Bach, proposto anch’esso in un adattamento cameristico. Vortice monumentale della letteratura organistica, l’opera fu pubblicata nel 1739 come cornice della Clavier-Übung III, caratterizzata da un’architettura sonora imponente intrisa di simbologia teologica.
I biglietti per il concerto sono proposti al prezzo unico di 5 euro e sono in vendita online sul sito OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino.
Auditorium Rai – piazza Rossaro, Torino – telefono: 011 8104996 – www.osn.rai.it
Mara Martellotta
Prenderà il via l’8 febbraio la terza stagione di T.R.A.C.K.S., progetto culturale multidisciplinare promosso dall’Accademia dei Folli, che propone spettacoli teatrali, safari urbani, laboratori musicali nelle scuole e una mostra tematica.
Domenica 8 febbraio si inaugura la nuova edizione di T.R.A.C.K.S. – Trasformazione, Radicamento, Arte, Contemporaneità, Knowledge, Sharing, ideato dalla compagnia di teatro e musica Accademia dei Folli, vincitrice del bando “Torino che cultura!” della Città di Torino, finanziato nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 a sostegno dell’economia urbana nel settore culturale.
Dal’8 febbraio al 22 novembre sono in calendario spettacoli teatrali, passeggiate urbane, laboratori didattici nelle scuole, un evento finale di restituzione e l’inaugurazione di una mostra tematica. L’edizione di quest’anno affronta alcuni degli obiettivi principali dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare attenzione a salute e benessere, riduzione delle disuguaglianze e città e comunità sostenibili.
Per il ciclo Urbantracks sono previsti quattro safari urbani, in programma domenica 8 febbraio, 1 marzo, 19 aprile e 11 ottobre. Le passeggiate offriranno l’opportunità di esplorare luoghi significativi di Torino, conoscere associazioni e realtà locali e raccogliere testimonianze legate alle sfide globali dell’Agenda 2030, sotto la guida di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Il percorso, caratterizzato da un approccio multisensoriale e multidisciplinare, prevede interventi teatrali degli attori dell’Accademia dei Folli e performance musicali dei musicisti di Estemporanea. I fotografi della Scuola Internazionale di Comics di Torino accompagneranno i partecipanti nella realizzazione di scatti fotografici, mentre una docente della Scuola Holden stimolerà la scrittura di impressioni e riflessioni sui luoghi visitati. Novità dell’edizione 2026 sarà la raccolta dei suoni dei quartieri attraversati. Fotografie, testi e registrazioni sonore confluiranno nella mostra finale, che sarà inaugurata il 22 novembre. Le passeggiate sono gratuite, si svolgono dalle 15 alle 17.30.
Al termine di ogni safari urbano, alle ore 18, è previsto uno spettacolo teatrale dedicato a uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 individuati dal progetto.
Il cartellone propone cinque produzioni di compagnie teatrali nazionali: l’8 febbraio il Teatro delle Temperie porterà in scena Lo stronzo; il 1° marzo la compagnia Noveteatro presenterà Drained – Sdrenati; il 19 aprile Cabiria Teatro proporrà al Teatro Studio Bunker Romeo e Giulietta – Opera ibrida; l’11 ottobre Assemblea Teatro sarà protagonista con Il barone rampante; chiuderà la rassegna, il 30 ottobre, Evoè! Teatro con Flyover Country. Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Studio Bunker (via Niccolò Paganini 0/200). Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 5 euro per i partecipanti ai safari urbani pomeridiani, ad eccezione dello spettacolo del 30 ottobre, non preceduto dalla passeggiata.
Il progetto comprende inoltre laboratori musicali rivolti alle scuole primarie, che coinvolgeranno quattro classi in altrettanti percorsi tematici, ciascuno dedicato a una delle sfide globali individuate. Le attività saranno precedute da una matinée scolastica a cura del Collettivo Clochart con lo spettacolo Despresso, legato all’obiettivo 10 dell’Agenda 2030, dedicato alla riduzione delle disuguaglianze. I laboratori, della durata di dieci ore, saranno condotti da formatori di Legambiente, docenti di musica di Estemporanea e insegnanti della Scuola Holden. I brani musicali realizzati dagli studenti costituiranno una “colonna sonora sostenibile”, grazie all’utilizzo di strumenti costruiti con materiali plastici riciclati. Il percorso si concluderà il 22 novembre al Teatro Studio Bunker con Tracks Explosion, spettacolo finale che vedrà l’Accademia dei Folli riarrangiare ed eseguire le canzoni composte dai bambini.
Completa il progetto la mostra Trackshibition, un’immersione nei quartieri esplorati durante gli Urbantracks, che raccoglierà fotografie, testi e suoni realizzati dai partecipanti, coinvolgendoli attivamente nel processo di esplorazione culturale. Lo spazio espositivo sarà individuato attraverso una call dedicata. L’inaugurazione è prevista per domenica 22 novembre e sarà pensata come momento di condivisione culturale e artistica con la comunità locale.
Mara Martellotta
“L’agente segreto”, candidato a quattro premi Oscar
PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione
Due giovani ragazze, più vicine alla nostra epoca, percepiscono una retribuzione per ricomporre, attraverso registrazioni, articoli dei tanti giornali, intercettazioni ambientali, come in un puzzle che non conosce delimitazioni ma che al contrario si dilata ad ogni nuovo sguardo, giorno dopo giorno: i tratti, l’esistenza, gli spostamenti, i fatti e la morte di Armando alias Marcelo, dando forma a una spy story che trova le proprie radici durante un carnevale di Recife della seconda metà dei Settanta, caotico e sanguinoso, di quelli che pur tra i festeggiamenti seminano catene di vittime. Frammenti dopo frammenti, tracce, visi che si mescolano e si fanno sempre più numerosi, parole e chiacchiere, voci, tante voci disseminate e ancora silenziose, un intreccio che non si chiarifica, che s’affida anche al cinema – che non è certo sempre spettacolo benevolo, se una donna può uscire dalla sala in preda come posseduta da quanto ha appena visto – e agli schermi su cui scorrono le immagini dello “Squalo” horrorifico del giovane Spielberg o il naso schiacciato di Belmondo circondato da cento bellezze, o alle locandine che s’affacciano sugli ingressi delle sale, “Pasqualino Settebellezze” della nostra Wertmuller, per esempio. Si tenta di ricomporre la storia ma altresì la Storia, quella con la esse maiuscola, quella della dittatura e dei generali al comando, della corruzione e delle uccisioni a cui la parola inchiesta per ristabilire laverità e i mandanti sarà del tutto negata. Realtà e ricostruzioni, al di là di qualche decennio, sangue e anche ironia, sberleffo che dovrebbe accompagnarti al sorriso (o alla risata) ma che dentro quel sangue non ci riesce, per cui anche “la gamba pelosa”, trovata in bocca allo squalo, che va disseminando strage in un giardinetto notturno dentro cui da coppiette o trii di grande mescolanza si consuma un’ampia ginnastica sessuale, si fa realissima in tutto il suo più genuino surrealismo. Brandello importante di un grottesco che è una delle anime dell’intera, doverosa, gustabilissima vicenda. Imprigionato in esso quel memento di b-movie che spesso è arrivato a terrorizzarci e a farci anche un po’ sorridere, in avanti con gli anni.
Pugni nello stomaco dello spettatore, ingarbugliamenti e un racconto dove molte cose (troppe?) rimangono sotto il pelo dell’acqua, un preteso caos che dà la mano a quel materiale disordinato e misterioso che andiamo cercando, sbocconcellamenti cinematografici che ritroviamo qua e là. Fin dall’inizio. Una stazione di servizio dove il protagonista giunge a bordo di un giallo maggiolino per rifornirsi mentre un cadavere, al riparo dal sole ma non dai tafani che gli ronzano intorno e dai cani randagi che gli si avvicinano, occupa il suo spazio nell’area di sosta. L’incredulo viene informato che il morto è lì disteso già da qualche giorno e che nessuno ancora è venuto a reclamarlo: mentre un’auto della polizia gli viene a passare accanto, chiede documenti e informazioni ad Armando/Marcelo, reclama con calma al padrone del servizio una qualche mancia per la buona polizia. È l’inizio. Poi facciamo la conoscenza di Dona Sebastiana e della sua casa ospitale con “i rifugiati”, del piccolo Fernando che è il figlio di Armando e che vive con i nonni, del corrotto capo della polizia Euclides, della famosa gamba pelosa che qualcuno pensa bene di sostituire nella cella dell’obitorio con una zampa d’animale, del nuovo lavoro che il protagonista riesce a ottenere nell’ufficio dell’anagrafe locale, di un ebreo sfuggito all’olocausto, dei due sicari che il perfido quanto arrogante Ghirotti, genovese d’origine, ha assoldato per far fuori Armando/Marcelo, colpevole d’aver scoperto che il famigerato ha annullato tutti i finanziamenti all’università dove lui è a capo di un gruppo di ricerca. E ancora, Elza che guida un movimento di resistenza politica, una storia di passaporti di cui si ha sempre più urgenza, una carneficina con tanto di macchie rossastre che s’allargano sul selciato, il figlio di Armando con un salto di decenni, che una delle ragazze investigatrici ha rintracciato in una clinica dove approdano i donatori di sangue e che ha preso il posto di un vecchio cinema. Fernando confessa di non aver nessun ricordo del padre ma ricorda benissimo di aver visto in quello spazio dove oggi lavora proprio il film di Spielberg, con il nonno.
“L’agente segreto”, suddiviso in tre capitoli, è valso il Premio per la regia a Cannes al suo regista Kleber Mendonça Filho e il Palmarès per la miglior interpretazione maschile a Wagner Moura, eccellente triplice (potremmo dire) interprete, che si è pure preso tra le mani il Golden Globe con quello come miglior film straniero, mentre ora attende di conoscere quale/quali delle quattro candidature porti a casa lo zio Oscar. “L’agente segreto” a ben vedere è un grande romanzo fiume, di quelli che si leggerebbero comodamente seduti in poltrona, flussi di parole senza briglie a frenarle, 158’ impressi sullo schermo, un fiume (volutamente?) disperso e mai dispersivo, inesauribile di immagini, di memorie e di sentimenti, di ossessioni, di ricordi sfocati e di un’immaginazione che pur avrà fatto ricorso all’immaginario collettivo di un tempo, che ha preso a emblema l’immagine di un uomo che improvvisamente vediamo cadavere ricoperto di sangue e abbandoniamo in un sottofinale. Un dramma (diventa un drammone, con tutte le proprie leggi, in taluni momenti?) a cui si potrebbe non perdonare la eccessiva lunghezza e quei tratti di “avventura” che sviano lo sguardo dello spettatore rendendolo più “facile” ma che certo ha in sé due momenti di cinema “alto” come sono quelli che danno vita alla riunione e alla cena con Ghirotti e che, come si usa scrivere in questi momenti, varrebbero il prezzo del biglietto: ma certamente “L’agente segreto” non ha la robustezza, la dolenza e la commiserazione, lo sguardo lucidamente triste di un film che l’anno scorso abbiamo amato moltissimo, “Io sono ancora qui” del brasiliano Walter Salles, Oscar come miglior film in lingua straniera e un monumento per Fernanda Torres, costruzione di memoria collettiva e privata allo stesso tempo, di quella medesima terra del Brasile che ancora ricerca i suoi desaparecidos.
Domenico Pinelli debutta, come interprete e regista, venerdì 6 febbraio, alle ore 21, al teatro Gioiello di Torino, con la tragedia che si fa farsa “Ditegli sempre di sì”, di Eduardo De Filippo. La produzione è a cura della compagnia degli Ipocriti di Melina Balsamo, composta da 12 attori. Pinelli l’ha portato in scena per la prima volta nel 2024 al teatro La Pergola di Firenze, in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa del grande drammaturgo.
La geniale commedia era nata nel 1927 con un atto unico in dialetto napoletano, dal titolo “Chill’è pazzo!”, ed era stata scritta per il fratellastro Vincenzo Scarpetta e, in seguito, nel 1932, reintitolata dopo aver apportato importanti modifiche. L’opera racconta una vicenda in bilico fra farsa e dramma, dove la follia si fa motore narrativo e specchio della condizione umana. Muovendo dal celebre monito di Eduardo di “divertirsi riflettendo”, la messinscena propone un arilettura più consapevole e stratificata del testo, ricercando il cuore tragico dietro l’apparente leggerezza. Il progetto, sostenuto da una compagnia di giovani interpreti, coniuga rispetto per la tradizione e ambizione contemporanea, nel segno dell’umorismo pirandelliano, che tanto influenzò Eduardo. La storia parla di Michele Murri, un commerciante dimesso dal manicomio, dove è stato ricoverato per un anno, che torna a casa dalla sorella Teresa, a cui viene raccomandato di sottostare alle richieste del fratello per non tornare il suo fragile equilibrio. Murri, apparentemente sembra guarito, ma confonde i nomi reale persone, non conosce ironia, prende tutto alla lettera e si ritrova in un mondo in cui la normalità non coincide con ciò che la sua mente gli suggerisce, e tutto questo provoca una serie di equivoci e fraintendimenti. L’opera è una scommessa coraggiosa, che trasforma la farsa in dramma e rilancia la domanda “chi è davvero il pazzo?”.
Venerdì 6 e sabato 7 febbraio ore 21 / domenica 8 febbraio ore 16
Teatro Gioiello – via Cristoforo Colombo 31, Torino
Mara Martellotta
“Che la mia fine sia un racconto”, scritto da Giorgia Würth, appartiene a un modo di far letteratura che è andato piano piano perdendosi già a partire dalla seconda metà del Novecento, fino quasi scomparire, non fosse per qualche grande voce fuori dal coro, negli anni Duemila. Si tratta di quella letteratura che dall’intimismo puramente soggettivo vira e si ramifica in una più ampia analisi dello stare al mondo dell’essere umano come protagonista di un’unica comunità. Giorgia Würth, in questo libro, sembra ripercorrere le orme di quegli scrittori che, non sottomessi a un ordine politico o di credo, hanno saputo individuare e donare all’umanità la purezza della percezione elevandola a tema universale. Ricordo Carlo Emilio Gadda e il suo “Diario di guerra e di prigionia”, in cui i terribili eventi della Grande Guerra sono narrati dallo scrittore quasi fossero un affronto alla sua persona, che pagina dopo pagina diventa unica rappresentante del dolore e della sofferenza di corpi, cuori e menti trafitti dall’orrore. Una dinamica molto simile la troviamo in molti dei libri “sociali” di Antonio Tabucchi. Anche Giorgia Würth, in questo suo lavoro, ci propone un “diario” che funge da strumento per una riflessione complessa, ampia e che tocca molteplici argomenti. Le testimonianze di sofferenza di chi ha toccato con mano gli effetti del brutale conflitto israelo-palestinese non ci mettono in contatto con la semplice dimensione del dolore causato dal conflitto sanguinario, ma anche con il nostro modo di accogliere e metabolizzare le informazioni mediatiche che ne derivano, filtrate dalle nuove tecnologie. Oggi, per lo più, l’informazione arriva attraverso l’immediatezza dell’immagine, del reel social e la breve didascalia che lo contestualizza, della notizia “flash”, e leggere il libro di Giorgia Würth significa anche chiedersi se questo grande calderone di contenuti a cui ci sottoponiamo, e con il quale entriamo in azione a colpi di veloce scorrimento sul nostro smartphone, non contribuisca a una dispercezione riguardante il pericolo o la gravità di un evento, se tutto questo non causi anche una sterilità culturale e sentimentale nei confronti di un altro essere umano. Certo, le manifestazioni ProPal sono numerose, ma mi ha fatto riflettere una frase che disse un ragazzo durante un corteo a Torino: “Forse sto manifestando perché gli ideali che mi sono stati tramandati me lo impongono, ma sento purtroppo molto lontana la sofferenza di tutte queste guerre”.
Ecco, penso che questo di Giorgia Würth sia un libro necessario, e che risponda a queste preoccupazioni attraverso lo stimolo alla riflessione, riportando alla luce il grande potere della letteratura.
Dalla sinossi: “Dal 7 ottobre 2023, per molti di noi la vita non è più la stessa. Gli eventi di Gaza hanno scosso le fondamenta della giustizia, dei diritti umani e della libertà di pensiero. Per la prima volta, attraverso i social media, assistiamo in diretta a un genocidio, e questo ha lasciato un segno indelebile su chi ha scelto di non chiudere gli occhi. Dolore, rabbia e impotenza hanno spinto molti a rivoluzionare la propria vita, le relazioni, il lavoro. In questo diario collettivo, voci diverse si intrecciano per raccontare la lotta per la sopravvivenza di un popolo e l’impatto profondo di questa resistenza sulle nostre coscienze. Sono testimonianze di sofferenza, ma anche di risveglio e liberazione, in cui la Palestina diventa una lente attraverso cui ripensare noi stessi. Un’opportunità per decolonizzare il nostro immaginario, combattere l’islamofobia e il razzismo, e sfidare la disumanizzazione. La causa palestinese non è solo un conflitto geopolitico, ma un simbolo universale di dignità e umanità per chi ha il coraggio di coglierlo.
Affinché davvero non accada mai più.
“Che la mia fine sia un racconto” è un’opera potente e toccante che, attraverso la condivisione di esperienze personali, ci mette di fronte alla realtà brutale del conflitto israelo-palestinese e al suo impatto devastante sulla vita di milioni di persone. Il libro ci chiama a non rimanere indifferenti, a trasformare il dolore in azione, a rompere il silenzio e a lottare per un futuro di giustizia e di pace.
Gian Giacomo Della Porta

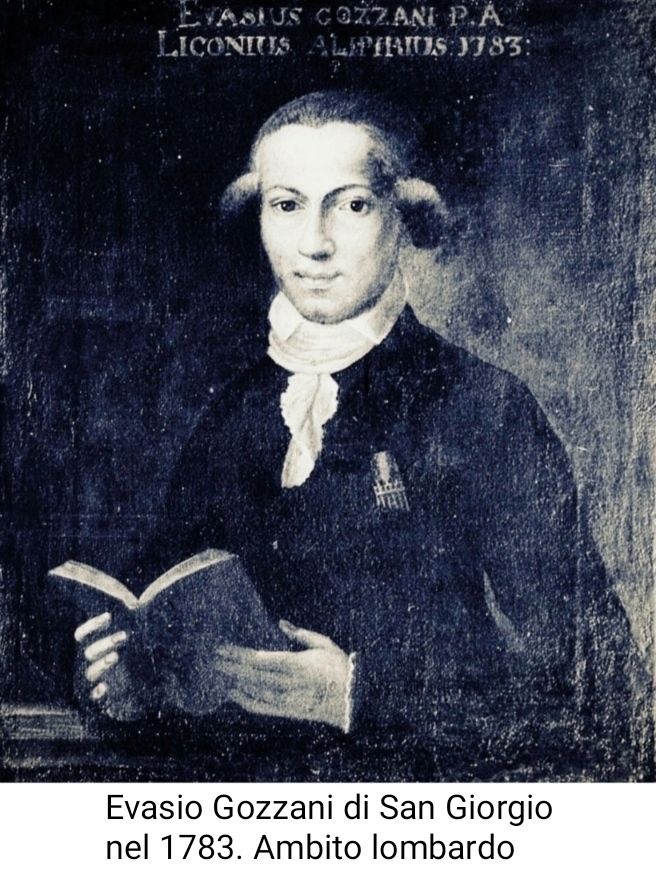


Di Riccardo Rapini
Nel terzo appuntamento di Brandelli vi parlo della regista Giulia Odetto.
Originaria di Fossano e formatasi alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, si destreggia, giovanissima, sul filo di lana di più linguaggi: attrice, assistente alla regia, macchina concreta delle produzioni, fino ad approdare alla regia come fucina in cui amalgamare al meglio l’energia rigogliosa che l’attraversa.
Nel 2016 fonda Effetto Pullman, poi Collettivo EFFE, dove già in nuce si può trovare aggrovigliata la traiettoria che prenderà: non un teatro di rappresentazione, ma abbastanza ampio da mettere in attrito corpi e media, natura e tecnologia, stracolore di luci e buio.
Arriva anche il riconoscimento pubblico come attrice quando viene scelta per Tango Glaciale Reloaded, diretto da Mario Martone, del quale lei parla con affetto: “uomo calmo e risolto”.
Uno spettacolo in cui la dirompenza della sua giovinezza può deflagrare tra pareti che si aprono, stanze che cambiano funzione, oggetti che diventano improvvisamente “altro da sé”.
Poi c’è Onirica, finalista alla Biennale College Teatro (registi under 30), e Wonderland, prodotto dal Teatro Stabile di Torino nel gennaio 2024, ispirato ad Alice in Wonderland, dove il mondo infantile si fa macchina percettiva che moltiplica la realtà come attraverso la lente di un canocchiale che esplode, e un vociare nevrastenico riecheggia in un fantasmagorico tunnel lampeggiante.
Oggi lavora tra creazione e istituzioni, ed è impegnata nell’allestimento di Come vi piace di Shakespeare al Teatro Carignano, l’autore per antonomasia, che le permetterà di sperimentare anche là dove sembra essere già stato saggiato tutto.
Ci incontriamo una mattina di pioggia al bar Antico Borgo, in zona Borgo Dora, uno di quei quartieri di Torino che, di per sé, sembra un’imprudente scenografia teatrale: una ripetizione quotidiana di gesti e di volti che appaiono come irrorati dalle fiamme tremule di una corte dei miracoli.
Impataccata, rimbombante, sottosopra, spesso grottesca, reale, qui Torino dismette il suo abito da sera sabaudo e si impiastriccia malamente il viso con un trucco umano che la fa assomigliare al quadro La maschera di Frida Kahlo.
Vedo Giulia dai vetri del bar, indossa un cappello da pescatore leopardato che non le permette di mimetizzarsi e un sorriso da folletto che ben predispone.
Mentre parliamo seduti a un tavolino noto in lei una tendenza naturale alla pianificazione, alla struttura, come se il caos – che pure la attrae – dovesse sempre passare attraverso un filtro prima di essere esaudito.
Ogni frammento della realtà le appare come potenziale teatro: nulla è davvero neutro.
Come se il quotidiano non fosse una banalità da oltrepassare, ma una miniera che permette di accumulare una fortuna da dilapidare in scena.
Giulia si percepisce come un collante umano: le piace lavorare in gruppo e, seppur mantenendo di fondo la veste di regista-demiurgo, non domina né invade. Immagina uno spazio dove poter osservare tanti corpi, presenze, materie vive, da far risuonare in un attrito inizialmente controllato e che, da scintilla, può generare il fuoco.
Parliamo di balle di fieno, di faine, di pullman, di spaventi, di corpi umani, di montagne.
Di montagne: nel suo spettacolo Il mio corpo è (come) un monte del 2021, Giulia si pone non una metafora poetica ma un’ipotesi ontologica: farsi cima.
Tenta l’inesaudibile attraverso il corpo della ballerina Lidia Luciani e “l’occhio in vista” e lo strumento percettivo, visivo e sonoro, di Daniele Giacometti.
I movimenti sono rallentati, rotti e spesso minimi, talvolta prossimi all’immobilità. La scena non cambia: è il rapporto tra corpo e spazio a mutare lentamente, producendo una sensazione di durata geologica.
I suoni sono d’acqua che gocciola, d’aria sferzante e soprattutto di sassi che si scontrano, continui e stratificati: microscopiche placche tettoniche in azione.
Cambiamenti minimi di intensità e temperatura nella luce accompagnano la metamorfosi.
Tutto dal vivo.
Nel progetto la parola che ritorna è “rinuncio”: un ammasso di rinunce all’umano che tentano, appunto, di ammassarsi e diventare monte.
Una ricerca che si concentra sull’abbandono come sincera dichiarazione d’identificazione, sull’idea che diminuendo l’umano si possa espanderlo, fino a farsi tangente di condizioni limite dell’esistenza.
Termino l’articolo su questo suo lavoro, che mi vede particolarmente partecipe negli intenti, e che ha trovato un forte nodo di congiuntura con Giulia.
Uno smarginare oltre una terra isolata del corpo, un perpetuo oltrepassamento per sfiorare ciò che “è più lontano a ciò che è vicino e più vicino a ciò che è lontano”.
