Quando domenica a Torino, dopo le ultime preghiere per il Ramadan al
Parco Dora i 30mila fedeli hanno cominciato a disperdersi
pacificamente, un gruppo si è staccato e ha iniziato una
manifestazione per la Palestina, bruciando le foto di Giorgia Meloni e
di Ursula Von Der Leyen. Un gesto grave violento e sciocco, che ha visto
protagonisti piccoli gruppi di antagonisti di facinorosi, e di esponenti dei centri
sociali.
Noi credenti del Coordinamento Interconfessionale del Piemonte Noi siamo con voi, rinnoviamo a tutti un forte appello alla tolleranza e al rispetto,
oggi più che mai quando i venti dei pregiudizi sembrano dominare il
nostro tempo. Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo
la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola
della nostra condotta deve essere la tolleranza reciproca. Siamo tutti
impastati di debolezze e di errori e dobbiamo imparare a rispettare le idee altrui, a capire prima di discutere, a discutere
prima di condannare. Per queste ragioni – nello spirito autentico e originario delle fedi religiose, intendiamo rinnovare ancora più convintamente il nostro impegno per il dialogo, l’accoglienza, la solidarietà, la non violenza, la pace nella giustizia la legalità, anche a livello internazionale. Accompagnando questo impegno con un lavoro educativo serio e costante e affiancandoci, doverosamente e volentieri, a tutte le realtà istituzionali, politiche, sociali, culturali, spirituali ecc. che operano in questa prospettiva.
Idris Bergia ,Wualid Bouchnae, Younis Tawfik, Amir Younes, Bruno Geraci, Giampiero Leo, Walter Nuzzo, a nome del Coordinamento interconfessionale “Noi siamo con voi”



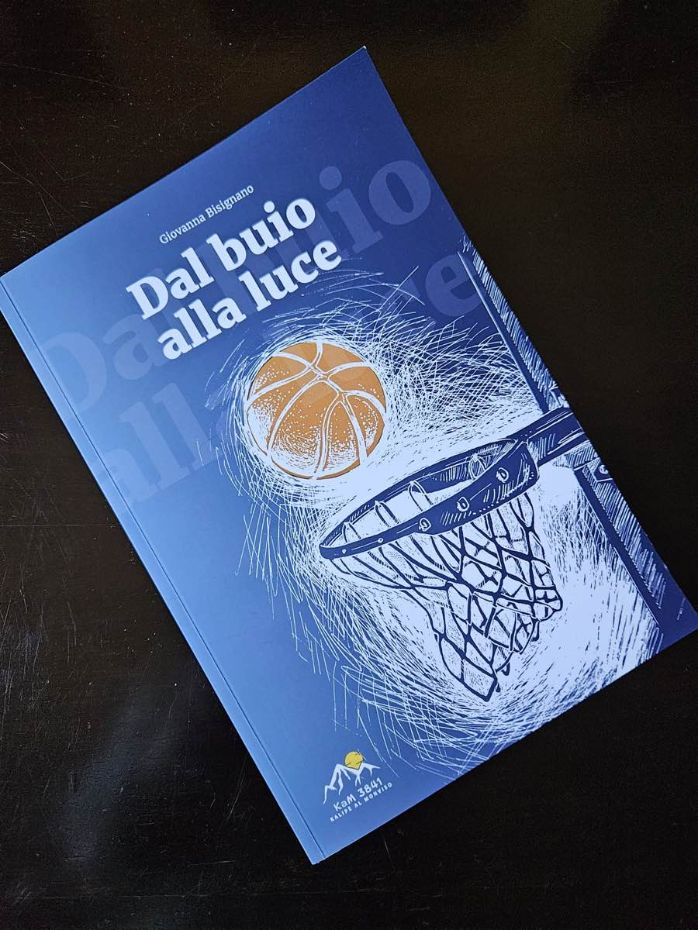











 A Torino e Milano: due appuntamenti con l’attualità politica
A Torino e Milano: due appuntamenti con l’attualità politica

