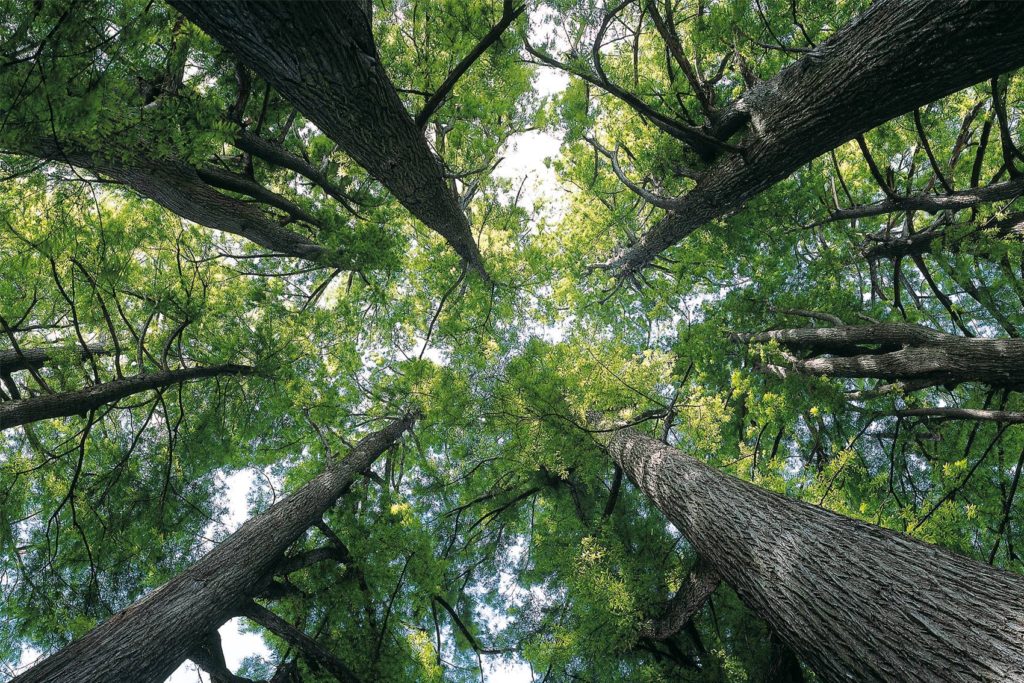Un antico dessert tipico del Piemonte, tutto da gustare. Una preparazione semplice e genuina realizzata con pesche dolci e mature, farcite da un goloso ripieno a base di cioccolato fondente e amaretti, un abbinamento davvero delizioso e irresistibile.
Ingredienti:
6 pesche mature a pasta bianca
80 gr. di amaretti
60 gr.di cioccolato fondente
2 tuorli
30 gr. di zucchero a velo
Poco burro
Lavare ed asciugare le pesche. Tagliarle a meta’ ed eliminare il nocciolo. Scavare un poco la polpa e metterla in una terrina. Preparare il ripieno mescolando la polpa delle pesche tritata con il cioccolato grattugiato e gli amaretti sbriciolati, unire parte dello zucchero a velo e i due tuorli. Disporre le mezze pesche in una pirofila da forno, precedentemente imburrata, riempirle con il ripieno di amaretti ed un fiocchetto di burro. Cuocere in forno a 190 gradi per circa 30 minuti. Servire a piacere tiepide o fredde cosparse di zucchero a velo.
Paperita Patty