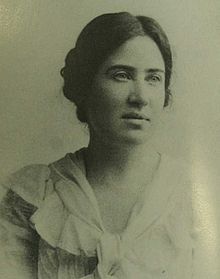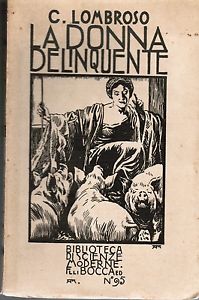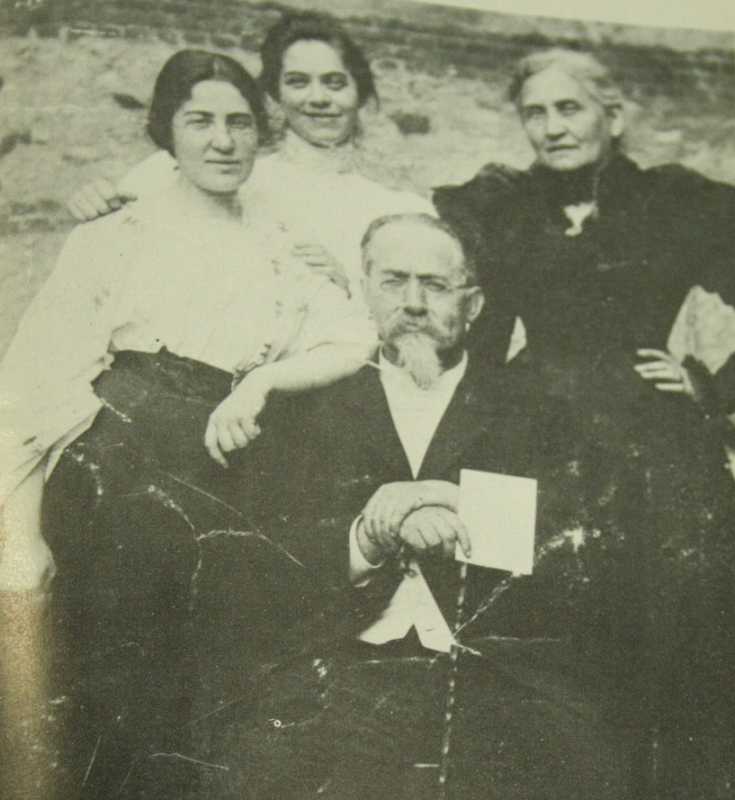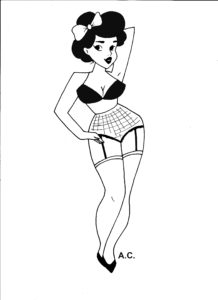Avete letto bene, e’ una pasta ma… cuoce come un risotto, provatela: e’ proprio appetitosa!
Ingredienti (per 4 persone):
320gr. di pasta corta tipo penne
15/20 pomodorini tipo Pachino
1 cucchiaio di capperi dissalati
3 cucchiai di olive taggiasche denocciolate sott’olio
1 piccola cipolla
1 spicchio di aglio
3 cucchiai di olio evo
1 bicchierino di vino bianco secco
3 cucchiai di pecorino grattuggiato
acqua per cottura
basilico e prezzemolo freschi
Sale q.b.
In una larga padella mettere a dorare la cipolla, l’aglio e i capperi tritati, aggiungere poi le olive e i pomodorini tagliati a meta’, insaporire per qualche minuto poi unire la pasta cruda e rimestare. A questo punto, salare, sfumare con il vino bianco e poi coprire completamente gli ingredienti con acqua calda e rigirare, proprio come… un risotto. Lasciar cuocere per 10 minuti (dipende dal tempo di cottura della pasta) rimestando di tanto in tanto aggiungendo, se occorre, poca acqua. Quando pronta, spolverizzare con basilico, prezzemolo fresco tritati e pecorino grattuggiato. Servire subito. Potete sostituire gli ingredienti secondo i vostri gusti, magari aggiungendo 2 filetti di acciuga… La pasta cotta in questo modo risultera’ molto piu’ gustosa e avvolta da una cremina che vi conquistera’.
Buon appetito.
Paperita Patty