Da Vienna a Casale Monferrato

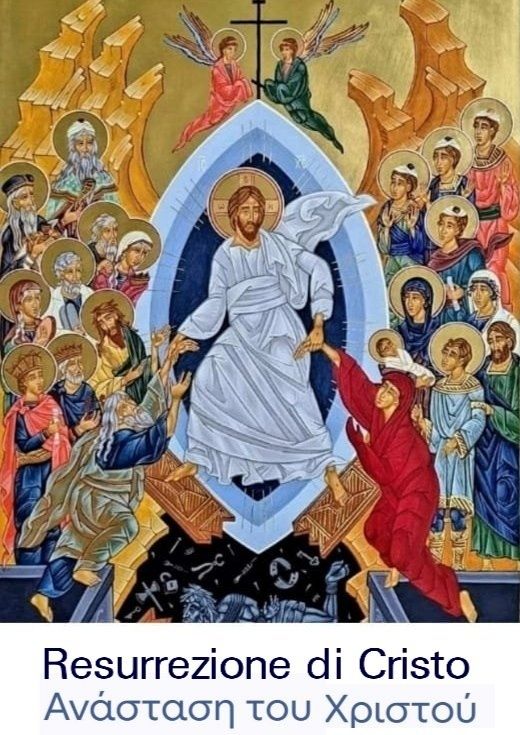

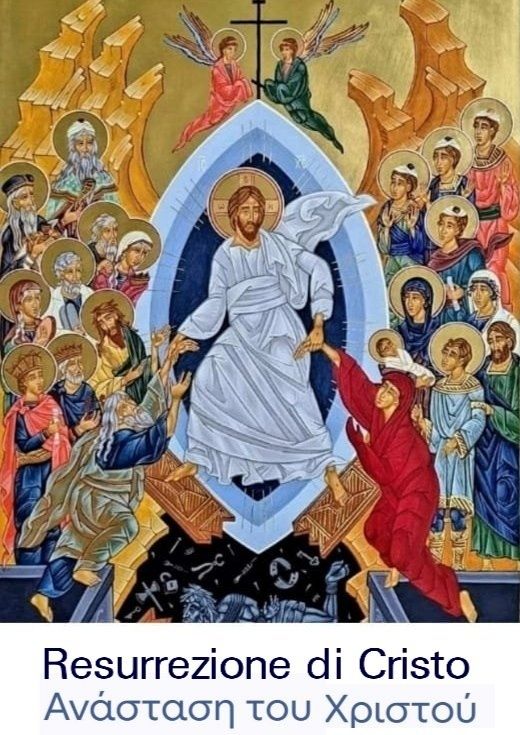
Di Marco Travaglini
“ Domenica è sempre domenica. Si sveglia la città con le campane”. Evaristo Sgancia, come è solito fare, entra fischiettando nel bar in Piazza Salera, a Omegna. La melodia è sempre la stessa da cinquant’anni, da quando rimase folgorato davanti alla televisione che trasmetteva Il Musichiere.
Un’aria orecchiabile che al vecchio operaio della Cobianchi è rimasta indelebilmente impressa nella memoria. Più invecchia e più vive di ricordi. E di abitudini che ormai non si scrolla più da dosso. Tra queste, quella di portarsi la sedia da casa quando va a vedere le partire al bar o al Circolo. Come un tempo, quando la gente si radunava davanti ai pochi apparecchi televisivi per vedere Lascia o raddoppia?, Campanile Sera o, appunto, Il Musichiere. Quando poi incrociava Gino Denti, coscritto e compagno di lavoro nel far tondi e laminati al tempo della ferriera, erano scintille. Divisi su tutto, litigavano che era un piacere. Ogni pretesto era buono, dalla passione per la pesca allo sport, dalle donne alla televisione. Anzi, “alla Tv di una volta, non quella robaccia che si vede adesso”.
Parola del Denti che, pur non portandosi appresso la sedia, in quel caso non solo evitava di contraddire l’amico (una rara eccezione) ma lo comprendeva, rammentando i bei tempi andati. Dopo di ché, rimessa in moto la memoria, infuriava la polemica. “ Il Mario sì che era un ganzo. Conduceva il Musichiere alla grande”, asseriva Evaristo con voce possente. “Tutte balle. Il migliore è sempre stato il Mike e già ai tempi si vedeva di che stoffa era fatto”, ribatteva Dino, rosso in viso. La discussione, per quanto fosse concitata, s’incanalava immancabilmente sull’onda dei ricordi. Su un punto concordavano: la superiorità della “tele” degli anni ruggenti, quando iniziarono le trasmissioni del “Programma Nazionale”. “La RAI Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. Erano le 11 di mattina del 3 gennaio 1954 quando, con voce cinguettante, Fulvia Colombo – la prima “signorina buonasera”- fece lo storico annuncio. E alla sera prese il via la prima puntata ufficiale de“La Domenica Sportiva”, con le immagini della partita Inter-Palermo ( per la cronaca, vinsero i nerazzurri per 4-0 e il campionato li vide poi conquistare il settimo scudetto mentre i rosanero siciliani retrocedettero in serie B). Fin qui, tutto liscio. L’intesa era solida. Ma da lì in poi, apriti cielo: le trasmissioni erano il loro muro di Berlino. Uno per l’altra e l’altro per l’una, ardentemente critici e polemici. Evaristo era un fans de Il Musichiere, un gioco a quiz basato sulle canzoni, condotto da Mario Riva- pseudonimo di Mariuccio Bonavolontà – dove i concorrenti, seduti su di una sedia a dondolo, dovevano ascoltare l’attacco di un brano musicale e, una volta riconosciuto, precipitarsi a suonare una campanella a dieci metri di distanza per avere diritto a dare la propria risposta, accumulando gettoni d’oro per il monte premi finale.
A eseguire i motivi musicali ci pensava l’orchestra di Gorni Kramer , affiancata da due cantanti: Nuccia Bongiovanni e un giovane alle prime armi, un tal Johnny Dorelli. La trasmissione andò in onda il sabato sera per novanta puntate, dal 7 dicembre 1957 al 7 maggio 1960 e ben presto diventò il contraltare di Lascia o raddoppia? ( per la quale stravedeva Dino Denti ). Lascia o raddoppia? , condotto da Mike Buongiorno, andò in onda a partire dal 26 novembre 1955 ogni sabato sera, alle ore 21,00, fino all’ 11 febbraio 1956 e ogni giovedì sera dal 16 febbraio1956 al 16 luglio 1959. Il primo, e più famoso, programma a quiz della RAI, ipnotizzava i telespettatori, incollandoli davanti allo schermo in bianco e nero. Nel corso della prima serata il concorrente doveva rispondere ad otto domande, nel tempo massimo di trenta secondi per ciascuna. Il montepremi iniziale era di 2.500 lire. Ad ogni risposta esatta il montepremi raddoppiava, ma se sbagliava non c’era pietà: veniva eliminato. Se invece rispondeva esattamente a tutte le otto domande, raggiungendo così la quota di 320.000 lire, aveva diritto a ritornare alla settimana successiva. Al ritorno, il conduttore rivolgeva al concorrente la domanda: Lascia o raddoppia? Se il concorrente “lasciava” intascava la somma vinta fino a quel momento, altrimenti doveva entrare in una cabina, con una cuffia attraverso la quale poteva sentire solo la voce di Mike. Di domanda in domanda, con il tempo scandito da un orologio e da una musica d’archi a far da sottofondo, cresceva la suspence. Rispondeva esattamente? Il montepremi raddoppiava e tornava la settimana successiva. Ma se la risposta era sbagliata il suo montepremi andava in fumo ed era eliminato dal gioco.
A dire il vero non andava via a mani vuote. Le poteva stringere attorno al volante di una Fiat 600 che rappresentava la “consolazione “ ( e buttala via! ). Di raddoppio in raddoppio, la somma che il concorrente poteva vincere era di 5.120.000 lire (al massimo poteva partecipare a cinque puntate consecutive). Se intascava il premio passava alla storia del quiz altrimenti “raddoppiava” la consolazione, portandosi a casa una Fiat 1200. La popolarità della trasmissione fu tale che la RAI, nel 1956, dovette spostarne la programmazione dal sabato al giovedì a seguito delle proteste dei gestori delle sale cinematografiche, che avevano visto assottigliarsi vistosamente i loro incassi proprio nella serata settimanale tradizionalmente più redditizia. Ma le cose non andarono per il verso giusto e il rimedio si rivelò, paradossalmente, peggiore del male, quando la serata del sabato, rimasta libera, fu occupata dal Il Musichiere, a sua volta popolarissimo, tanto da costringere molti cinema, ad installare televisori in sala per non perdere la clientela. Così capitava che i militari in libera uscita erano costretti a vedere i film a metà, poiché dopo il primo tempo “andava in onda” il quiz televisivo e, ad una certa ora, dovevano per forza ritornarsene in caserma. La concorrenza tra il conduttore italoamericano e il cantante romano si mostrò anche sul versante del “gentil sesso” e dei concorrenti famosi.
A Lascia o raddoppia venne inventata la figura della valletta, dove spopolò Edy Campagnoli, diventando una delle beniamine del grande pubblico (accrebbe la sua popolarità sposando il portiere del Milan e della Nazionale, Lorenzo Buffon ). E qui il ricordo si fa languido: “Ah, la Edy! Che donna. Aveva una grazia ed un’eleganza che oggi se la sognano quelle lì, pronte a far vedere la mercanzia quasi fossero al mercato”, sospirava, sognante, il Denti. Evaristo, per non essere da meno, ricorda che al fianco di Mario Riva di vallette ce n’erano addirittura due, le “Simpatiche“. “ Altro che “letterine”, “figurine”, “plastichine” e balle varie: in quel ruolo si sono avvicendate delle donne bellissime come Carla Gravina e Marilù Tolo”, sottolineava stirandosi i baffetti. E i concorrenti,eh? Al Musichiere le vincite erano più magre e l’unico campione che emerse dall’anonimato, con una vincita di otto milioni di lire circa, fu un cameriere di Roma, Spartaco D’Itri, che con il premio vinto aprì un’attività in proprio. “ La nostra, caro il mio Gino, era una trasmissione per i proletari”, sottolineava con malizia lo Sgancia. Il quale, di rimando, tesseva le lodi del torinese Gianluigi Mariannini che, in cinque puntate, rispondendo esattamente a domande sulla storia del costume, mise “ in cascina” la cifra-record di cinque milioni e 120 mila lire (poco più di 60 mila euro attuali).
Stravagante, dai modi eccentrici, con gli occhialini tondi e spessi e la barbetta cavouriana, il filosofo-dandy era stato uno dei più pittoreschi personaggi della Tv di quel periodo. I due amici con il gusto della polemica, prima di comandare un litro di barbera per farsi compagnia ( anzi: “un mezzo a testa, così non litighiamo”), ricordano una famosa puntata del 1959 de Il Musichiere, quando i due nemici Fausto Coppi e Gino Bartali (annunciati dal roboante “nientepopodimenoché” di Mario Riva) fecero la pace sulle note di “Come pioveva”, trasformata per l’occasione in “Come perdevi”. “Erano come noi, eh Gino. Peccato che io non mi chiamo fausto, altrimenti pensa un po’ che roba: uguali in tutto e in tutto differenti, come cani e gatti”. Evaristo scoppia a ridere . La risata contagia anche Gino. Si alzano, salutano e se ne vanno a casa. Ognuno per la sua strada. Evaristo portando in spalla la sua sedia impagliata.
CESANA TORINESE – Quest’anno Cesana Torinese per le vacanze natalizie e di inizio anno, accanto agli eventi legati alla neve, ha voluto puntare forte sulla cultura.
Appuntamento quindi da non perdere, sabato 4 gennaio, per un viaggio nel tempo. Infatti alle ore 21 presso la Sala Formont in via Pinerolo 0, l’Associazione Museo Monte Chaberton di Claviere, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Cesana e con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese, organizza una serata informativa ad ingresso gratuito e aperta a tutti “Cesana in bianco e nero” sulla storia di Cesana e del Monte Chaberton attraverso le immagini in bianco e nero del passato. Un viaggio per immagini tra XIX° e XX Secolo quando Cesana è passata da borgo alpino a presidio militare ai confini del Regno d’Italia.
Sino a domenica 5 gennaio è poi visitabile presso la sala polivalente dell’Ufficio del Turismo la mostra personale dell’architetto Massimo Rasero “Montagna e Territorio” con ingresso libero dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
Ultimi giorni anche per visitare la mostra “I Sapori tramandati dalle Donne” che è ospitata presso il “Museo Casa delle Lapidi” di Bousson sino a martedì 7 gennaio. Sempre a Bousson, grazie all’impegno dell’Associazione Contempora, resterà aperta alle visite sino al 31 gennaio la Natività con figure a grandezza naturale dipinte a mano dall’artista Valeria Tommasi con la grande novità dei grandi Angeli che dalla via del “Museo Casa delle Lapidi” indicheranno la via alla Natività.
Si conclude poi il 30 gennaio la seconda edizione dell’iniziativa “Scatta e Post@” a cura dall’Ufficio del Turismo. La partecipazione è libera e tutti ed è sufficiente scattare una foto o girare un video e pubblicarli sul social istagram taggando la pagina ufficiale del Comune @comunecesanatorinese. I primi 100 partecipanti saranno premiati con un simpatici gadget da ritirare presso l’Ufficio del Turismo di piazza Vittorio Amedeo.
Questa sera, venerdì 3 gennaio, a Sansicario “Sansi on fire”: fiaccolata per la solidarietà con dj set e ospiti a sorpresa. La discesa è prevista per le ore 18 con partenza dal Rifugio Madia per livello spazzaneve e dal Rifugio Soleil Beuf per livello sci paralleli/esperti. Una iniziativa promossa dalla Scuola Sci “Sansicario Action” e “Non solo neve” che si concluderà con una festa in piazza.
Domani, sabato 4 gennaio alle ore 21, sempre a Sansicario “Concerto Sansicario Vibes” “La Montagna che suona”: un gruppo di giovani talentuosi musicisti cresciuti a Sansicario. Una serata di grande musica e atmosfera perfetta per concludere le vacanze in bellezza.
Faceva freddo in quella stalla abbandonata. Dai muri tirati su a secco entrava un’aria gelida, sibilata dal vento che quella notte turbinava neve. Attorno a quel tavolo di fortuna, combinato da due vecchie assi poggiate su malfermi cavalletti di legno, io, Giorgio e Renato parlavamo di quale futuro ci attendeva. La cera della candela era rappresa in pallide lacrime e le parole scorrevano veloci, di bocca in bocca. Quando sarebbe finito l’incubo della guerra, l’occupazione dei tedeschi e l’arroganza dei fascisti della repubblica sociale con quei ghigni sinistri e i simboli delle teste da morto? L’Italia sarebbe tornata come prima del fascismo o sarebbe cambiata davvero? Certo, volevamo la libertà ma non si combatteva solo per ottenere quella. C’era di più, molto di più. “Il nostro obiettivo riguarda insieme libertà e democrazia”, diceva Giorgio. “Non è possibile che le cose rimangano come al tempo dello Statuto Albertino. Non basta che ci sia un sovrano che conceda di sua iniziativa, bontà sua, i diritti al popolo. Anzi. Non va nemmeno bene che ci sia un Re, la monarchia, i Savoia a decidere e comandare. Quelli sono scappati all’8 settembre lasciandosi alle spalle un paese dilaniato, distrutto, occupato. Prima hanno aperto le porte al Duce, poi all’avventura della guerra e ora dovremmo accoglierli ancora, perdonando tutto? Nemmeno per idea!”. Accompagnava le parole picchiando pugni sul tavolaccio, facendo tremare la candela che prontamente dovevo prendere al volo. Eravamo d’accordo tutti e tre: non avevamo preso le armi per cacciare i fascisti e i tedeschi per tornare ad essere sudditi. Insieme alla libertà volevamo giustizia, un lavoro da svolgere con dignità. Volevamo la fine di quei tormenti che ci avevano avvelenato la vita. Era la vigilia di Natale, il 24 dicembre 1944. Dopo la caduta della Repubblica dell’Ossola e il proclama di Alexander che ci chiedeva di cessare le azioni di guerriglia, in questo gelido e duro inverno ci eravamo riorganizzati ma bisognava stare attenti. C’erano giorni in cui venivamo avvertiti che in giro c’erano tedeschi e fascisti che ci davano la caccia e non era il caso di uscire allo scoperto, altri in cui si preparava o si effettuava un agguato o un’azione particolare. Avevamo deciso di non stare ad aspettare che gli alleati riprendessero a risalire l’Italia. Dovevamo fare la nostra parte e l’avremmo fatta ad ogni costo. Nei periodi di inattività eravamo impegnati anche in grandi discussioni, in cui si parlava del futuro, di come lo si immaginava. L’idea del futuro, anche fosse solo per istinto, era associata al desiderio di qualche cosa di completamente diverso che chiamavamo genericamente democrazia, cioè un Paese senza dittatura, senza imposizioni, senza violenza. Sono passati tantissimi anni e a volte penso a quella sera e alle tante sere passate a discutere, alle azioni e ai rischi che corremmo, ai compagni che persero la vita e vedendo quest’Italia piatta, meschina, ignorante mi scopro a pensare chi ce l’avesse fatto fare. Poi, superato lo scoramento, mi ritornano in mente le parole di Renato quando diceva che non bisognava illudersi, che le cose sarebbero sì cambiate ma che non c’era conquista che sarebbe stata ottenuta una volta per tutte, che per noi che volevamo cambiare la società, che aspiravamo a cambiare il mondo non ci sarebbe mai stato congedo. Quante volte ci siamo ritrovarti da anziani. Noi, i sopravvissuti con i capelli bianchi. Noi che avevamo fatto saltare i ponti e con queste mani tremanti un giorno avevamo lanciato bombe a mano e stretto forte le armi. Con queste signore dallo sguardo mite, diventate nonne e anche bisnonne, che a quei tempi nascosero pistole, portarono messaggi, ospitarono e nutrirono partigiani, fecero con coraggio la loro parte. Oggi siamo rimasti in pochi e facciamo fatica a camminare, sorretti da un bastone o una stampella. Attraversiamo lentamente le vie che un tempo ci videro muoverci con rapidità, colpendo e fuggendo. Vecchi, malandati, spesso soli e dimenticati. Può darsi che si susciti tenerezza o compatimento ma a quel tempo sbaragliammo interi battaglioni, rischiammo la vita, ci battemmo per garantire quella libertà della quale oggi tanti ne fanno cattivo uso, abusandone, senza immaginare quanto ci sia costata perché non ne sono mai stati privati e non hanno dovuto battersi per riconquistarla. Non c’è retorica. Non serve indulgere in nostalgie. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto ciò che era giusto e che tutto quanto è accaduto non deve essere dimenticato e quei semi di giustizia e libertà non inaridiscano mai. Siamo gli ultimi testimoni e tra poco non ci sarà più nessuno di noi. Il nostro regalo per Natale e per tutti i giorni a venire è questa eredità. Fatene un buon uso e non scordatevi quanto è costata.
Marco Travaglini
 Il latinista Luciano Perelli è stato ricordato al liceo “Carlo Botta” di Ivrea dove nacque nel 1911. Morto trent’anni fa, è ancora molto ricordato dagli ex allievi al liceo Gioberti di Torino e alla Facoltà di Lettere dove insegnò-caso raro- Letteratura latina e successivamente Storia romana alla Facoltà di Magistero. Soprattutto Perelli è ricordato per i suoi libri di testo dalla pregevolissima “Storia della letteratura latina” che non ebbe eguali per decine d’anni ai molti commenti a Cicerone ed agli amatissimi Lucrezio, poeta dell’angoscia e Catullo, poeta dell’amore tenero e disperato. I giovani nei suoi commenti ritrovavano l’humanitas autentica e la storicità di Roma senza l’eccessivo tecnicismo filologico che a volte uccide gli studi classici. Gli allievi di Perelli, similmente a quelli di Concetto Marchesi, acquisivano una cultura classica che era la base di un sapere poliedrico nel quale sarebbero cresciuti. Quando Perelli morì all’improvviso nel 1994, Luciano Canfora scrisse di lui una testimonianza ancora oggi importante che riguarda i suoi “ricordi antifascisti” incentrati sul carcere inflitto dal regime al padre e al fratello, che condizionò i suoi studi per affrettare il suo insegnamento privato, appena superata la Maturità, per dare un sostegno alla famiglia. Tuttavia egli non confuse mai l’insegnamento con un marcato impegno politico, come invece fece Marchesi. L’antifascismo per lui fu una scelta di libertà incompatibile con l’ideologismo anche se seppe difendere le ragioni della scuola classica da chi avrebbe voluto circoscriverla a pochi specialisti, di fatto uccidendola. Giovanna Garbarino, che fu docente di Letteratura latina, mi disse spesso che questa capacità di miscelare insieme letteratura e storia latina e greca era la cifra straordinaria di Luciano, forse non abbastanza apprezzato in Facoltà. Quando ancora insegnava al liceo, seppe difendere con coraggio ed anticonformismo la dignità professionale dei professori dalla tendenza già allora emergente di considerarli degli impiegati. La tutela della funzione docente fu una delle sue più grandi preoccupazioni e anche questo rende Perelli un protagonista unico della scuola piemontese. Egli capì fin dal suo sorgere l’aspetto eversivo di una parte della contestazione giovanile del ’68 insieme ai colleghi Franco Venturi, grande storico dell’Illuminismo e Giorgio Gullini, archeologo e preside della Facoltà di Lettere. Giunse a vedere delle affinità con il fascismo in certi estremismi di sinistra. Una volta con il “Corriere della Sera” in mano parlammo di un articolo del direttore Spadolini sugli opposti estremismi che corrispondeva a pieno al suo modo di vedere la violenza in quegli anni difficilissimi in cui qualcuno tentò di vedere le lotte studentesche in una sorta di continuità con la Resistenza.
Il latinista Luciano Perelli è stato ricordato al liceo “Carlo Botta” di Ivrea dove nacque nel 1911. Morto trent’anni fa, è ancora molto ricordato dagli ex allievi al liceo Gioberti di Torino e alla Facoltà di Lettere dove insegnò-caso raro- Letteratura latina e successivamente Storia romana alla Facoltà di Magistero. Soprattutto Perelli è ricordato per i suoi libri di testo dalla pregevolissima “Storia della letteratura latina” che non ebbe eguali per decine d’anni ai molti commenti a Cicerone ed agli amatissimi Lucrezio, poeta dell’angoscia e Catullo, poeta dell’amore tenero e disperato. I giovani nei suoi commenti ritrovavano l’humanitas autentica e la storicità di Roma senza l’eccessivo tecnicismo filologico che a volte uccide gli studi classici. Gli allievi di Perelli, similmente a quelli di Concetto Marchesi, acquisivano una cultura classica che era la base di un sapere poliedrico nel quale sarebbero cresciuti. Quando Perelli morì all’improvviso nel 1994, Luciano Canfora scrisse di lui una testimonianza ancora oggi importante che riguarda i suoi “ricordi antifascisti” incentrati sul carcere inflitto dal regime al padre e al fratello, che condizionò i suoi studi per affrettare il suo insegnamento privato, appena superata la Maturità, per dare un sostegno alla famiglia. Tuttavia egli non confuse mai l’insegnamento con un marcato impegno politico, come invece fece Marchesi. L’antifascismo per lui fu una scelta di libertà incompatibile con l’ideologismo anche se seppe difendere le ragioni della scuola classica da chi avrebbe voluto circoscriverla a pochi specialisti, di fatto uccidendola. Giovanna Garbarino, che fu docente di Letteratura latina, mi disse spesso che questa capacità di miscelare insieme letteratura e storia latina e greca era la cifra straordinaria di Luciano, forse non abbastanza apprezzato in Facoltà. Quando ancora insegnava al liceo, seppe difendere con coraggio ed anticonformismo la dignità professionale dei professori dalla tendenza già allora emergente di considerarli degli impiegati. La tutela della funzione docente fu una delle sue più grandi preoccupazioni e anche questo rende Perelli un protagonista unico della scuola piemontese. Egli capì fin dal suo sorgere l’aspetto eversivo di una parte della contestazione giovanile del ’68 insieme ai colleghi Franco Venturi, grande storico dell’Illuminismo e Giorgio Gullini, archeologo e preside della Facoltà di Lettere. Giunse a vedere delle affinità con il fascismo in certi estremismi di sinistra. Una volta con il “Corriere della Sera” in mano parlammo di un articolo del direttore Spadolini sugli opposti estremismi che corrispondeva a pieno al suo modo di vedere la violenza in quegli anni difficilissimi in cui qualcuno tentò di vedere le lotte studentesche in una sorta di continuità con la Resistenza.
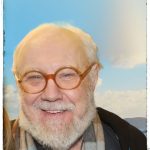
Sono già cominciate a Bra le manifestazioni commemorative dei fratelli Carando, trucidati dai fascisti il 5 febbraio 1945 a Villafranca Piemonte, zona dove Pompeo Colajanni, ”Barbato” ,aveva costituito-lui ufficiale al “Nizza Cavalleria” della vicina Pinerolo-una banda armata garibaldina che si rivelò una vera e propria punta di diamante nella Resistenza non soltanto piemontese. Ennio ed Ettore Carando ,fratelli con idee e vite diverse, furono accomunati da una morte atroce nella condivisione degli ideali di libertà propri della migliore Resistenza piemontese. Ennio , un apprezzato professore di filosofia quasi cieco che aveva insegnato a Savona ed era autore di saggi filosofici , divenne ispettore del Raggruppamento delle divisioni “Garibaldi” nel Cuneese.
Secondo una versione era un militante comunista ,mentre secondo altri aveva esitato a mettersi con i comunisti, chiedendo lumi nel 1943, già prima della Resistenza, al filosofo Piero Martinetti . Lo stesso dubbio lo ebbe il filosofo della scienza Ludovico Geymonat che parlerà del valore socratico dell’ opera filosofica di Ennio. Martinetti disse loro che il dovere dell’antifascismo era superiore ad ogni altra ragione. In tempi recenti ho appreso da un nipote dei due partigiani che Ennio era, nel periodo del partigianato, in stretti rapporti con il futuro leader politico Antonio Giolitti, nipote del grande statista liberale, che con le sue scelte dimostrò il suo rifiuto di ogni forma di stalinismo. Ettore era un ufficiale di artiglieria, sposato da poco tempo, che come tanti ufficiali fedeli al giuramento prestato sentì la Resistenza anche come un nuovo Risorgimento.
In una lettera alla moglie, che ebbi modo di conoscere ,espresse il suo dovere di soldato di liberare il suolo patrio dall’oppressione straniera che può farlo accostare anche nel portamento ad un eroe del Risorgimento. Nel contempo egli le scrisse tutto il dolore del distacco da lei con parole di intensa umanità. La vedova non volle risposarsi e visse nel ricordo disperato del marito. I due fratelli, uniti dalla morte, non vennero invece accomunati nel riconoscimento del loro sacrificio. Ad Ennio venne conferita con una bella motivazione che si trova in Internet, la Medaglia d’Oro alla memoria, mentre ad Ettore solo la Medaglia d’Argento.
Una disparità di trattamento che stupì allora e continua ancora a stupire oggi. Nessuna voce specifica è stata dedicata ad Ettore che viene citato insieme a quella dedicata al fratello. Vittorio Prunas Tola, capo dei gruppi d’ Unione “Camillo di Cavour” e combattente per la libertà a fianco dei suoi figli proprio a Villafranca evidenziò già molti anni fa questa diversità di trattamento, ricordando il partigiano caduto con le stellette del soldato. Anche Davide Lajolo si disse stupito. Forse sarebbe giusta nell’ottantesimo della Liberazione maggiore attenzione al capitano Carando, non conosciuto al mondo intellettuale come il fratello, ma egualmente meritevole di riconoscimento.
 Città dei crocieristi, delle torri e dei Papi, Savona è una bella città, facile da visitare per chi ha poco tempo. Il piccolo centro storico si gira agevolmente a piedi tra vicoli stretti, palazzi colorati e lunghe vie centrali come via Paleocapa. Per raggiungere tutte le altre località del Ponente è quasi d’obbligo passare da Savona ma spesso la città viene considerata solo un luogo di passaggio, sovente ignorata e trascurata. È uno sbaglio, andrebbe visitata e goduta anche Savona. Viene chiamata la Città dei Papi perché nei dintorni di Savona nacquero ben due Papi, Sisto IV, Francesco della Rovere (1414-1484), il pontefice che commissionò la Cappella Sistina di Roma e Giulio II, Giuliano della Rovere (1443-1513). Una piccola cappella Sistina c’è anche a Savona, accanto alla cattedrale dell’Assunta, fatta edificare proprio da Sisto IV come cappella funeraria per i suoi genitori. Non è certo paragonabile alla cappella omonima romana ma è comunque un’attrazione da non perdere. Si può visitarla sabato 10-12,30 e 16,00-18,00 e domenica 10-12 e 16-18, le visite pomeridiane sono sospese a luglio e agosto. Il Duomo, realizzato nel Seicento accanto alla cappella, si può vedere quando non sono in corso le funzioni religiose per ammirare gli affreschi di scuola genovese e savonese, l’organo voluto da Papa Sisto IV e gli appartamenti papali dove un altro Papa, Pio VII, fu rinchiuso come prigioniero di Napoleone ai primi dell’Ottocento. Ma il simbolo più importante della città è però la Torre del Brandale al porto, a Campanassa per i savonesi, la torre più importante tra le diverse torri della città. Innalzata nel Trecento, la campana suona quando in città succede qualcosa di importante. Ma accanto alla torre si anima un intero centro storico che merita una visita. A pochi metri svettano le
Città dei crocieristi, delle torri e dei Papi, Savona è una bella città, facile da visitare per chi ha poco tempo. Il piccolo centro storico si gira agevolmente a piedi tra vicoli stretti, palazzi colorati e lunghe vie centrali come via Paleocapa. Per raggiungere tutte le altre località del Ponente è quasi d’obbligo passare da Savona ma spesso la città viene considerata solo un luogo di passaggio, sovente ignorata e trascurata. È uno sbaglio, andrebbe visitata e goduta anche Savona. Viene chiamata la Città dei Papi perché nei dintorni di Savona nacquero ben due Papi, Sisto IV, Francesco della Rovere (1414-1484), il pontefice che commissionò la Cappella Sistina di Roma e Giulio II, Giuliano della Rovere (1443-1513). Una piccola cappella Sistina c’è anche a Savona, accanto alla cattedrale dell’Assunta, fatta edificare proprio da Sisto IV come cappella funeraria per i suoi genitori. Non è certo paragonabile alla cappella omonima romana ma è comunque un’attrazione da non perdere. Si può visitarla sabato 10-12,30 e 16,00-18,00 e domenica 10-12 e 16-18, le visite pomeridiane sono sospese a luglio e agosto. Il Duomo, realizzato nel Seicento accanto alla cappella, si può vedere quando non sono in corso le funzioni religiose per ammirare gli affreschi di scuola genovese e savonese, l’organo voluto da Papa Sisto IV e gli appartamenti papali dove un altro Papa, Pio VII, fu rinchiuso come prigioniero di Napoleone ai primi dell’Ottocento. Ma il simbolo più importante della città è però la Torre del Brandale al porto, a Campanassa per i savonesi, la torre più importante tra le diverse torri della città. Innalzata nel Trecento, la campana suona quando in città succede qualcosa di importante. Ma accanto alla torre si anima un intero centro storico che merita una visita. A pochi metri svettano le  torri, più basse, Guarnero e Corsi, e poco più in là, all’ingresso di via Paleocapa, fa bella mostra di sé la Torre Leon Pancaldo che, eretta alla fine del Trecento, faceva parte della cinta muraria. A picco sul mare c’è l’imponente e straordinaria fortezza del Priamàr, eretta dai genovesi nel Cinquecento per proteggere la città dagli attacchi dal mare. Il porto fu interrato e sul colle del Priamàr venne costruita la piazzaforte dopo aver abbattuto l’antica cattedrale, tre ospedali, la chiesa e il convento dei Domenicani e diversi oratori. Scomparve in pratica la parte più importante della città di epoca medioevale. Gli storici fanno notare che nel Duecento a Savona si trovavano almeno 50 torri e una decina si innalzavano sul Priamàr. La fortezza, che conserva i pochi resti dell’antica cattedrale cittadina, fu anche carcere con Giuseppe Mazzini in cella. Oggi è un grande teatro all’aperto con spettacoli e concerti per tutta l’estate e ospita il Museo archeologico e il Museo Sandro Pertini. Infine, da gustare in tutti i sensi, la Vecchia Darsena con il porticciolo turistico a pochi minuti dal Priamàr, luogo di incontro di savonesi e turisti a spasso tra pescherecci, ristoranti e trattorie. Filippo Re
torri, più basse, Guarnero e Corsi, e poco più in là, all’ingresso di via Paleocapa, fa bella mostra di sé la Torre Leon Pancaldo che, eretta alla fine del Trecento, faceva parte della cinta muraria. A picco sul mare c’è l’imponente e straordinaria fortezza del Priamàr, eretta dai genovesi nel Cinquecento per proteggere la città dagli attacchi dal mare. Il porto fu interrato e sul colle del Priamàr venne costruita la piazzaforte dopo aver abbattuto l’antica cattedrale, tre ospedali, la chiesa e il convento dei Domenicani e diversi oratori. Scomparve in pratica la parte più importante della città di epoca medioevale. Gli storici fanno notare che nel Duecento a Savona si trovavano almeno 50 torri e una decina si innalzavano sul Priamàr. La fortezza, che conserva i pochi resti dell’antica cattedrale cittadina, fu anche carcere con Giuseppe Mazzini in cella. Oggi è un grande teatro all’aperto con spettacoli e concerti per tutta l’estate e ospita il Museo archeologico e il Museo Sandro Pertini. Infine, da gustare in tutti i sensi, la Vecchia Darsena con il porticciolo turistico a pochi minuti dal Priamàr, luogo di incontro di savonesi e turisti a spasso tra pescherecci, ristoranti e trattorie. Filippo Re
nelle foto:
la Fortezza del Priamàr a Savona
La Torre del Brandale con le torri minori
Interno della Cappella Sistina accanto alla Cattedrale
Il villaggio Leumann è una originale borgata operaia del comune di Collegno, alle porte di Torino, costruita a fine Ottocento per volere dell’imprenditore e filantropo svizzero Napoleone Leumann
Il villaggio operaio è una vera opera d’arte , che nulla ha a che fare con le moderne periferie industriali, simbolo concreto di una cultura del lavoro e dell’umanesimo di imprenditori illuminati che non pensavamo solo al profitto . Ma e anche l’esempio di un mondo popolare che aveva valori e principi e non era una plebe abbrutita e emarginata di cui purtroppo sono popolate oggi certe banlieue. L’edilizia industriale si trasforma così in arte, e ancora oggi attira gli sguardi dei curiosi per la sua particolare architettura.
Una mostra evento al Polo del 900 di Torino (Palazzo San Daniele, Piazzetta Franco Antonicelli ) vuole raccontare questo passato glorioso, di un uomo con una vision moderna e innovativa, concretizzatasi nel Villaggio Leumann
La mostra “Villaggio Leumann, da 150 anni passato e futuro si incontrano”, inaugurata a Torino è organizzata dall’Associazione Culturale Kòres, e fa parte dei progetti che inizieranno ad aprile 2025 per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Villaggio Leumann, rendendo ogni visita un’esperienza unica e indimenticabile, dando priorità al coinvolgimento del visitatore e coniugando la cultura del passato con tecnologie attuali, che esaltino le bellezze e le prerogative del luogo in modo sostenibile e non invasivo.
In mostra fotografie di Renzo Miglio, foto d’epoca, documenti inediti tratti del carteggio tra Leumann e Fenoglio, il grande architetto torinese del liberty , manifesti e tanti oggetti che testimoniano la storia del villaggio e dell’opificio, provenienti da archivi privati e mai esposti al pubblico.
E’ stato anche presentato in anteprima il progetto V.O.C.A.LE (Villaggi Operai, Cultura ed Arte al Leumann), vincitore del bando “Ecosistemi Culturali” di Fondazione CDP – l’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che partirà ad aprile 2025 e metterà a disposizione di tutti coloro che vorranno visitare il villaggio Leumann un’applicazione ad alto impatto emozionale. Intanto il comune di Collegno sta spendendo oltre tre milioni di euro per il rinnovamento del Villaggio
Come parte integrante del progetto, verranno attivati contatti e scambi con altre realtà di villaggi industriali europei per mettere in luce la complessità e le valenze del fenomeno del paternalismo industriale e per far
Dopo questa giornata d’inaugurazione, ci saranno alcuni incontri di approfondimento sulla storia del Villaggio Leumann:
• Martedi 17 dicembre 2024 alle ore 18: Marco Revelli, storico, politologo e giornalista parlerà de “La cultura operaia del lavoro nella Torino delle origini”
• Giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 18: Gianni Oliva, storico, docente e giornalista terrà un incontro su “Il Villaggio sociale di Napoleone Leumann”. In serata ci sarà la Premiazione dei vincitori del workshop organizzato dal Fotogruppo l’Incontro di Collegno.
Napoleone Leumann fece costruire intorno al suo Cotonificio, primaria industria tessile dell’epoca, un complesso residenziale e assistenziale per gli operai che lavoravano nella fabbrica: una città nella città. Il villaggio fu progettato tra il 1875 e il 1907 dall’ingegnere igienista Pietro Fenoglio. Lo stile è Liberty e coinvolge circa 60 edifici, su una superficie di oltre 70 mila metri quadrati.
