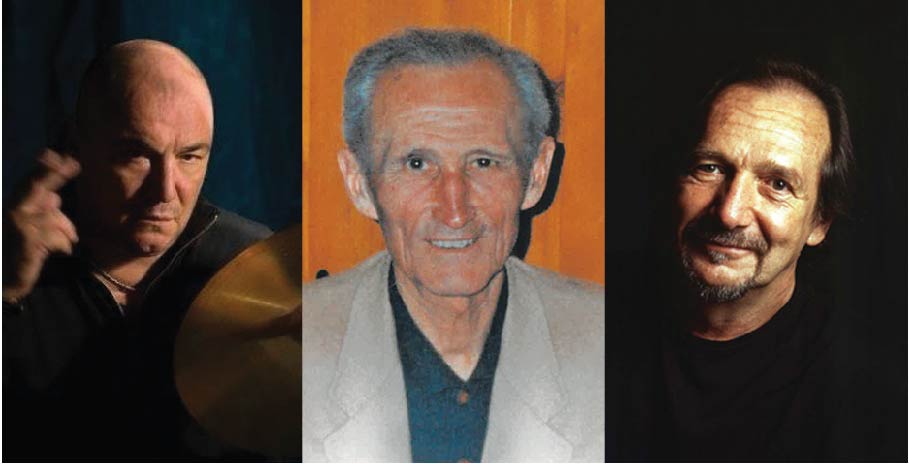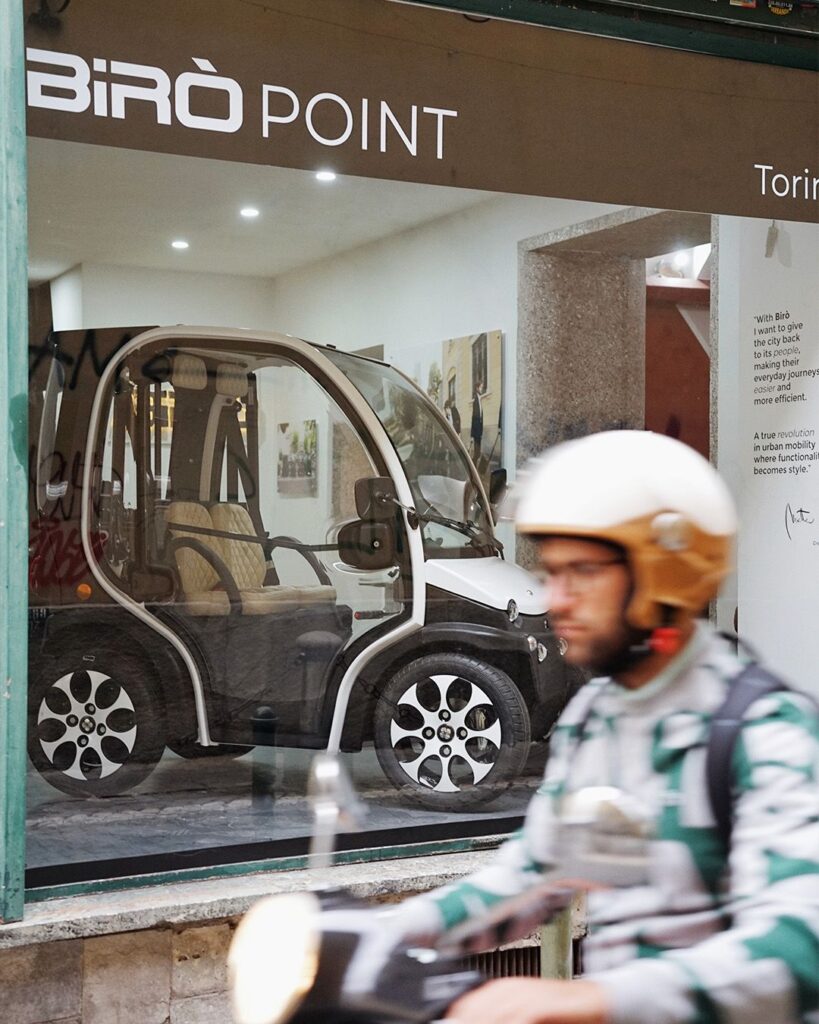L’evento privato tenutosi sabato 17 settembre ha visto la presenza di numerose personalità
Un ampio parterre di circa 400 invitati scelti tra le personalità più rappresentative di Torino e del Piemonte si sono date appuntamento a Lombriasco per celebrare ‘Vocinsieme per Nonno Mario’, un grande evento privato con cui ‘Giubileo’, la storica e prestigiosa onoranza funebre torinese, ha voluto celebrare le proprie radici.
E al contempo guardare al futuro, presentando, in vista dei propri primi 25 anni che cadranno nel 2023, il nuovo Polo Culturale ‘Giubileo Incontri’: una struttura avveniristica tutta dedicata alla promozione e valorizzazione della cultura in città.
La serata ha visto la partecipazione di tre grandi artisti della musica leggera italiana: Valerio Liboni, Andrea Mingardi & The Rossoblues Brothers Band, e a sorpresa l’intenso autore e cantautore Danilo Amerio, salito sul palco tra la meraviglia degli ospiti.
Moltissimi i nomi di punta della politica e dell’imprenditoria regionale, tra cui Gioacchino Cuntrò, il Viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin, Daniele Ronco e Doriano Mina (Sindaco e Vice Sindaco di Lombriasco), Giorgio Albertino (Sindaco di Carignano), Agostino Bottano (Sindaco di Villafranca Piemonte).
Insieme a un gran numero di famosi medici, giornalisti e direttori di testate, commercialisti, avvocati, notai, dirigenti d’azienda e titolari di rinomate PMI pronti a fare squadra, con la Famiglia Scarafia fondatrice e anima di ‘Giubileo’, attorno a un progetto aggregativo vincente, che ha tutte le carte in regola per creare altresì nuova occupazione sotto la Mole.
La serata è stata condotta da Maurizio Scandurra, giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico noto per le sue frequenti apparizioni anche a ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ insieme a Luciano Scarafia, Fondatore con la moglie Piera di ‘Giubileo Srl’.
“Un evento memorabile, ricco di colpi di scena, risate, allegria, che testimonia e conferma l’intelligenza di un’impresa familiare che ha fatto dell’umiltà, della qualità e dell’operosità costante e crescente la propria bandiera. E’ stato straordinario toccare con mano quanta vita si nasconde in un’azienda così fresca e pulsante, attorno alla quale si sono radunate le figure d’eccellenza della Torino e del Piemonte che conta. Un grazie speciale anche a Giacomino Ariatello, Presidente della Pro Loco di Lombriasco, e a tutta la sua ottima squadra per la collaborazione, e alla Dottoressa Virginia Sanchesi per la grandissima e preziosa collaborazione nella creazione di un parterre di invitati illustri intervenuti per l’occasione”, conclude entusiasta Scandurra.