Per la regia teatrale dello spettacolo RUMORI FUORI SCENA prodotto dal Teatro Stabile Di Torino – Teatro Nazionale
Ecco le motivazioni al premio
Da anni ormai Valerio Binasco spicca tra gli esponenti della migliore
tradizione di interpretazione amorevole e creativa dei testi, nel solco dei suoi
maestri Marco Sciaccaluga e Carlo Cecchi e, dietro di loro, dei riformatori del
teatro del dopoguerra, Visconti e Strehler. In una ricca carriera, Binasco ha
affrontato classici, dai greci a Shakespeare e Molière, e contemporanei come
l’irlandese Martin McDonagh o il norvegese Jon Fosse, ovvero come la sua
amata e assai congeniale Natalia Ginzburg, di cui il 15 giugno ha recuperato
“L’intervista”, primo spettacolo in sala post-pandemia presso lo Stabile di
Torino di cui è apprezzatissimo direttore artistico.


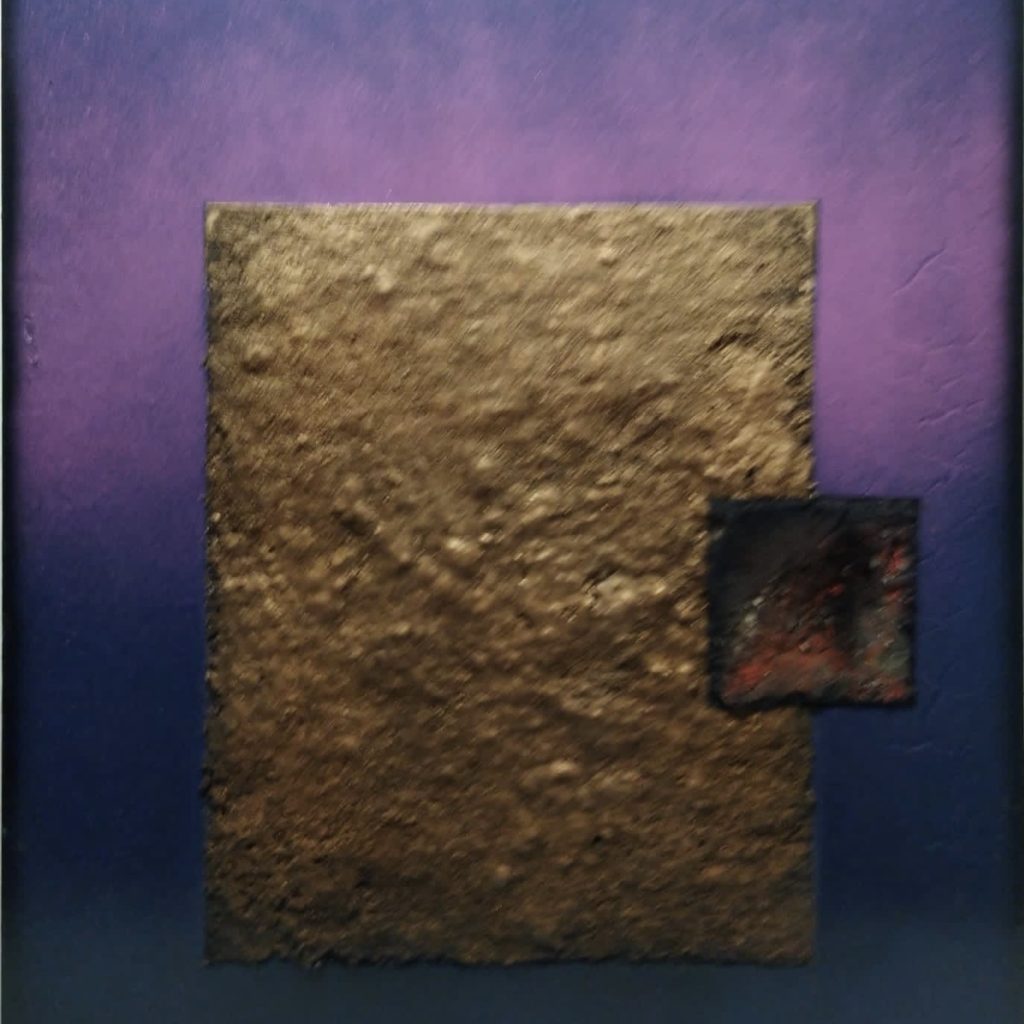


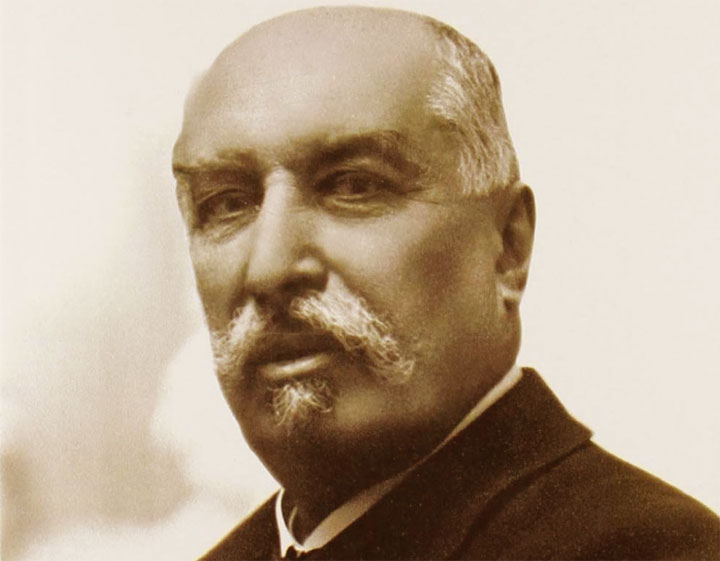
 Giolitti era contrario all’intervento perché riteneva che si potesse ottenere “parecchio“ dall’Austria attraverso le trattative diplomatiche. Forse era inevitabile quell’intervento in guerra, al di là del compimento del Risorgimento con la quarta guerra di indipendenza. Ma certamente l’Italia, pur vittoriosa nel 1918, uscì sconvolta da quella guerra. La crescita di benessere realizzata durante i governi giolittiani si era fermata. Divampava nel Paese un forte disagio sociale. La guerra aveva toccato quasi tutte le famiglie e la spagnola aveva mietuto le stesse vittime delle trincee.
Giolitti era contrario all’intervento perché riteneva che si potesse ottenere “parecchio“ dall’Austria attraverso le trattative diplomatiche. Forse era inevitabile quell’intervento in guerra, al di là del compimento del Risorgimento con la quarta guerra di indipendenza. Ma certamente l’Italia, pur vittoriosa nel 1918, uscì sconvolta da quella guerra. La crescita di benessere realizzata durante i governi giolittiani si era fermata. Divampava nel Paese un forte disagio sociale. La guerra aveva toccato quasi tutte le famiglie e la spagnola aveva mietuto le stesse vittime delle trincee.

 L’occasione si è presentata dopo aver conosciuto il libro della Volpi che ha accettato di scrivere un racconto con un inedito caso da risolvere.
L’occasione si è presentata dopo aver conosciuto il libro della Volpi che ha accettato di scrivere un racconto con un inedito caso da risolvere.
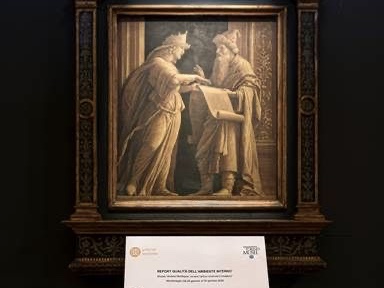

 come accadrà con Travaglio ed altri. Di questo Gino era ben consapevole, aveva scrupoli morali precisi che gli facevano molto onore. Apostolo fu sempre molto attento ed equilibrato, direi sempre equo e prudente. Non cercò mai lo scoop. E questo è un merito che lo distingue e fa di lui un maestro di giornalismo. Mi è stato anche vicino per anni per il Centro Pannunzio che non poteva frequentare, ma che sentiva vicino alle sue idee di liberal- socialista. Si è molto dedicato alla tutela dei giornalisti ricoprendo cariche nazionali nell’Ordine fino a tarda età, malgrado una malattia lo avesse debilitato. Era un uomo di animo gentile e disponibile con cui si poteva parlare. Sarebbe giusto celebrarlo come attore e giornalista. La sua gentilezza era quasi inversamente proporzionale alla sua corporatura imponente. Di lui mi parlò molte volte assai bene Ferruccio Borio che fu redattore capo della Cronaca della “Stampa” e anche il comune amico Edo Ballone. Un mondo giornalistico che non esiste più perché quello stile è evaporato. Oggi ci sono, come diceva Salvatore Tropea in anni passati, soprattutto persone a libro paga che imperversano e screditano il vero giornalismo.
come accadrà con Travaglio ed altri. Di questo Gino era ben consapevole, aveva scrupoli morali precisi che gli facevano molto onore. Apostolo fu sempre molto attento ed equilibrato, direi sempre equo e prudente. Non cercò mai lo scoop. E questo è un merito che lo distingue e fa di lui un maestro di giornalismo. Mi è stato anche vicino per anni per il Centro Pannunzio che non poteva frequentare, ma che sentiva vicino alle sue idee di liberal- socialista. Si è molto dedicato alla tutela dei giornalisti ricoprendo cariche nazionali nell’Ordine fino a tarda età, malgrado una malattia lo avesse debilitato. Era un uomo di animo gentile e disponibile con cui si poteva parlare. Sarebbe giusto celebrarlo come attore e giornalista. La sua gentilezza era quasi inversamente proporzionale alla sua corporatura imponente. Di lui mi parlò molte volte assai bene Ferruccio Borio che fu redattore capo della Cronaca della “Stampa” e anche il comune amico Edo Ballone. Un mondo giornalistico che non esiste più perché quello stile è evaporato. Oggi ci sono, come diceva Salvatore Tropea in anni passati, soprattutto persone a libro paga che imperversano e screditano il vero giornalismo.
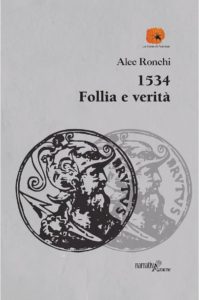 Progetto Cantoregi presenta a Racconigi il nuovo romanzo storico di Alec Ronchi, pseudonimo di Andrea Piovano. Sabato 4 luglio, ore 18,30. Racconigi (Cn)
Progetto Cantoregi presenta a Racconigi il nuovo romanzo storico di Alec Ronchi, pseudonimo di Andrea Piovano. Sabato 4 luglio, ore 18,30. Racconigi (Cn)