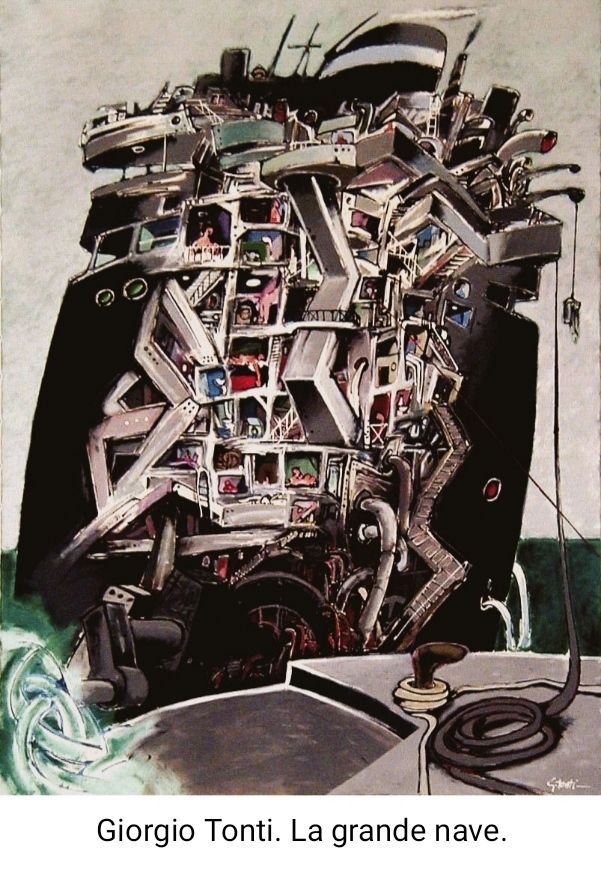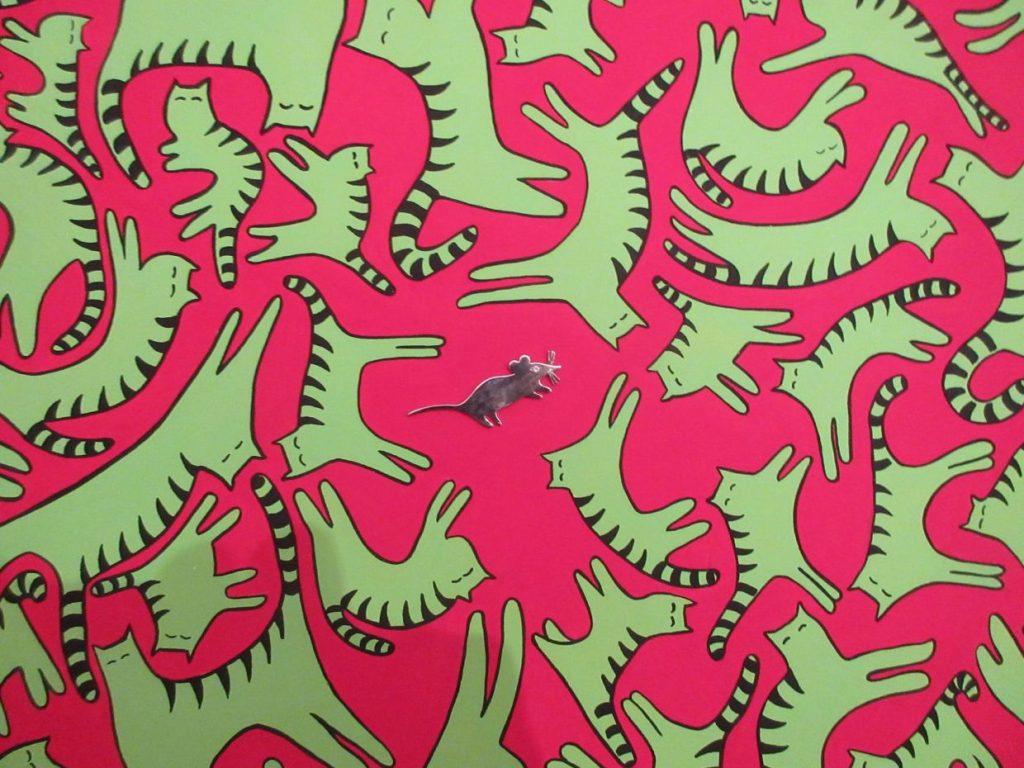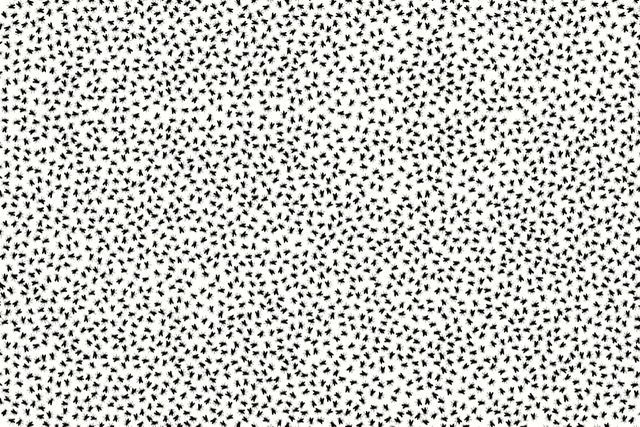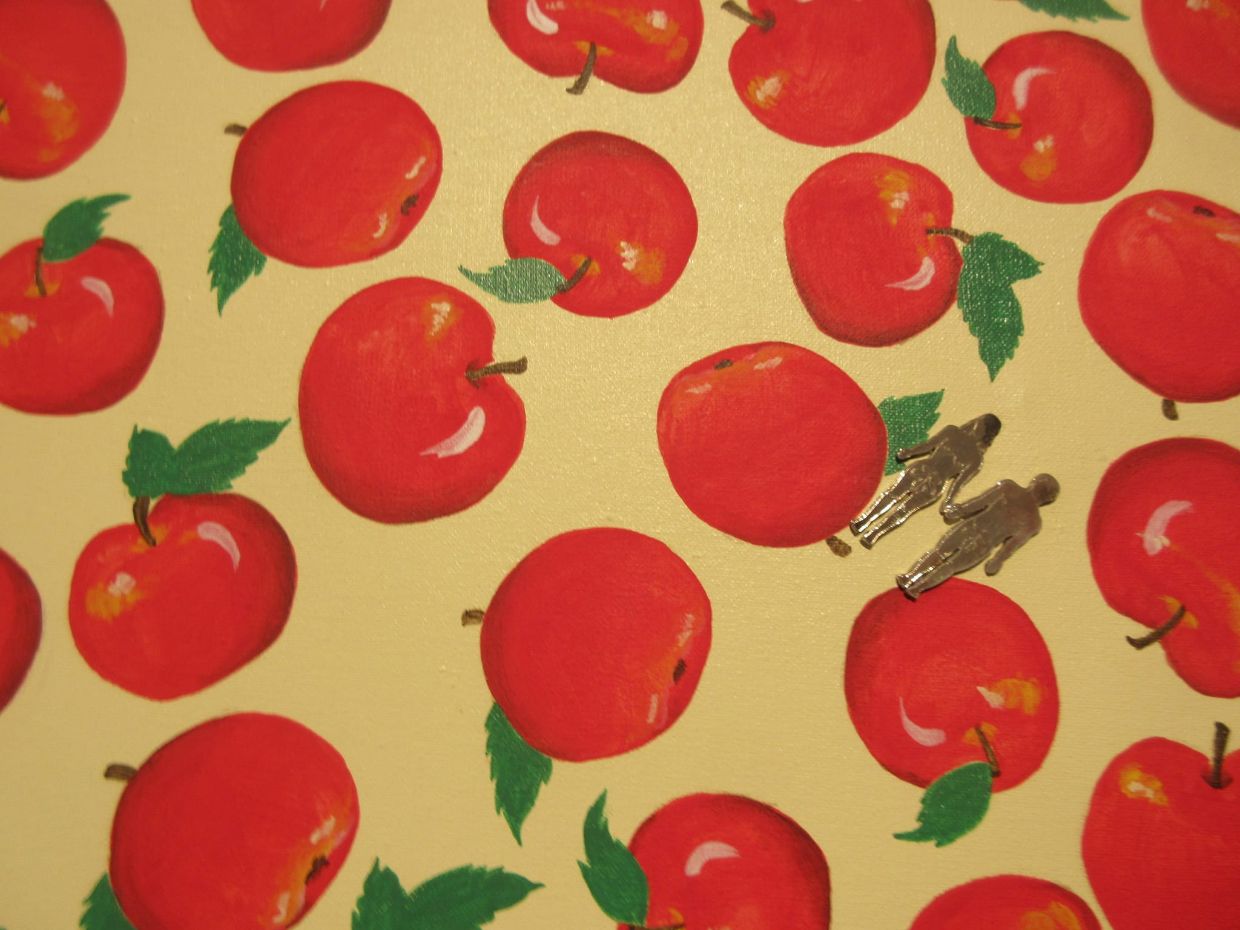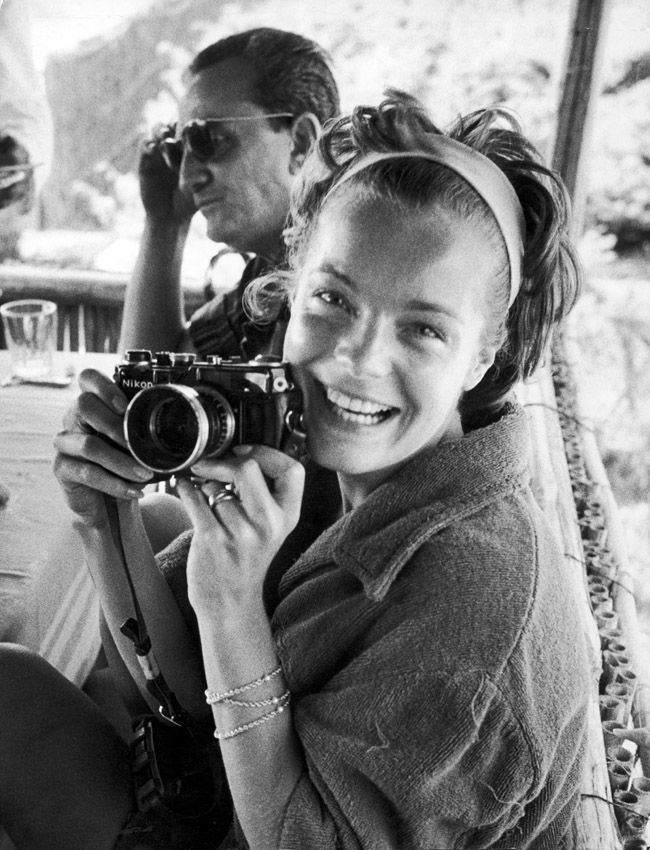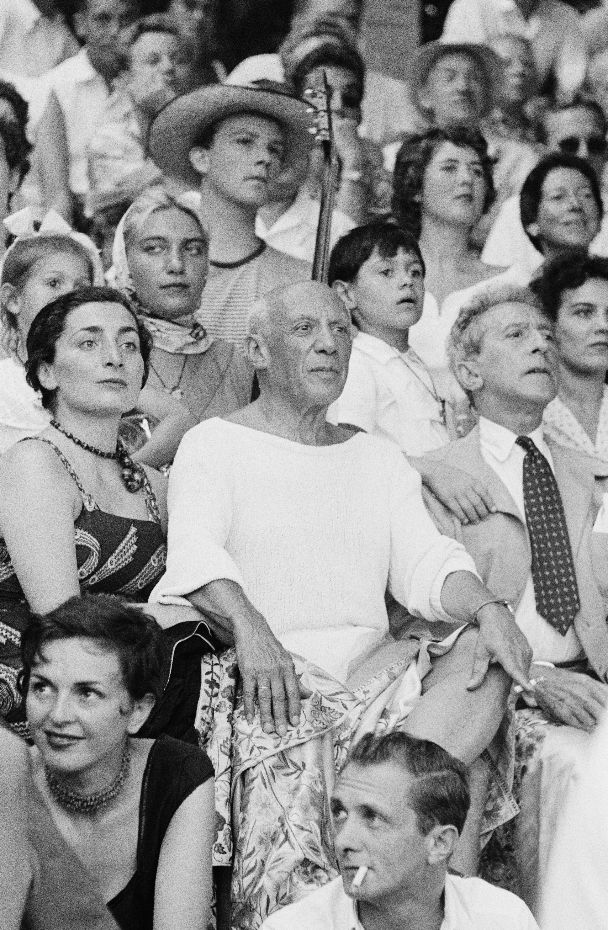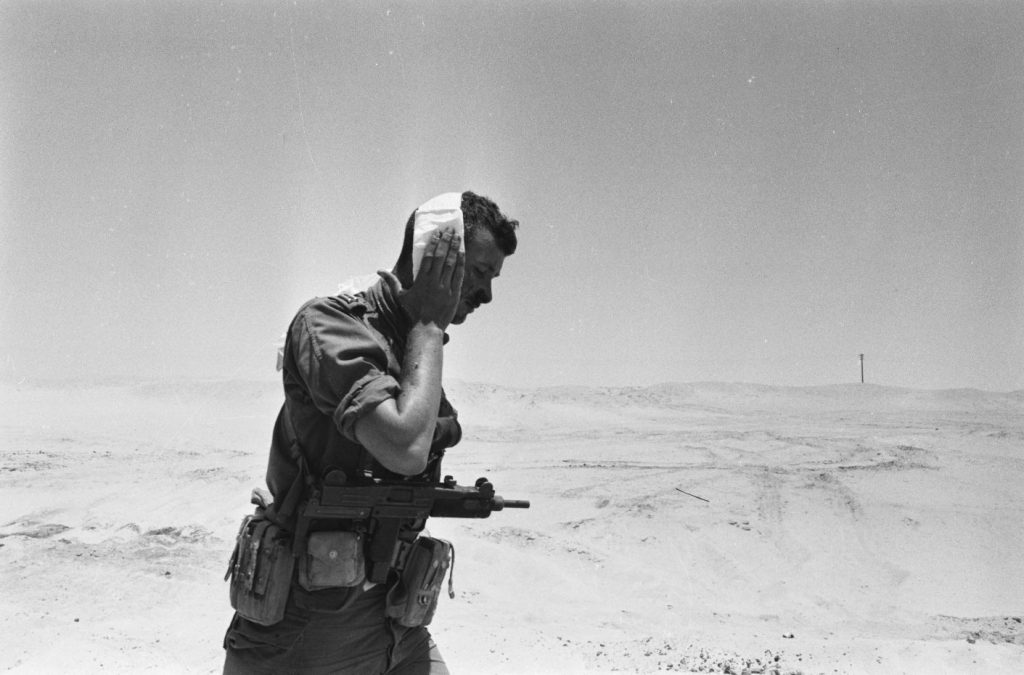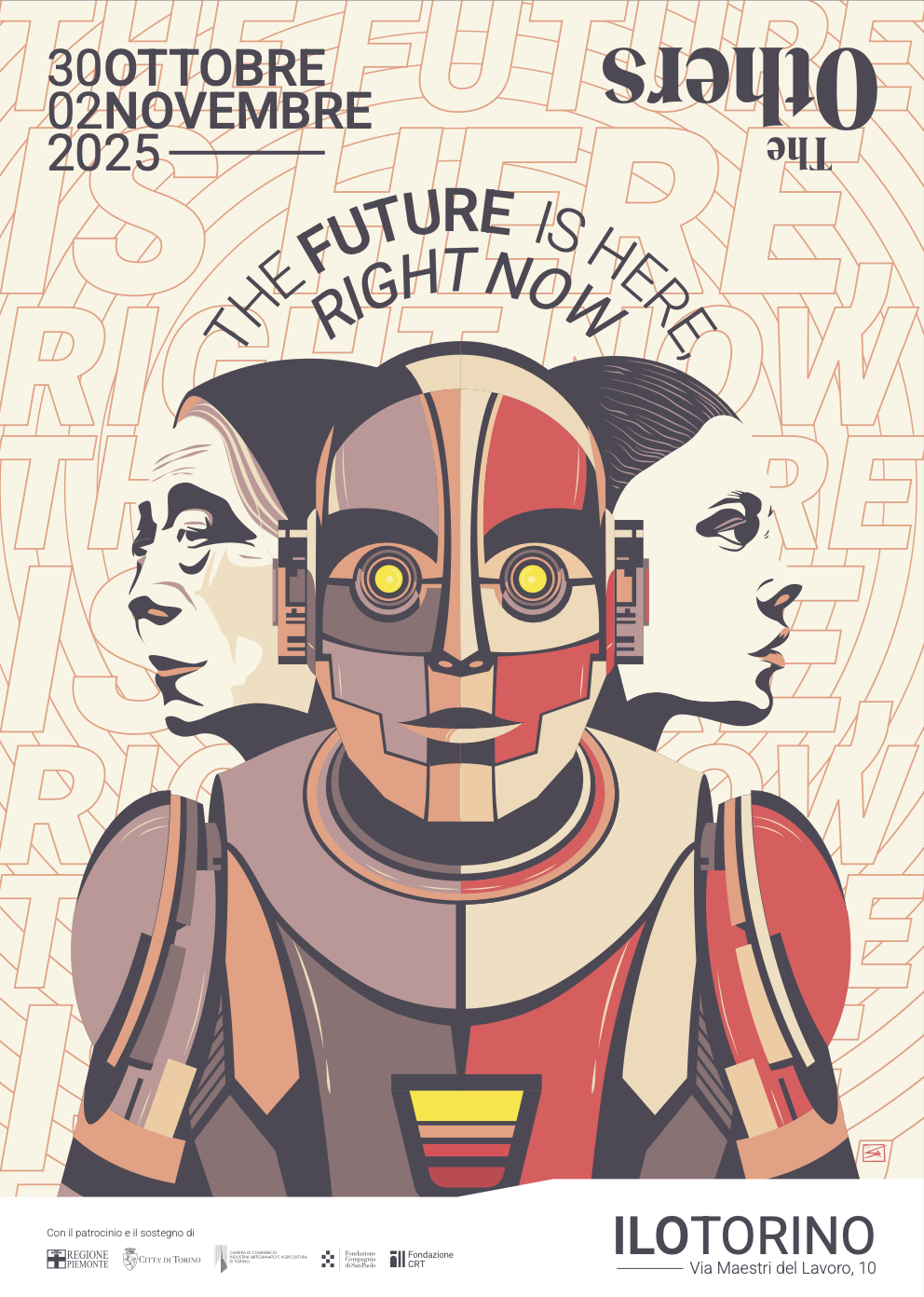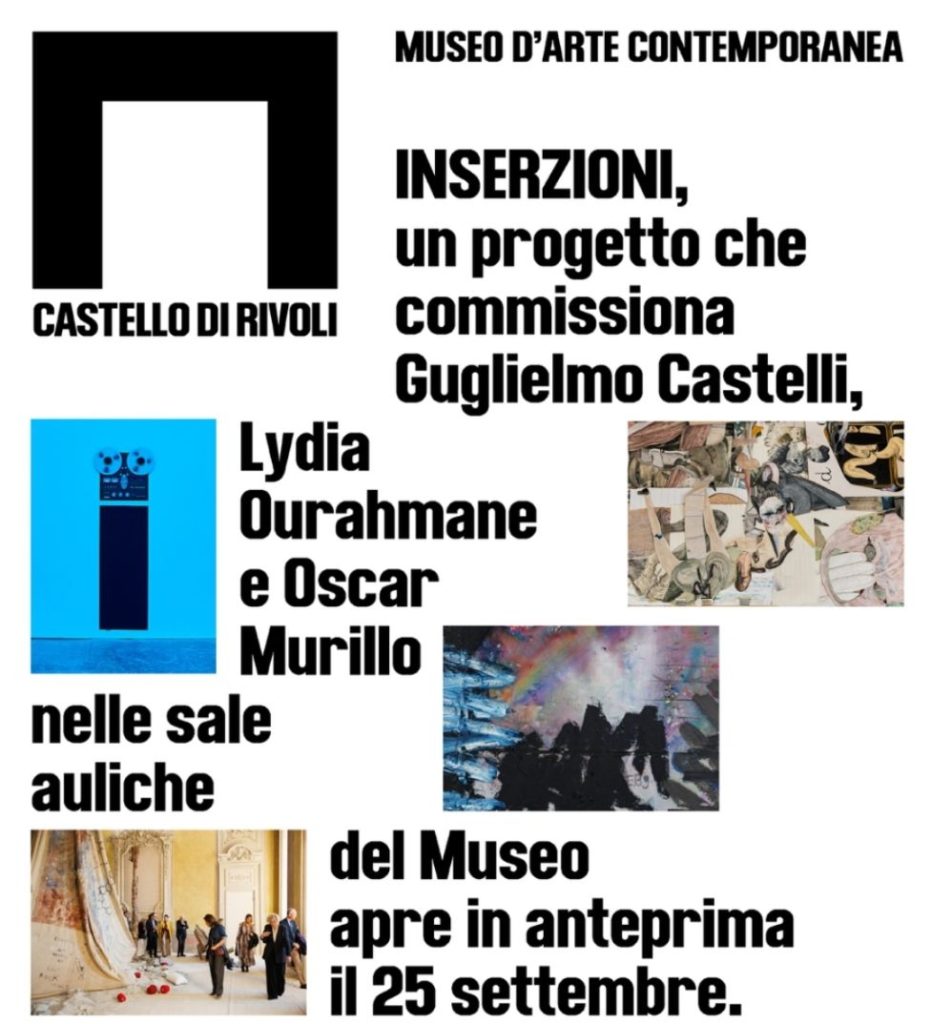Domenica 5 ottobre 2025, Rosignano Monferrato celebra la 30ª edizione di Vendemmia in Arte con un programma che intreccia approfondimento, valorizzazione territoriale e spettacolo. Al centro della giornata: la tavola rotonda dedicata al futuro dell’enoturismo, l’Infernot Wine Festival con la Banca del Vino e, nel pomeriggio, il concerto di Giorgio Conte in trio – Sconfinando Tour 2025 in Piazza XI Settembre (ore 16.00, ingresso libero; in caso di pioggia al Teatro Ideal).
La mattinata si aprirà alle ore 10.00 al Teatro Ideal con la tavola rotonda:
“Vino, mercato ed enoturismo in Monferrato. La tendenza del calo dei consumi in quale modo può incidere sull’enoturismo nei territori del sito Unesco I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato?”
Un confronto di alto profilo, che vedrà la partecipazione di: Paolo Sabbatini (Università di Torino), Gianpaolo Fassino (Università Piemonte Orientale), Maurizio Gily (Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Giovanna Quaglia (Presidente Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato), Claudio Coppo (Presidente Consorzio Tutela Vini Colline del Monferrato Casalese – Piemonte Land of Wine), Federico Piemonte (Banca del Vino di Pollenzo). La tavola rotonda sarà coordinata dal giornalista Pier Ottavio Daniele.
Al termine, nel cortile d’onore del Palazzo Municipale, spazio al vino e alla convivialità con l’Infernot Wine Festival: un momento che celebra la tradizione locale e che segna un nuovo patto monferrino con la Banca del Vino di Pollenzo.
La festa proseguirà nel pomeriggio con il concerto di Giorgio Conte in trio – Sconfinando Tour 2025, alle ore 16.00 in Piazza XI Settembre, a ingresso libero.
Durante la giornata si ricorderà quarantennale del Consorzio del Barbesino e sarà inaugurato il murales dedicato al senatore Paolo Desana, padre della legge sulle Denominazioni di Origine Controllata, di cui fu promotore e primo firmatario.
“Questa edizione speciale di Vendemmia in Arte mette in risalto il ruolo dell’enoturismo come risorsa strategica per il Monferrato – ha dichiarato Cesare Chiesa, Sindaco di Rosignano Monferrato – con la presenza di autorevoli voci del mondo accademico, la nascita della sede monferrina della Banca del Vino e il contributo artistico di Giorgio Conte vogliamo offrire una giornata che unisce pensiero, cultura e comunità”.
Mara Martellotta