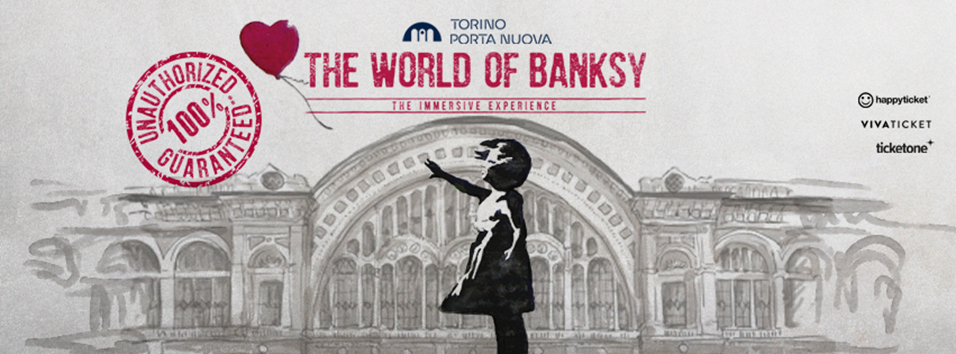Diasporas Now: Rieko Whitfield + Micaela Tobin (White Boy Scream) e Chinabot: Jpn Kasai & Neo Geodesia
Martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2023 ore 18.30
MAO Museo d’Arte Orientale, Torino
Il 24 e 25 gennaio il MAO Museo d’Arte Orientale ospita un doppio appuntamentonell’ambito del public program della mostraBuddha10.
Martedì 24 gennaioore 18.30 saranno ospiti del museo Reiko Whitfield e Miacaela Tobin per una conversazione e narrazioni alternative su identità migranti, background intersezionali, decolonizzazione, self-empowerment, cura e supporto reciproco.
Il termine diaspora è usato in relazione all’arte per parlare di artisti emigrati di prima o successive generazioni, che riprendono e utilizzano le proprie diverse esperienze culturali e identitarie, spesso creando nelle loro opere narrazioni alternative in contrasto a idee e strutture consolidate.
Mai prima d’ora è stato così importante per gli artisti raccontare le loro storie alle proprie condizioni, quindi mettiamoci in ascolto!
In questo pomeriggio molto speciale Rieko Whitfield, artista, scrittrice e musicista giapponese-americana di base a Londra, una delle fondatrici di Diasporas Now, piattaforma di solidarietà diasporica che si occupa di discorsi contemporanei sulle identità migranti, e Micaela Tobin, soprano e sound artist, filippina-americana di prima generazione di base a Los Angeles, presenteranno due dei loro più recenti lavori: due film/opere musicali che partono da mitologie speculative per togliere centralità alle traiettorie storiche del colonialismo eurocentrico.
In parte rituale sonoro, in parte narrazione diasporica, “BAKUNAWA: Opera of the Seven Moons” di Micaela Tobin è un’opera sperimentale e coinvolgente basata sull’omonimo album acclamato dalla critica di Tobin, che rivendica la mitologia pre-coloniale delle Filippine dopo secoli di violenta cancellazione culturale. Raccontando la storia di Bakunawa, un drago simile a un serpente della mitologia filippina, Tobin porta la sua voce al di fuori delle mura imperialistiche del teatro dell’opera e sulla Costa della California di fronte all’Oceano Pacifico – creando un ponte sonoro verso le isole delle Filippine in un atto di guarigione.
“Regenesis: An Opera Tentacular” di Rieko Whitman è una storia sui cicli della vita, sulla morte, sull’importanza della comunità ambientata in un mondo post apocalittico e narrata in modo non lineare tramite l’impersonificazione di avatar soprannaturali. La narrazione in tre atti è ispirata a Izanami, dea shintoista della creazione e della distruzione, che brucia fino a morire per dare vita al mondo. “Regenesis” mette in scena una mitologia speculativa evocando esseri soprannaturali che guariscano il corpo sofferente della terra, attraverso l’utilizzo di metodi di collective care e creando al contempo prototipi alternativi di futuri sostenibili.
Lo screening delle due opere musicali sarà seguito da una talk su temi diasporici in cui interverranno le due artiste, moderato da Ilaria Benini, editor della collana Asia di Add editore, ed esploratrice della scena culturale asiatica contemporanea.
Mercoledì 25 gennaio alle ore 18.30 il MAO ospita invece una serata con Chinabot, collettivo che vuole cambiare la discussione sulla musica asiatica. Canti Khmer, samples di karaoke, musica popolare giapponese, juke e batteria metal.
Sin dal suo lancio l’etichetta-collettivo londinese Chinabot ha ampliato e demistificato la percezione pubblica delle scene musicali sperimentali asiatiche pubblicando opere bizzarre, imprevedibili e innovative di artisti provenienti da varie regioni dell’Asia. Ogni uscita è stilisticamente varia e significativamente concettualizzata attraverso riferimenti culturali locali, esperienze di ascolto immersive che sono più adatte per il teatro d’avanguardia che per i club.
L’etichetta lavora per dare spazio alle varie unicità del continente asiatico a livello di culture, tradizioni e generi (sia musicali che identitari) e per dare spazio agli artisti provenienti dai paesi in via di sviluppo dell’Asia. Ciò include come parte del suo modus operandi uno sforzo per l’ampliamento della conoscenza del continente che vada al di là delle scene giapponesi e cinesi, che ormai da tempo rappresentano la produzione creativa dell’Asia sulla scena mondiale, e la rappresentazione di temi di attualità e politica asiatica. Gran parte della produzione di Chinabot è infatti tematica, incentrata su governi, geopolitica e ambiente nel tentativo di stimolare la discussione e far luce su questioni sottorappresentate con artisti le cui opere abbracciano argomenti come disordini nazionali, decolonizzazione, femminismo, fluidità di genere e futurismo cyborg.
Per questa serata speciale il MAO ospita unaselezione di videoclip di artisti Chinabot e una talk con Saphy Vong, fondatore dell’etichetta, eGiulia Mengozzi, assistente curatrice presso il PAV Parco Arte Vivente, parte di ALMARE, collettivo dedicato alle pratiche contemporanee che usano il suono come mezzo espressivo, e di AWI – Art Workers Italia.
A seguire il concerto in streaming da Kyoto di JPN Kasai, che abbina musica popolare giapponese Ondo e Minyo a juke e footwork minimali, ed un live dello stesso Vong che mixa samples di canti Khmer, karaoke e batteria metal sotto lo pseudonimo di Neo Geodesia.
*Entrambi gli incontri si svolgeranno in inglese
Info e prenotazioni:eventiMAO@fondazionetorinomusei.it
Costo per i due eventi: 15 € intero | 10 € ridotto studenti




 La mostra inaugura il 2023 della “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile” di Chieri (Torino) e rappresenta una ghiotta occasione per ammirare, negli spazi della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), immagini fotografiche e film d’autore del fiorentino Rossano B. Maniscalchi, pluripremiato fotografo e film maker di fama internazionale, senatore accademico onorario della “Medici International Academy” di Firenze e autore di celeberrimi “ritratti” scattati, fra gli altri, ai più importanti “Premi Nobel” internazionali, da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, da Rigoberta Menchù al 14° Dalai Lama. In rassegna, fino a sabato 28 gennaio, ad accogliere i visitatori sono diversi filmati proiettati in loop che fanno da contrappunto a 15 scatti fotografici di Maniscalchi generosamente prestati alla “Fondazione” dalla storica azienda tessile chierese “Angelo Vasino S.p.a.” e realizzati nella stessa azienda di corso Torino 62, con l’eccezionale bravura dell’artista che sa, attraverso la concreta ricezione delle cose, leggere le infinite possibilità di trasformarle in sogni, in memorie, in mondi “altri” in cui lasciarsi guidare senza richiesta alcuna di suggerimenti e appigli esterni. Liberi nella più totale fascinosa e provocatoria immaginazione. “Attraverso l’obiettivo– si legge in una nota stampa – una ‘allure’ particolare si sprigiona dalle rocche colorate che alimentano un orditoio, fili che avvolgono un subbio o scorrono fra i licci di telai oggidiani, dove mani giovani e meno giovani di operatori esperti infondono nuova linfa vitale a un’arte antica, ma nel presente”. In mostra anche telai, orditoi di ultima generazione, immortalati nello stabilimento chierese, fondato nel 1955 da Angelo Vasino con il cognato (“Vasino & Ciaudano”) e oggi guidato dai figli Giuseppe e Renato Vasino, ormai affiancati dalla terza generazione di famiglia, con Giovanni, Valentina e Stefano. Che continueranno a far loro le parole dello scrittore (e politico) di Prato, Edoardo Nesi, fino al 2004 ai vertici dell’azienda tessile di famiglia: “Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore di una tessitura è continuo e inumano, fatto di mille suoni
La mostra inaugura il 2023 della “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile” di Chieri (Torino) e rappresenta una ghiotta occasione per ammirare, negli spazi della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), immagini fotografiche e film d’autore del fiorentino Rossano B. Maniscalchi, pluripremiato fotografo e film maker di fama internazionale, senatore accademico onorario della “Medici International Academy” di Firenze e autore di celeberrimi “ritratti” scattati, fra gli altri, ai più importanti “Premi Nobel” internazionali, da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, da Rigoberta Menchù al 14° Dalai Lama. In rassegna, fino a sabato 28 gennaio, ad accogliere i visitatori sono diversi filmati proiettati in loop che fanno da contrappunto a 15 scatti fotografici di Maniscalchi generosamente prestati alla “Fondazione” dalla storica azienda tessile chierese “Angelo Vasino S.p.a.” e realizzati nella stessa azienda di corso Torino 62, con l’eccezionale bravura dell’artista che sa, attraverso la concreta ricezione delle cose, leggere le infinite possibilità di trasformarle in sogni, in memorie, in mondi “altri” in cui lasciarsi guidare senza richiesta alcuna di suggerimenti e appigli esterni. Liberi nella più totale fascinosa e provocatoria immaginazione. “Attraverso l’obiettivo– si legge in una nota stampa – una ‘allure’ particolare si sprigiona dalle rocche colorate che alimentano un orditoio, fili che avvolgono un subbio o scorrono fra i licci di telai oggidiani, dove mani giovani e meno giovani di operatori esperti infondono nuova linfa vitale a un’arte antica, ma nel presente”. In mostra anche telai, orditoi di ultima generazione, immortalati nello stabilimento chierese, fondato nel 1955 da Angelo Vasino con il cognato (“Vasino & Ciaudano”) e oggi guidato dai figli Giuseppe e Renato Vasino, ormai affiancati dalla terza generazione di famiglia, con Giovanni, Valentina e Stefano. Che continueranno a far loro le parole dello scrittore (e politico) di Prato, Edoardo Nesi, fino al 2004 ai vertici dell’azienda tessile di famiglia: “Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore di una tessitura è continuo e inumano, fatto di mille suoni  metallici sovrapposti, eppure a volte sembra una risata”. Parole in cui c’è tutta la filosofia (azienda non solo business) della “Vasino S.p.a.”. Insieme a quella particolare angolatura poetica, fuori dal tempo e dal mondo, degli scatti grandiosi di Rossano B. Maniscalchi, cui la Città di Chieri, “culla del tessile” dal Medioevo, ha conferito – in occasione della mostra e in memoria proprio di Angelo Vasino – il Premio “Navetta Arcobaleno”, riservato ad artisti distintisi nel coniugare linguaggi multimediali con le arti tessili. “Con questo evento di inizio anno, all’insegna dell’eccellenza – commenta Melanie Zefferino, presidente della ‘Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile’ – la ‘Fondazione’ rinsalda il legame con i propri Soci Fondatori e la comunità del territorio di riferimento facendo luce, attraverso l’arte, sulla produzione tessile contemporanea in una delle sue migliori declinazioni”.
metallici sovrapposti, eppure a volte sembra una risata”. Parole in cui c’è tutta la filosofia (azienda non solo business) della “Vasino S.p.a.”. Insieme a quella particolare angolatura poetica, fuori dal tempo e dal mondo, degli scatti grandiosi di Rossano B. Maniscalchi, cui la Città di Chieri, “culla del tessile” dal Medioevo, ha conferito – in occasione della mostra e in memoria proprio di Angelo Vasino – il Premio “Navetta Arcobaleno”, riservato ad artisti distintisi nel coniugare linguaggi multimediali con le arti tessili. “Con questo evento di inizio anno, all’insegna dell’eccellenza – commenta Melanie Zefferino, presidente della ‘Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile’ – la ‘Fondazione’ rinsalda il legame con i propri Soci Fondatori e la comunità del territorio di riferimento facendo luce, attraverso l’arte, sulla produzione tessile contemporanea in una delle sue migliori declinazioni”.
 Già nel titolo, la rassegna esprime appieno la personalità e lo spirito del grande “Immaginifico” o “poeta – soldato” o “poeta – vate” (allo stesso modo di Giosué Carducci) cui la mostra si ispira. Ospitata in “Palazzo Giusiana” (ex sede del Tribunale) ad Ivrea, da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo, “Vate, Vanitas, Vittoria” è stata ideata per inaugurare la seconda parte dell’anno da “Capitale italiana del libro 2022” di Ivrea – terza capitale dopo Vibo Valentia nel 2021 e Chiari (Brescia) nel 2020 – e per ricordare il centenario della donazione, il 22 dicembre 1923, da parte di Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938), della sua casa-museo (“città nella città”, eretta, a memoria delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, sulle rive del Lago di Garda con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni) allo Stato Italiano. Curata da Costanza Casali, assessore alla Cultura della Città di Ivrea, la mostra presenta opere di Nicola Bolla e Andrea Chisesi e sarà introdotta, sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1), da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente dal 2008 della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, affiancato da Angelo Piero Cappello, studioso del “Vate” abruzzese e direttore del “Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”.
Già nel titolo, la rassegna esprime appieno la personalità e lo spirito del grande “Immaginifico” o “poeta – soldato” o “poeta – vate” (allo stesso modo di Giosué Carducci) cui la mostra si ispira. Ospitata in “Palazzo Giusiana” (ex sede del Tribunale) ad Ivrea, da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo, “Vate, Vanitas, Vittoria” è stata ideata per inaugurare la seconda parte dell’anno da “Capitale italiana del libro 2022” di Ivrea – terza capitale dopo Vibo Valentia nel 2021 e Chiari (Brescia) nel 2020 – e per ricordare il centenario della donazione, il 22 dicembre 1923, da parte di Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938), della sua casa-museo (“città nella città”, eretta, a memoria delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, sulle rive del Lago di Garda con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni) allo Stato Italiano. Curata da Costanza Casali, assessore alla Cultura della Città di Ivrea, la mostra presenta opere di Nicola Bolla e Andrea Chisesi e sarà introdotta, sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1), da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente dal 2008 della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, affiancato da Angelo Piero Cappello, studioso del “Vate” abruzzese e direttore del “Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”. Artista di fama internazionale, anche il secondo ospite di “Palazzo Giusiana”, Nicola Bolla, nativo di Saluzzo (Cuneo), ma residente a Torino, dove alterna l’attività creativa al lavoro di medico-oculista. Bolla è, per tutti, l’ “artista degli Swarovski”, il particolare pregiatissimo cristallo ideato nel 1862 dal tagliatore boemo Daniel Swarovski, attraverso il quale l’artista saluzzese raggiunge la notorietà negli ultimi anni grazie ad una serie di “installazioni iconiche” – “Vanitas” – fondate su opere scultoree che, attraverso l’utilizzo esclusivo di un materiale riflettente (come, appunto, il cristallo Swarovski) “rileggono la storia della scultura invertendo i fattori costitutivi della stessa, da sempre fondata su materiali pesanti, duri, poco propensi alla riflessione della luce”. Ottima la scelta dei due artisti e delle loro creazioni ispirate alla figura del Grande “Immaginifico”, interpretata in maniera non didascalica, traendo ispirazione da tre termini a lui fortemente legati e ben ricordati nel titolo della mostra a tre “V”: “Le opere di Andrea Chisesi e Nicola Bolla – sottolinea in proposito, Costanza Casali – si discostano dalle tecniche tradizionali, e offrono un punto di vista diverso su D’Annunzio: se Chisesi utilizza la ‘fusione’ intervenendo con la fotografia dopo aver dipinto la tela, Bolla utilizza materiali inusuali per la scultura come cristalli e carte da gioco, che esprimono pienamente l’effimero. Le opere di Chisesi dedicate al ‘Vate’ rivelano fotogrammi di vita di D’Annunzio. Le ‘Vanitas’ di Bolla sono un ‘memento mori’ e la ‘Vittoria’ è rappresentata dalla ‘Nike di Samotracia’ reinterpretata da Chisesi e da ‘bandiere ammainate’ in cristallo create da Bolla, che sono il simbolo di una vittoria effimera che rappresenta soltanto un momento e un passaggio che domani potrebbe tramutarsi in disfatta”.
Artista di fama internazionale, anche il secondo ospite di “Palazzo Giusiana”, Nicola Bolla, nativo di Saluzzo (Cuneo), ma residente a Torino, dove alterna l’attività creativa al lavoro di medico-oculista. Bolla è, per tutti, l’ “artista degli Swarovski”, il particolare pregiatissimo cristallo ideato nel 1862 dal tagliatore boemo Daniel Swarovski, attraverso il quale l’artista saluzzese raggiunge la notorietà negli ultimi anni grazie ad una serie di “installazioni iconiche” – “Vanitas” – fondate su opere scultoree che, attraverso l’utilizzo esclusivo di un materiale riflettente (come, appunto, il cristallo Swarovski) “rileggono la storia della scultura invertendo i fattori costitutivi della stessa, da sempre fondata su materiali pesanti, duri, poco propensi alla riflessione della luce”. Ottima la scelta dei due artisti e delle loro creazioni ispirate alla figura del Grande “Immaginifico”, interpretata in maniera non didascalica, traendo ispirazione da tre termini a lui fortemente legati e ben ricordati nel titolo della mostra a tre “V”: “Le opere di Andrea Chisesi e Nicola Bolla – sottolinea in proposito, Costanza Casali – si discostano dalle tecniche tradizionali, e offrono un punto di vista diverso su D’Annunzio: se Chisesi utilizza la ‘fusione’ intervenendo con la fotografia dopo aver dipinto la tela, Bolla utilizza materiali inusuali per la scultura come cristalli e carte da gioco, che esprimono pienamente l’effimero. Le opere di Chisesi dedicate al ‘Vate’ rivelano fotogrammi di vita di D’Annunzio. Le ‘Vanitas’ di Bolla sono un ‘memento mori’ e la ‘Vittoria’ è rappresentata dalla ‘Nike di Samotracia’ reinterpretata da Chisesi e da ‘bandiere ammainate’ in cristallo create da Bolla, che sono il simbolo di una vittoria effimera che rappresenta soltanto un momento e un passaggio che domani potrebbe tramutarsi in disfatta”.

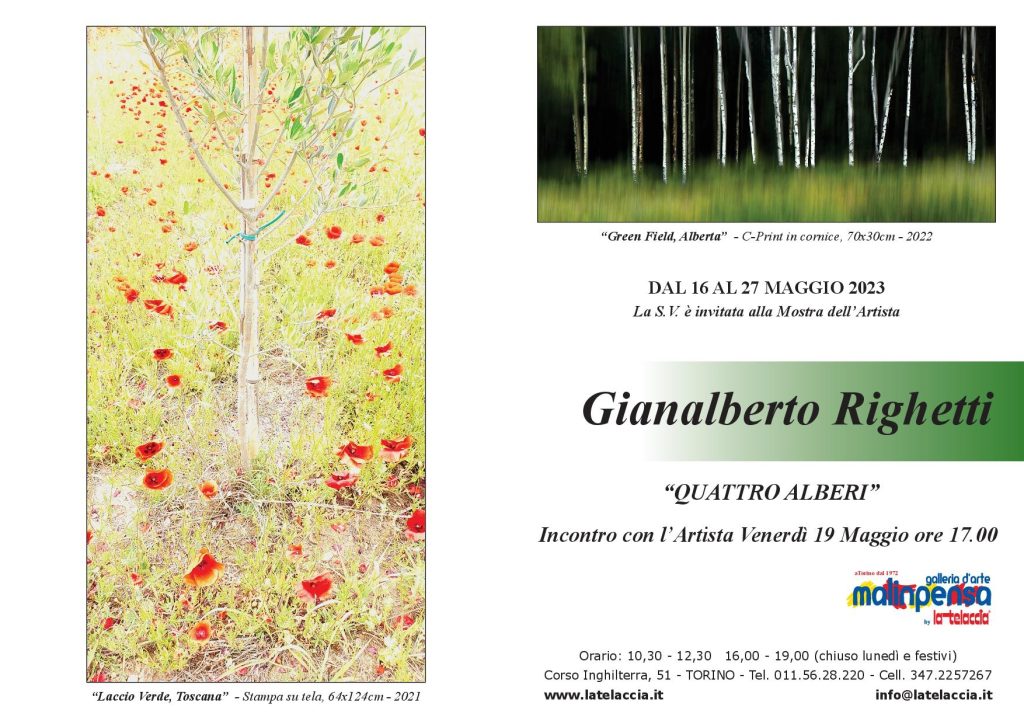


 In un riordino che guarda essenzialmente “alla più ampia accessibilità dei contenuti e delle grandi storie racchiuse nel patrimonio ella Sabauda”, ancora sottolinea Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali: “Per Gualino, la vita e le passioni di un fine collezionista si intrecciano ad una storia della produzione artistica che va dall’antico Egitto all’Ottocento, abbracciando pittura, scultura e arti decorative. Un percorso che meritava di essere sorretto da un allestimento nuovo e adeguato, sia in termini di articolazione di spazi e di luci, sia per i supporti esplicativi.” Soprattutto al lavoro e al gusto di Annamaria Bava, responsabile delle Collezioni d’Arte e di Archeologia dei Musei Reali, va la sensibile sistemazione del materiale pittorico e scultoreo: “A seguito dei recenti studi ad ampio raggio condotti sulla figura del finanziere piemontese in occasione della mostra “I mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore”, allestita nelle sala Chiablese nel 2019, risultava ormai imprescindibile restituire anche una giusta dimensione alla straordinaria raccolta di un personaggio che, in primis nel mondo dell’arte e dell’industria, ma anche in tanti altri campi, ha segnato la storia della città di Torino all’inizio del Novecento.”
In un riordino che guarda essenzialmente “alla più ampia accessibilità dei contenuti e delle grandi storie racchiuse nel patrimonio ella Sabauda”, ancora sottolinea Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali: “Per Gualino, la vita e le passioni di un fine collezionista si intrecciano ad una storia della produzione artistica che va dall’antico Egitto all’Ottocento, abbracciando pittura, scultura e arti decorative. Un percorso che meritava di essere sorretto da un allestimento nuovo e adeguato, sia in termini di articolazione di spazi e di luci, sia per i supporti esplicativi.” Soprattutto al lavoro e al gusto di Annamaria Bava, responsabile delle Collezioni d’Arte e di Archeologia dei Musei Reali, va la sensibile sistemazione del materiale pittorico e scultoreo: “A seguito dei recenti studi ad ampio raggio condotti sulla figura del finanziere piemontese in occasione della mostra “I mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore”, allestita nelle sala Chiablese nel 2019, risultava ormai imprescindibile restituire anche una giusta dimensione alla straordinaria raccolta di un personaggio che, in primis nel mondo dell’arte e dell’industria, ma anche in tanti altri campi, ha segnato la storia della città di Torino all’inizio del Novecento.”



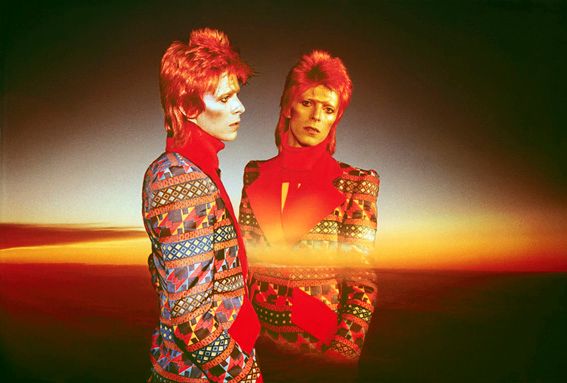


 La mostra è suddivisa in sei sezioni. Affidata ai “Precursori” la prima, in cui si allineano i nomi e le opere di Giovanni Canavesio (di Pinerolo, prima del 1450-1500; suo un probabile “Sant’Agostino” di fine secolo), di Tommaso Biazaci (di Busca, documentato tra il 1465 e il 1488; importante per il suo trasferimento in Liguria dove, con i favori dei ricchi banchieri liguri, divenne il tramite tra le novità fiamminghe e la pittura piemontese), di Andrea De Aste. Il Salone Cinese è dedicato ai “Committenti”, dove fa bella mostra la “Madonna in trono tra San Nicola da Tolentino e santo vescovo” di Tommaso Cagnola, e ai “Grandi polittici tra scomposizione e ricostruzione”, in cui parti smembrate (come due ante) riconducono ad un polittico eseguito dallo Spanzotti e dall’allievo Ferrari tra il 1496 e il 1500.
La mostra è suddivisa in sei sezioni. Affidata ai “Precursori” la prima, in cui si allineano i nomi e le opere di Giovanni Canavesio (di Pinerolo, prima del 1450-1500; suo un probabile “Sant’Agostino” di fine secolo), di Tommaso Biazaci (di Busca, documentato tra il 1465 e il 1488; importante per il suo trasferimento in Liguria dove, con i favori dei ricchi banchieri liguri, divenne il tramite tra le novità fiamminghe e la pittura piemontese), di Andrea De Aste. Il Salone Cinese è dedicato ai “Committenti”, dove fa bella mostra la “Madonna in trono tra San Nicola da Tolentino e santo vescovo” di Tommaso Cagnola, e ai “Grandi polittici tra scomposizione e ricostruzione”, in cui parti smembrate (come due ante) riconducono ad un polittico eseguito dallo Spanzotti e dall’allievo Ferrari tra il 1496 e il 1500.