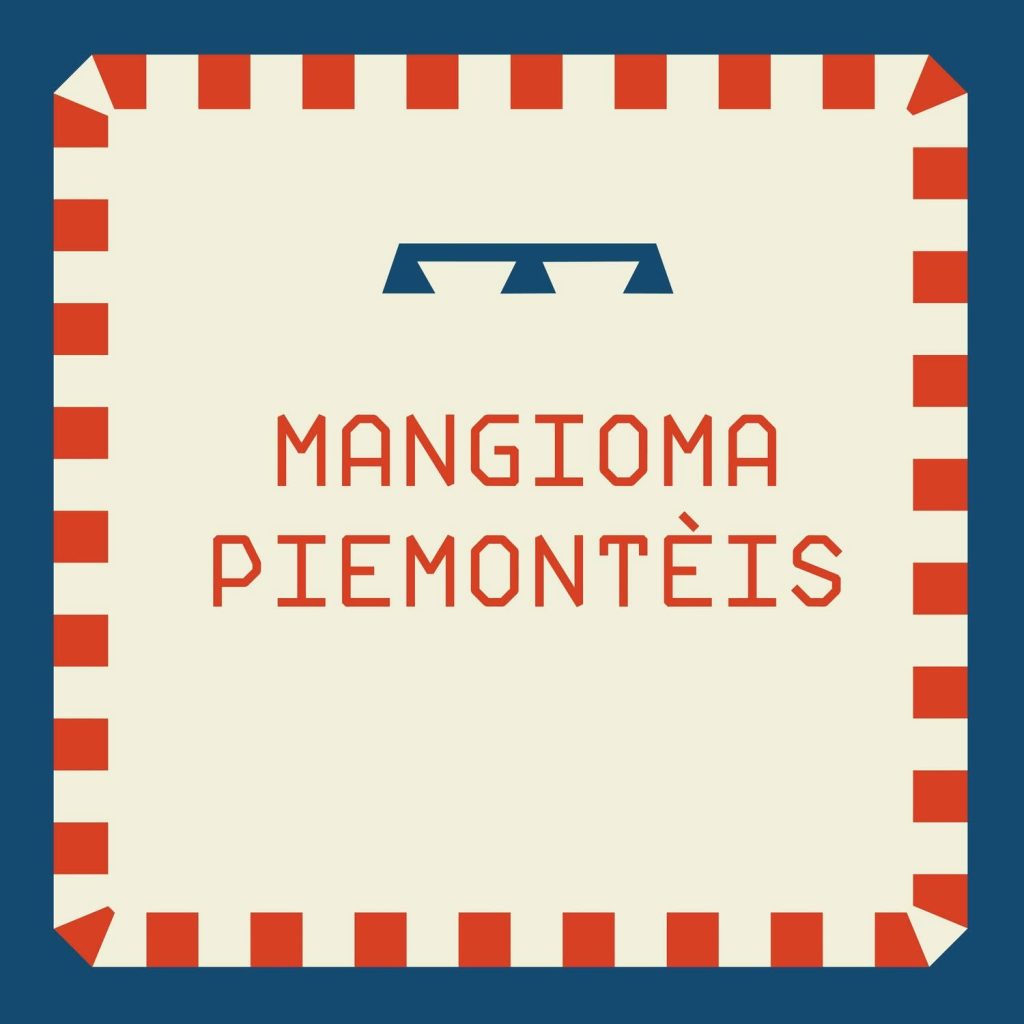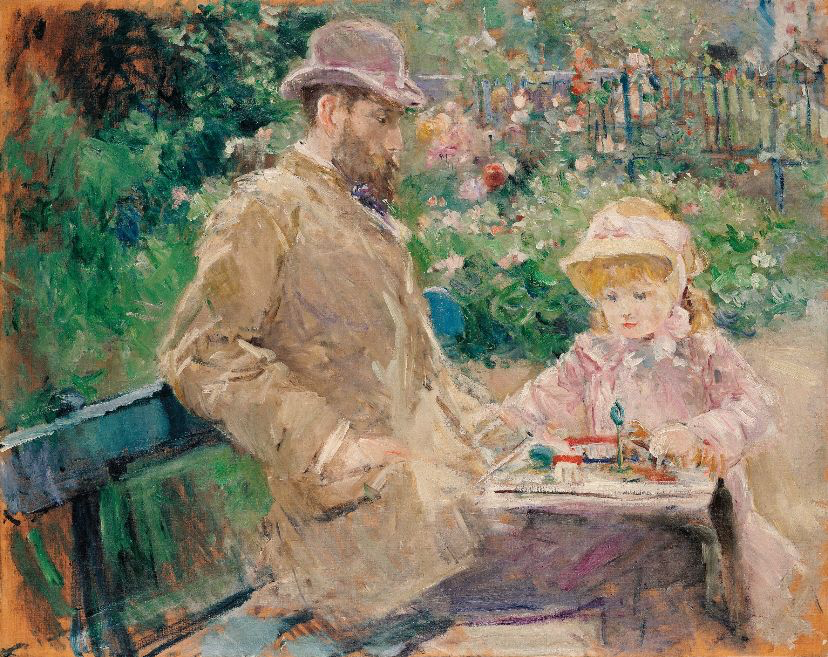Informazione promozionale
“Le donne nell’arte” sono protagoniste della mostra in programma da martedì 26 novembre al 7 dicembre prossimo presso la galleria d’arte Malinpensa by La Telaccia. Le quattro artiste dell’esposizione, curata dalla direttrice artistica Monia Malinpensa, sono Alessandra Cardi, Anita Clemente, Ines Tropeani e Luisa Piccoli.

L’artista Alessandra Cardi vive e lavora a Montebelluna, in provincia di Treviso. Senza un’educazione scolastica in ambito artistico ha manifestato già dalla giovinezza una particolare propensione per l’equilibrio di colore delle linee. Il suo istinto la conduce a avvicinarsi all’arte astratta, che sente molto vicina a quel mondo interiore che diventa propulsore creativo quando si avvicina a una tela. Esprime con il suo linguaggio pittorico emozioni profonde, finalizzate a una ricerca interiore altamente riflessiva. I suoi soggetti astratti, che sono caratterizzati da elementi figurativi dal tratto volutamente non compiuto, evolvono in una rappresentazione ricca di dettagli formali e di aspetti simbolici. Il segno incisivo si libera in una astrazione poliedrica di pura espressione in cui l’utilizzo di materiali diversi, quali la corda, regalano all’opera dimensione sensoriale del tutto suggestiva in grado di lasciare spazio di interpretazione allo spettatore.

L’artista Anita Clemente, nata a Milano nel 1977, da sempre attratta dall’arte in ogni sua forma, si approccia al disegno, alla pittura e al genere figurativo. Sentendosi limitata dalla staticità della pittura, si avvicina in momenti più recenti al mondo fotografico e lo riconosce come un mezzo, più che come un fine. Non si limita alla sola rappresentazione figurativa, ma trasforma la materia attraverso interventi di innovativa combinazione e di complessa progettualità, dove è evidenziato un iter che la contraddistingue. Frammenti di fotografie e moduli pittorici si liberano costantemente nelle sue installazioni, giocando con i pieni e i vuoti per creare un aspetto tridimensionale di ampio stile personale. Si tratta di un’artista capace di unire diverse tecniche con una stesura valida e suggestiva che spazia in modo magistrale dal figurativo all’astratto.

Ines Tropeani, nata a Montebelluna, in provincia di Treviso, nel 1989, frequenta l’Istituto d’Arte dove si diploma in Grafica Pubblicitaria e Fotografia, per poi iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove si laurea in Discipline e Arti dello Spettacolo. Fotografa e scenografa, unisce l’approccio naturalistico e realistico con una sensibilità speciale e meticolosa nei dettagli, riflettendo una profonda e attenta analisi del soggetto. L’artista ha la capacità di trasformare un semplice paesaggio o elemento naturalistico in una rappresentazione intensa, che vive di emozioni e stati d’animo ricorrenti. La composizione del soggetto fotografico assume un ruolo fondamentale nel suo iter, che si carica di luci e di ombre magistrali in un perfetto connubio.

L’artista Luisa Piccoli, nata a Bisceglie, in provincia di Bari, nel 1953, ha conseguito la maturità classica e ha frequentato l’Accademia d’Arte di Bari. È pittrice, scultrice, scrittrice, poeta e scenografa. Utilizza un linguaggio di grande spessore umano e porta alla luce una figurazione di notevole tensione lirica e di poetica creatività, che si distingue rilevante e personale. L’artista concepisce opere sulla condizione umana e sociale con profonda essenza emotiva, offre al fruitore importanti spunti di riflessione e significativi messaggi, sempre con rispettabilità e sentimento. Si tratta di racconti di pura contemplazione che suscitano emozioni, e svolgono una funzione molto impegnativa e simbolica.
Mara Martellotta