|
Domenica 25 dicembre, ore 21.15 L’attesaLe musiche di Arvo Pärt tra le opere di Christo e Jeanne-Claude per un coinvolgimento sensoriale totale e unico |
|
Dopo l’esperienza del Concerto da Casa del 2020 e del Concerto nella corte rustica del 2021, torna il Concerto di Natale nelle sale espositive del Castello di Miradolo. Il concerto, a cura del progetto Avant-dernière pensée, indagherà quest’anno il tema della musica come sospensione del tempo, come spazio offerto all’ascolto: da qui, il suo titolo, L’attesa. Gli esecutori INFO |



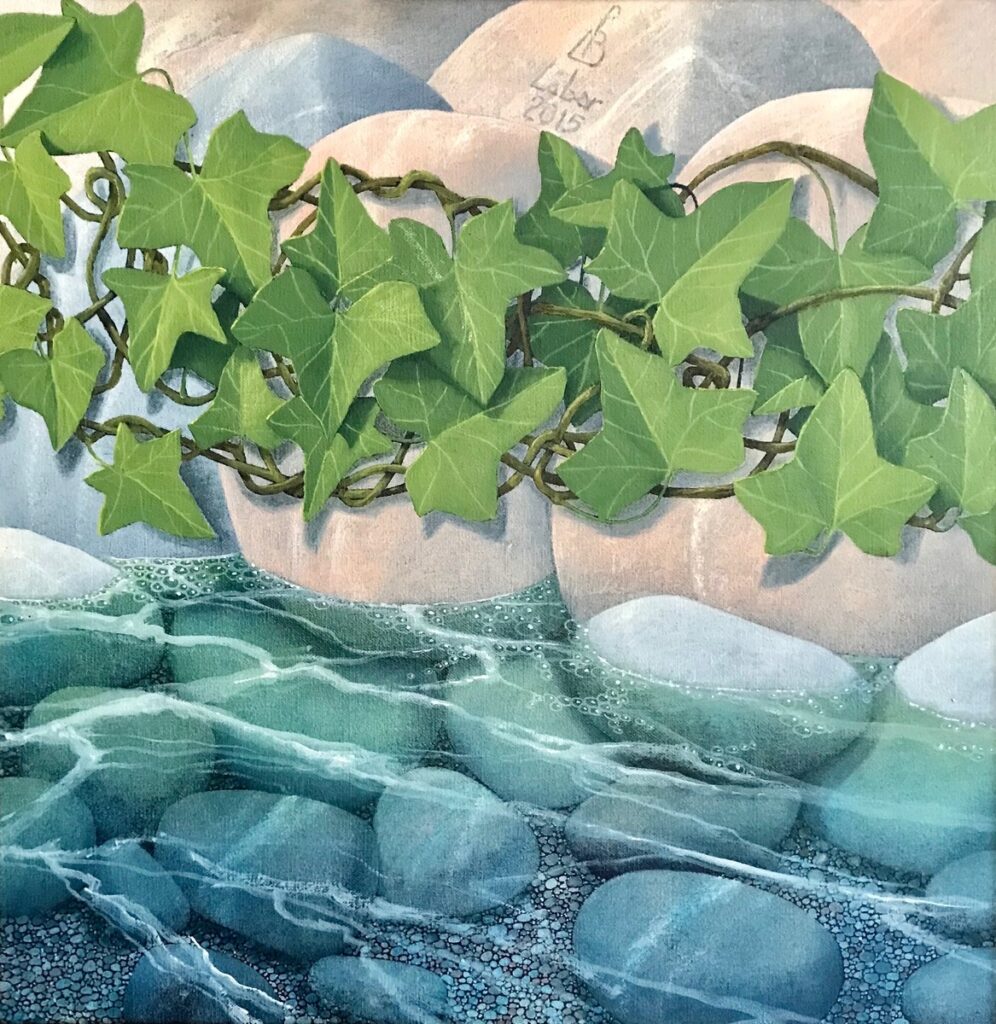

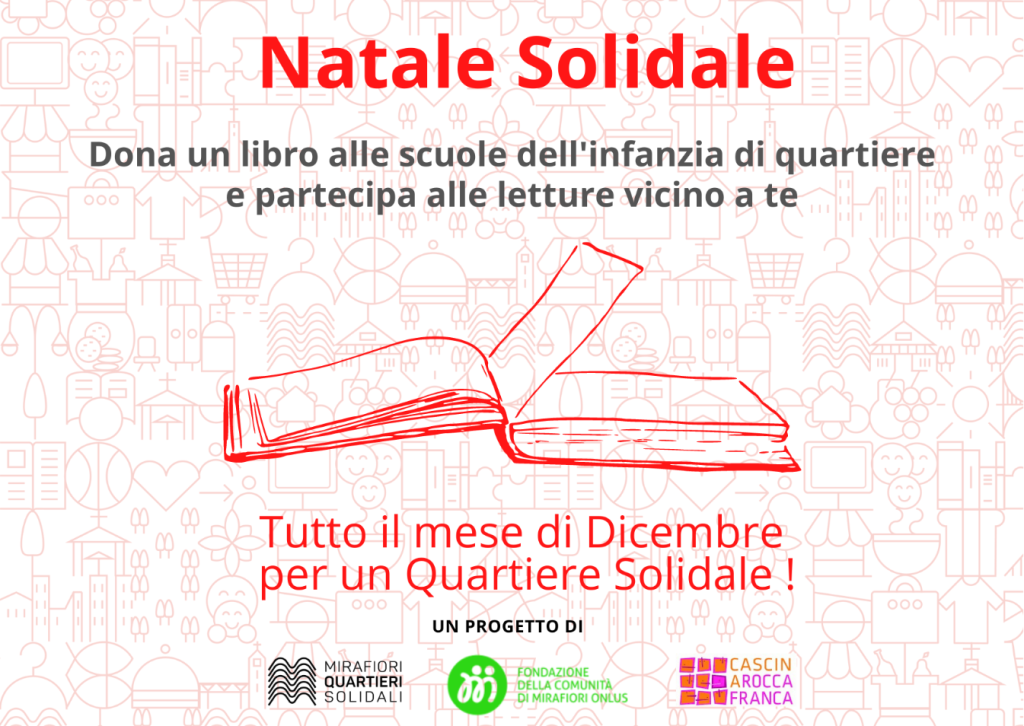

 CHIARA DE CARLO
CHIARA DE CARLO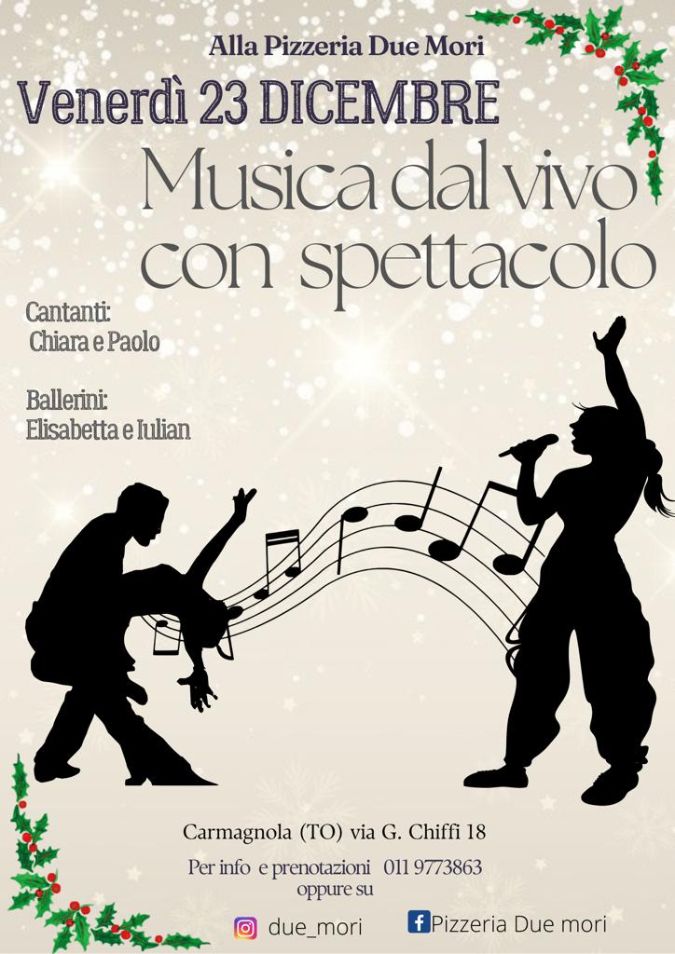


 I singolari portabottiglie, creati dalle loro stesse mani, niente hanno a che vedere, seppur ci sia una certa assonanza verbale, con lo scolabottiglie di Duchamp che ha dato l’avvio al Ready-made e al Dadaismo limitandosi a scegliere e collocare un oggetto preesistente dandogli dignità artistica.
I singolari portabottiglie, creati dalle loro stesse mani, niente hanno a che vedere, seppur ci sia una certa assonanza verbale, con lo scolabottiglie di Duchamp che ha dato l’avvio al Ready-made e al Dadaismo limitandosi a scegliere e collocare un oggetto preesistente dandogli dignità artistica.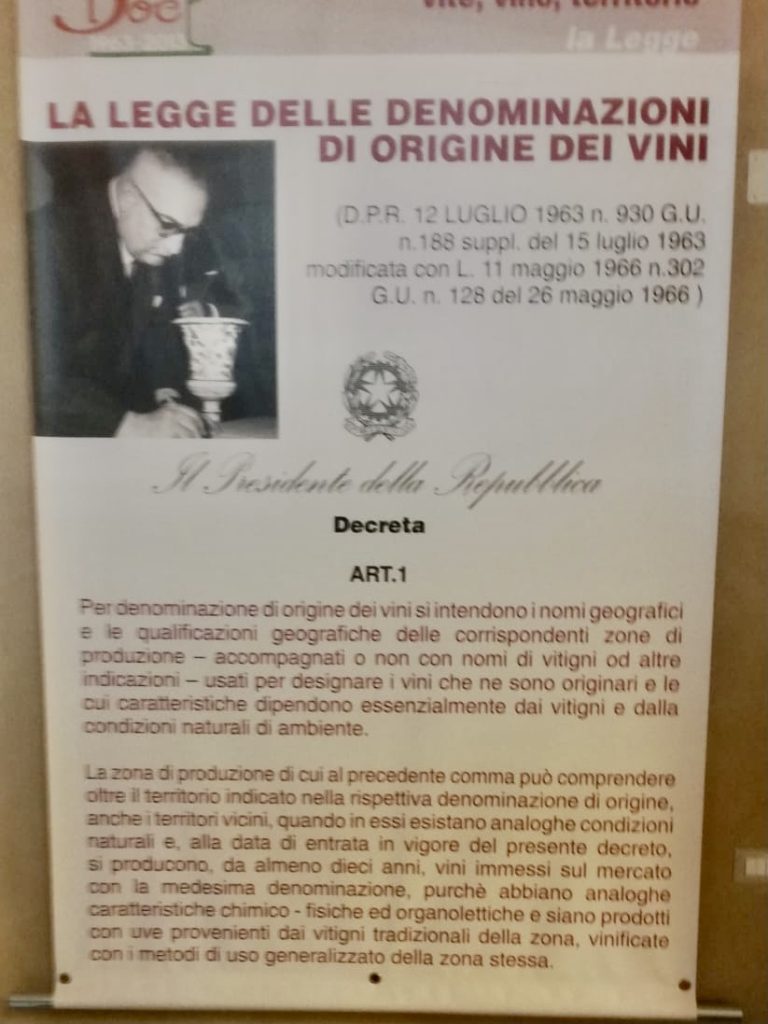 Ogni artista ha esposto piccole belle sculture che, nonostante la semplificazione di loro opere più complesse, riescono a contraddistinguere gli stili personali immediatamente riconoscibili.
Ogni artista ha esposto piccole belle sculture che, nonostante la semplificazione di loro opere più complesse, riescono a contraddistinguere gli stili personali immediatamente riconoscibili.
 Cinque eleganti sezioni, “Nascita di una collezione”, “Nuove sensibilità e ricerche”, “La pittura di paesaggio al Museo Civico”, “Dalla Scapigliatura al Divisionismo” e “Ricerche simboliste tra pittura e scultura”, accompagnate da tre focus su Andrea Gastaldi, Antonio Fontanesi e Giacomo Grosso. Un valido quanto suggestivo percorso che Passoni ama definire altresì una “ricognizione del nostro patrimonio storico”, dove trovano posto anche opere mai esposte, restaurate grazie al contributo degli Amici della Fondazione Torino Musei, quali “Ecco Gerusalemme” di Enrico Gamba, acquistato nell’anno della sua esecuzione per il Museo nel 1862 dalla Società Promotrice delle Belle Arti, e “Nobili in viaggio” (ma ritrovandone il titolo originale con cui fu esposto nel 1867, “La Guida. Studio di castagni dal vero”) di Francesco Gonin, sempre presso la Società Promotrice torinese.
Cinque eleganti sezioni, “Nascita di una collezione”, “Nuove sensibilità e ricerche”, “La pittura di paesaggio al Museo Civico”, “Dalla Scapigliatura al Divisionismo” e “Ricerche simboliste tra pittura e scultura”, accompagnate da tre focus su Andrea Gastaldi, Antonio Fontanesi e Giacomo Grosso. Un valido quanto suggestivo percorso che Passoni ama definire altresì una “ricognizione del nostro patrimonio storico”, dove trovano posto anche opere mai esposte, restaurate grazie al contributo degli Amici della Fondazione Torino Musei, quali “Ecco Gerusalemme” di Enrico Gamba, acquistato nell’anno della sua esecuzione per il Museo nel 1862 dalla Società Promotrice delle Belle Arti, e “Nobili in viaggio” (ma ritrovandone il titolo originale con cui fu esposto nel 1867, “La Guida. Studio di castagni dal vero”) di Francesco Gonin, sempre presso la Società Promotrice torinese.



