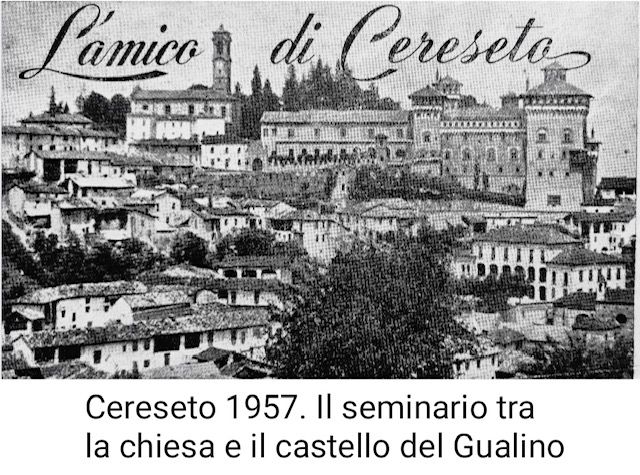Polimnia Arts Company, 6 gennaio 2026 su patrocinio di Rotary Torino Duomo, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte
Si terrà a Torino, il 6 gennaio prossimo, giorno dell’Epifania, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Madonna di Campagna di via Cardinal Massaia 98, un concerto organizzato dall’Associazione Polimnia Arts Company APS che appassionerà sia gli intenditori sia gli appassionati del genere, e che prevede l’esecuzione di brani tratti dai principali capolavori di due grandi compositori: Richard Wagner e Giuseppe Verdi. Il concerto vedrà protagonista la Polimnia Arts Chorus e Orchestra, diretta dal Maestro Lorenzo Battagion. La serata sarà presentata da Sax Nicosia.
Di Richard Wagner verranno eseguite “Vorspiel”, tratta da “I maestri cantori di Norimberga”; “Liebestod”, tratto da “Tristano e Isotta” (soprano: Annamaria Turicchi) e “Wein und Brot des letzten Mahles”, dal finale del primo atto del “Parsifal”.
Nella seconda parte del concerto verranno eseguite, di Giuseppe Verdi, la Sinfonia da “Nabucco”, l’Ouverture da “La forza del destino” e il “Te Deum” e Quattro pezzi sacri per coro e orchestra (soprano: Serena Rubini).
“I maestri cantori di Norimberga” è l’unica opera buffa scritta da Wagner, sebbene egli stesso non l’avrebbe definita così, poiché contiene sfumature oscure e malinconiche. Il “Tristano e Isotta” è un dramma musicale di Richard Wagner su libretto dello stesso compositore, e costituisce un capolavoro del romanticismo tedesco oltre a rappresentare uno dei pilastri della musica moderna. Già nel 1854 Richard Wagner aveva pensato di comporre un dramma musicale ispirato al poema cavalleresco del Duecento di Gottfried von Strassburg, che racconta la vicenda di Tristano e Isotta, composta tra l’autunno del 1857 e l’agosto del 1859.
Il “Parsifal” è l’ultimo dramma musicale di Richard Wagner, composto tra il 1877 e il 1882, che segna il ritorno al tema del Graal, già affrontato molti anni prima nel Lohengrin. Il brano proposto descrive l’ingresso alla sala del Graal ed è illustrato da una grande pagina sinfonica. Risuonano le campane mentre i cavalieri si dispongono lentamente attorno all’altare. Un coro di voci bianche scende dalla cupola.
Il “Nabucco” è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi, quella che ne decretò il successo. Composta su libretto di Temistocle Solera, “Nabucco” fece il suo esordio ottenendo grande approvazione da parte del pubblico il 9 marzo 1842, al teatro La Scala di Milano, alla presenza di Gaetano Donizetti. L’opera è ambientata tra Gerusalemme e Babilonia nel sesto secolo avanti Cristo, e narra la lotta tra gli ebrei e il re babilonese Nabucodonosor (Nabucco). L’opera ebbe un significato molto profondo per gli italiani dell’epoca, che vedevano nella prigionia degli ebrei un parallelo con la loro stessa oppressione e il desiderio di unificazione nazionale portato dal Risorgimento.
L’Ouverture da “La Forza del Destino”, sempre di Giuseppe Verdi, è un celebre brano orchestrale spesso eseguito come pezzo da concerto singolo, noto per la sua potenza drammatica e l’anticipazione dei temi operistici, specialmente quello della fatalità, riprendendo melodie dell’opera stessa, uno dei più famosi del repertorio sinfonico.
Il “Te Deum” è uno dei Quattro pezzi sacri composti da Verdi, che lo considerava uno dei suoi lavori più significativi e che ne conclude il ciclo. Si tratta di una composizione intensa e profonda, che può essere letta come una meditazione sul rapporto tra l’uomo, il sacro e la natura. Viene evocata l’immagine di una pineta viva in cui ogni albero, come ogni voce, contribuisce a un’armonia dell’insieme. Il taglio degli alberi spezza quell’equilibrio lasciando silenzio e vuoto. Il finale sommesso del “Te Deum” invita alla riflessione, come lo sguardo che si posa su una pineta ferita e interroga la coscienza dell’uomo.
Il concerto sarà eseguito da Polimnia Arts Chorus e Orchestra, diretta dal Maestro Lorenzo Battagion, direttore artistico della Polimnia Arts. Il Rotary Club Torino Duomo è patrocinante dell’evento, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte
Il concerto avrà la finalità di una raccolta fondi per Save the Children, rivolta ai bambini coinvolti nei conflitti nelle varie zone del mondo.
L’ingresso è a offerta libera.
All’Alfieri, repliche e grandioso successo sino al 6 gennaio
Tornare a vedere – e riapplaudire, senza se e senza ma, far ricredere quanti ancora possono credere che sul mondo del musical si sia depositata una certa polvere – all’Alfieri (repliche sino al 6 gennaio) “Cantando sotto la pioggia”, significa fare innanzitutto sincero chapeau dinanzi allo sforzo produttivo del Fabrizio Di Fiore Entertainment, una ricchezza nel mondo odierno dello spettacolo musicale in Italia, una ricchezza che ha l’apporto puntuale e incondizionato di 22 artisti tra attori e ballerini più 14 persone dietro le quinte a sovrintendere sera dopo sera una macchina teatrale che non è certo indifferente. Significa riconoscere quanto dalle anteprime dello scorso maggio proprio quella macchina, in qualche ansa di non facile scorrimento, si sia irrobustita e snellita, come in tutta la parte finale si sia messo maggior ordine agli sviluppi del racconto, causa non ultima la corposa tournée di “Cantando” che da inizio stagione ha già toccato tra gli altri Trieste e Firenze, Bolzano e Bologna per concludersi a fine aprile sul palcoscenico del Brancaccio di Roma dopo essere passata per Bari e Ancona, città del Veneto e Milano.
Significa essere presi, ancora una volta, dalla regia tutta vulcanica e fuochi d’artificio di Luciano Cannito – a lui si devono anche le festosequanto eleganti coreografie -, dal rispetto mantenuto per quello che rimane un capolavoro del cinema (era il 1952, Gene Kelly sullo schermo a danzare “in the rain” e alla regia con Stanley Donen, con accanto una freschissima Debbie Reynolds e un indiavolato Donald O’Connor mentre la Lina Lamont di Jean Hagen s’avvicinava all’Oscar) senza sottrarlo a una buona dose di attuale ironia, dal ritmo magnificamente indiavolato che all’Alfieri di oggi tocchiamo ancor più con mano tra risate e applausi e viva partecipazione, nel completo coinvolgimento del pubblico, l’omaggio dovuto di un uomo di teatro a un testo e alle musiche in cui ha sempre creduto, “un sogno che si avvera nei confronti di un testo a cui ho pensato da sempre, da quando ho iniziato a fare il mestiere che faccio”. Significa apprezzare uno spettacolo che – con il libretto di Betty Comden e Adolph Green, con le musiche e le canzoni di Nacho Herb Brown e Arthur Freed, firma leggendaria a Hollywood, dal “Mago di Oz” a “Gigi” – rende omaggio al vecchio cinema, a qualsiasi vecchio film di una industria che stava crescendo e che con “Il cantante di jazz” (era l’ottobre del ’27) abbandonava l’epoca del muto per il sonoro; già scrivevo, “compresi righe e filamenti volanti sulla pellicola, il carattere un po’ démodé delle scritte: con tanto di titoli di testa a elencare cast, costumi e scenografie, musiche, regia e produzione, quanti fecero l’impresa e quant’altro ancora: come ai vecchi tempi, tutto a scorrere sulla quarta parete del palcoscenico”; compresa l’eccellente ricostruzione di un clima e di un’epoca e le citazioni che soddisfano la cinefilia di chi scrive, dall’orologio di Harold Lloyd di “Preferisco l’ascensore” nelle immagini alle gambe più belle (e costose) del mondo, quelle di una smagliante Cyd Charisse in silhoutte in coppia con Kelly -, le musiche e le canzoni, le torte in faccia e le cineprese insicure, le recitazioni approssimative o senz’altro disastrose tra i fondali di cartapesta e il bianco e nero, i sentimenti e la cavalcata attraverso un sogno che si può realizzare, la gavetta e i capricci, le voci stridule e inascoltabili, i dispetti e le rivalse tra primedonne, la superiorità dell’eterno teatro sulla nuova arte, il red carpet e le dive (o pseudo-dive) che riuscivano a manipolare contratti e majors, il doppiaggio che può rimettere in piedi le cose, un divertimento insomma che riempie appieno le tre ore circa dello spettacolo. Non ultimi a decretare il successo i costumi di Silvia Califano e le scene mobili e veloci di Italo Grassi.
Significa riapprezzare le prove maiuscole degli interpreti. Lorenzo Grilli, cresciuto alla scuola di Gigi Proietti e nel cinema di Roberta Torre, è un validissimo Don Lockwood, infaticabile, visibilmente irrobustito, davvero efficace, nella recitazione e nella costruzione del protagonista, trascinante nel momento “in the rain” sotto scrosci non indifferenti d’acqua con voce e salti e zompi invidiabili sui lampioni di scena. Martina Stella e Flora Canto, su due diversissimi versanti, nella conferma che sono due belle attrici, che convincono, un ritrattino ancor più tutto pepe di ocaggine agguerrita nel non voler cedere lo spazio che s’è guadagnato la prima, zeppa di birignao e di confusione di vocali in finali di parole, divertentissima e spavaldamente ironica; grintosa “my fair lady” del palcoscenico la seconda, pienamente disponibile ad un percorso di tutto rispetto, pronta a esplodere e a portare a casa studio e passione ed entusiasmo in un godibilissimo “Good Morning” con i suoi due compagni di felice avventura. L’altro è Vittorio Schiavone, felicissima scoperta, inattesa a maggio e superlativa oggi, un folletto di scena che segui in ogni suo movimento, un artista autentico e versatile e completo, che rischia in parecchi momenti di diventare il mattatore della serata: sarebbero sufficienti, con buona pace del suo vecchio collega di Hollywood (cercatevi certi spezzoni in rete!), “Make ‘Em Laugh” o “Moses Supposes” (qui con Grilli, un binomio da premi incondizionati) o ancora il citato “Good Morning”, per farci ripetere che “il suo Cosmo, per certi tratti, ha tutta la magia dell’inafferrabile, del campione che non hai ancora incrociato, dell’uomo di palcoscenico abituato a sgusciar fuori improvviso, a lanciare piccoli e grandi guizzi e a colpire (sempre) nel segno, del nome che per il futuro non potrà di certo sfuggirti e che dovrai essere tu a dover tenere d’occhio”.
Elio Rabbione
Le immagini di “Cantando sotto la pioggia, regia di Luciano Cannito, sono di Valerio Polverari.

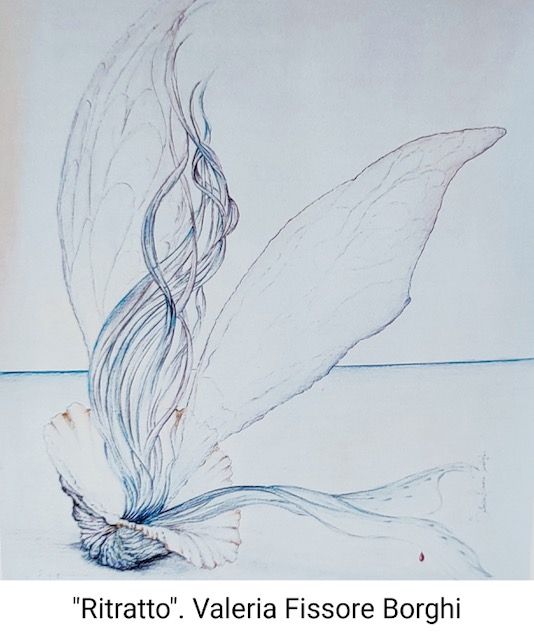
Un anno da record per Camera
2025 si è rivelato un anno da record: le mostre e le attività organizzate dalla Fondazione hanno attirato in via delle Rosine oltre 125 mila visitatori con una media giornaliera di 370 presenze. Un risultato di grande valore per la Fondazione, che arriva in un periodo particolarmente significativo caratterizzato dalla vittoria di uno dei più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito della fotografia a livello internazionale, il Lucie Spotlight Award 2025, e dall’avvio dei festeggiamenti per i primi dieci anni di attività di CAMERA.
Un anno intenso e ricco di iniziative, in gran parte dirette da Walter Guadagnini e che oggi proseguono sotto la guida di un nuovo direttore artistico dal profilo internazionale come François Hébel.
Sempre attento, curioso e appassionato, il pubblico di CAMERA ha potuto immergersi nella vita e nell’opera ditre grandi maestri del Novecento, due fotografi e una fotografa, che col loro sguardo inconfondibile hanno raccontato il loro tempo e lasciato una traccia indelebile nella storia della fotografia e nell’immaginario collettivo.
Il 2025 si è aperto con la mostra “Henri Cartier-Bresson e l’Italia” (14 febbraio – 2 giugno 2025), curata da Clément Chéroux e Walter Guadagnini, con cui i visitatori hanno potuto riscoprire il grande autore francese attraverso l’inedita prospettiva del suo lungo rapporto con l’Italia: un paese profondamente amato da Cartier-Bresson soprattutto per la vivace vita di strada, che gli dava l’opportunità di cogliere quei suoi celebri “istanti decisivi” con cui ha ritratto città e i borghi, la gente comune, così come i grandi intellettuali e gli artisti dell’epoca.
La lunga estate di CAMERA è stata poi animata dalla mostra su “Alfred Eisenstaedt” (13 giugno – 21 settembre 2025) tra i principali fotografi della rivista Life nonché autore del famoso ‘bacio a Times Square’: un viaggio in 170 immagini, curato da Monica Poggi, che ha attraversato tutto l’arco della sua carriera, dai primi scatti nella Germania degli anni Trenta alla vita vertiginosa degli Stati Uniti del boom economico, fino ai ritratti di alcuni personaggi noti come Sophia Loren, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer.
Dallo scorso 1°ottobre, 160 scatti iconici, misteriosi, affascinanti e autentici, tutti provenienti dai Lee Miller Archives, rivivono negli spazi di via delle Rosine nel percorso curato da Walter Guadagnini “Lee Miller. Opere 1930 – 1955”. Tra eleganti servizi di moda, onirici scatti surrealisti, enigmatici paesaggi surrealisti e drammatici reportage di guerra, la mostra mette in luce l’inesausta curiosità della straordinaria fotografa americana e il suo continuo desiderio di cambiamento e scoperta, tanto della vita quanto della fotografia.
Nel corso del 2025, hanno arricchito gli spazi di CAMERA anche le immagini e i progetti visivi di autori più o meno contemporanei proposti nelle mostre inProject Room, quali “Riccardo Moncalvo. Fotografie 1932 – 1990”, “Olga Cafiero. Cultus Langarum”, “CAMERA meets ICP. Un archivio vivente”, “Arianna Arcara. I sogni dei vecchi”, fino a Cristian Chironi e i suoi tanti modi di “Abitare l’immagine”.
Sguardi, voci, storie che il pubblico ha potuto approfondire anche attraverso un ricco programma di talk, presentazioni di libri, attività educative per grandi e piccoli oltre a percorsi di alta formazione per riflettere sulla forza delle immagini e interrogarsi sulla realtà contemporanea.
A cura di piemonteitalia.eu
Ivrea, capoluogo del Canavese, denominata Eporedia in epoca romana, è una città ricca di storia, arte e cultura, nonché sede dello storico e importante Carnevale di Ivrea.
Continua a leggere:
Giovedì 8 alle 20.30 e venerdì 9 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Andrès Orozco-Estrada e con Ettore Pagano al violoncello, eseguirà musiche di Berlioz, Saint-Saens, Respighi. Venerdì 9 alle 20.30 per Lingotto Musica all’Auditorium Agnelli, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Manfred Honeck e con Simon Trpceski al pianoforte, eseguirà musiche di Weber, Cajkovskij, Dvoràk.

Mercoledì 14 alle 20.30 al conservatorio G. Verdi, per l’Unione Musicale, Renaud Capucon violino e Guillaume Bellon pianoforte, eseguiranno musiche di Brahms. Giovedì 15 alle 20.30 per “I Pianisti del Lingotto”, nella Sala 500 del Lingotto, Angela Hewitt pianoforte, eseguirà musiche di Bach. Giovedì 15 alle 20.30 e venerdì 16 alle 20 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Ottavio Dantone e con Nicola Patrussi oboe, eseguirà musiche di Richard Strauss. Sabato 17 alle 18 al teatro Vittoria per l’Unione Musicale, il Trio Quodlibet eseguirà musiche di Bach, con un invito all’ascolto di Antonio Valentino. Domenica 18 alle 16.30 per l’Unione Musicale, i PICello Bros. eseguiranno musiche di Beethoven, Chopin, Molinelli.

Lunedì 19 alle 20 al teatro Vittoria per l’Unione Musicale, il Duo Repicco eseguirà musiche di de Visèe, Couperin, Couperin-de Visèe, von Westhoff. Martedì 20 alle 20, al teatro Regio, debutto de “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini. Melodramma giocoso in due atti. L’Orchestra del teatro Regio sarà diretta da Antonino Fogliani. Repliche fino a Martedì 27. Martedì 20 alle 20 al teatro Vittoria per l’Unione Musicale, Paolo Angeli chitarra sarda preparata e voce, presenta in concerto l’album “Lema”. Mercoledì 21 alle 20.30 al conservatorio, Natalie Clein violoncello e Cèdric Pescia pianoforte, eseguiranno musiche di Bloch, Lutyens, Schubert, Elias, Brahms. Giovedì 22 alle 20.30 e venerdì 23 alle 20, all’auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Diego Ceretta e con Fazil Say pianoforte, eseguirà musiche di Ravel, Say, Musorgskij. Martedì 27 alle 20.30 all’ auditorium Agnelli per Lingotto Musica, la Camerata Salzburg con Giovanni Guzzo violino concertatore e Pierre-Laurent Aimard pianoforte, eseguiranno musiche di Haydn e Mozart.

Giovedì 29 alle 20.30 e venerdì 30 alle 20 all’auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Nicolò Umberto Foron, con Fleur Barron mezzosoprano, eseguirà musiche di Messiaen, Mahler, Rachmaninov. Sabato 31 alle 18 al teatro Vittoria per l’Unione Musicale, Loris Palladino clarinetto, Pietro Beltramo pianoforte, con Antonio Valentino, eseguiranno musiche di Brahms, Debussy, Poulenc.
Pier Luigi Fuggetta

Si chiude un anno straordinario per la Fondazione Torino Musei, segnato da rilevanti risultati per quanto riguarda l’attività espositiva, lo sviluppo internazionale, la valorizzazione delle collezioni ma soprattutto per le prospettive di riqualificazione dell’eccezionale patrimonio architettonico.
Un anno che ha consolidato il ruolo dell’ente quale sistema culturale dinamico, autorevole e capace di coniugare visione a lungo termine, qualità scientifica e apertura a pubblici sempre più ampi.
Al centro di questa visione si collocano due grandi progetti di trasformazione infrastrutturale, di rilevanza nazionale e internazionale, che segnanouna svolta per i musei civici torinesi. Da un lato, l’annuncio del vincitore del concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione della GAM– reso pienamente possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo – apre l’avvio della fase di completa riqualificazione del museo, orientata a sostenibilità, accessibilità e rinnovati modelli di fruizione e partecipazione.
Dall’altro, il proseguimento del grande progetto di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Madama, sostenuto dalla Fondazione CRT, pone le basi per la nascita del futuro Museo della Città, restituendo al pubblico spazi rinnovati e una nuova narrazione del rapporto tra Torino, la sua storia e le sue comunità. Due interventi distinti ma complementari, che delineano una visione condivisa di museo come organismo culturale in continua evoluzione, contemporaneo, profondamente radicato nel contesto cittadino ma con un chiaro posizionamento e proiezione internazionale.
Accanto a questa forte progettualità, la Fondazione Torino Musei ha perseguito con nuova e diversa convinzione la propria vocazione internazionale, con ben otto mostre realizzate in Europa e in Asiae un’intensa attività di cooperazione e formazione, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio museale della città a livello globale. Gli spettatori delle mostre all’estero sono stati oltre 435.000. A coronare questa proiezione internazionale, il 2025 ha visto il ritorno in Italia della 57ª edizione della Conferenza Annuale di CIMAM – International Committee for Museums and Collections of Modern Art, promossa da CIMAM con il supporto di Fondazione Arte CRT e Fondazione CRT, per la quale Fondazione Torino Musei ha offerto il proprio contributo all’organizzazione.
Sul piano espositivo, il 2025 è stato segnato dal grande successo delle proposte espositive di tutti e tre i musei, apprezzate dal grande pubblico così come dagli specialisti.
La mostra Chiharu Shiota. The Soul Trembles al MAO, oltre a rappresentare una svolta nella programmazione complessiva del Museo verso nuovi pubblici e una dimensione attiva sulla scena contemporanea, è diventata uno dei momenti più rilevanti dell’intera programmazione annuale cittadina e nazionale. Analogamente, la programmazione di Palazzo Madama con l’eccellente mostra Vedova Tintoretto. In dialogo e con quella della GAM NOTTI. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni. Tutti progetti di forte rilievo, particolarmente apprezzati dalla critica, di forte fascino per i visitatori e capaci di confermare la funzione dei musei come spazi di approfondimento, dialogo e ricerca.
Artissima, diretta da Luigi Fassi, alla sua trentaduesima edizione, una delle migliori edizioni di sempre, con un progetto culturale senza pari e con la partecipazione di gallerie da 5 continenti e la presenza a Torino del miglior parterre del mondo dell’arte contemporanea nazionale e internazionale. Artissima continua a confermarsi al vertice dell’eccellente sistema dell’arte contemporanea con il ruolo di piattaforma internazionale di riferimento contribuendo in modo significativo al posizionamento di Torino non solo nel circuito globale delle fiere e degli eventi culturali, ma più radicatamente quale uno dei centri di riferimento nazionale nell’ambito dell’arte contemporanea.
Luci d’Artista grazie al profondo impulso dato al progetto dalla Fondazione e dal curatore Antonio Grulli, ha contribuito a rinnovare il rapporto tra arte contemporanea e città, ha trasformato lo spazio urbano in un’esperienza culturale diffusa e ha rafforzato, anche grazie alle nuove sezioni collaterali, Costellazioni e Duet, la dimensione nazionale e internazionale del progetto. La straordinaria edizione 2025, arricchita da cinque nuove opere di artisti internazionali, si è confermata come uno dei progetti dinamici e attrattivi della Fondazione e come appuntamento imprescindibile dell’autunno-inverno cittadino, con una sua naturale estensione ai restanti mesi dell’anno attraverso un public programinnovativo e coinvolgente per una platea di pubblici in costante rinnovamento. Particolarmente significativo è il programma di conservazione e restauro del patrimonio di opere d’arte, a garanzia della futura continuità del progetto, coronato quest’anno dal monumentale reenactement dell’opera di Joseph Kosuth Doppio Passaggio sulle fiancate del Ponte Vittorio Emanuele. Sono tutti fattori di crescita della manifestazione, che a oggi rappresenta uno dei più rilevanti progetti di arte nello spazio pubblico a livello internazionale.
In questo contesto, GAM, MAO, Palazzo Madama e Artissima hanno accolto complessivamente 650.777 visitatori, a cui si aggiungono circa 435.000 presenze registrate dalle mostre realizzate all’estero: Fondazione Torino Musei raggiunge così complessivamente oltre un milione di utentiincontrati a livello nazionale e internazionale, a conferma della solidità e attrattività di un sistema museale capace di operare con continuità tra dimensione locale e proiezione globale.
Nello specifico, nel corso dell’anno Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica ha superato le250.000 presenze e la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea i 220.000visitatori, confermando la varietà e qualità della loro programmazione. Il MAO Museo d’Arte Orientaleha registrato un significativo incremento di presenze, raggiungendo oltre 138.000 visitatori.
A conferma della rilevanza delle attività della Fondazione come motori di coesione sociale e di partecipazione culturale, nel corso del 2025 è proseguita un’azione significativa e continuativa sul territorio, che ha coinvolto un pubblico ampio e diversificato — insegnanti, studenti, famiglie, adulti e persone con disabilità — permettendo a tutti di vivere il museo in modo attivo attraverso la partecipazione alle numerose iniziative proposte.
Il 2025 in numeri
- 225.952 sono stati i visitatori registrati allaGAM, 138.764 al MAO, e 251.561 a Palazzo Madama; 34.500 sono state le presenze adArtissima.
Nel corso del 2025 la Fondazione Torino Musei ha realizzato:
- 21 mostre e progetti espositivi nei tre musei, tra grandi mostre temporanee, riallestimenti e percorsi di ricerca
- 8 mostre all’estero in Cina, Regno Unito, Spagna, Lettonia e Turchia
- 194 eventi, tra conferenze, attività educative e per famiglie, visite guidate speciali, performance, concerti e incontri pubblici
- 162 opere in prestito, a testimonianza della rilevanza e della diffusione delle collezioni della Fondazione Torino Musei nel panorama museale italiano e internazionale, con presenze in istituzioni quali il Kunstmuseum di Berna, Musée de Cluny di Parigi, Musée Savoisien di Chambéry, Liechtenstein Garten Palace di Vienna, Reggia di Caserta, Gallerie degli Uffizi di Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Roma, Palazzo Reale di Milano, Guggenheim di Venezia e di Bilbao, Galleria d’Arte Moderna di Milano, Palazzo Esposizioni di Roma e MART di Rovereto.
Alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, diretta da Chiara Bertola, il 2025 è stato caratterizzato da una programmazione intensa, capace di intrecciare ricerca storica e sperimentazione contemporanea, rafforzando il progetto delle Risonanze come visione curatoriale riconoscibile e continuativa, che favorisce solidità progettuale e un rapporto duraturo con il pubblico. Tra aprile e settembre il museo ha presentato laSeconda Risonanza. Ritmo, struttura, segno, con la retrospettiva Fausto Melotti. Lasciatemi divertire!, la personale di Alice Cattaneo e i progetti dedicati a River Claure e Giosetta Fioroni. Con la Terza Risonanza. Incanto, sogno, inquietudine, la stagione autunnale si è aperta con la grande mostra NOTTI. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni, affiancata dalle personali di Elisabetta Di Maggio. Frangibile, Linda Fregni Nagler. Anger Pleasure Fear e Lothar Baumgarten. Culture Nature, confermando il ruolo della GAM come luogo di riflessione critica sulla contemporaneità. All’ampia programmazione espositiva si è aggiunto il ciclo di conferenze tra arte e filosofia, che ha coinvolto importanti studiosi. L’anno si concluso con l’annuncio del vincitore del concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del museo a cui hanno partecipato 49 studi di architettura internazionali. Il progetto selezionato, firmato dallo studio MVRDV di Rotterdam con BALANCE Architettura, EP&S Group, Dott. Michelangelo Di Gioia e il Prof. Filippo Busato, immagina una nuova GAM aperta, accessibile e proiettata verso il futuro.
A Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, sotto la direzione di Giovanni Carlo Federico Villa, la programmazione 2025 ha proseguito nel racconto della storia artistica e culturale attraverso mostre capaci di connettere epoche, linguaggi e saperi. Tra l’inizio dell’anno e l’estate, il museo ha ospitato Giro di posta. Primo Levi, le Germanie, l’Europa, Peltri a Torino. La donazione di Attilio Bonci e Visitate l’Italia! Promozione e pubblicità turistica 1900–1950, seguite da Jan van Eyck e le miniature rivelate e Piante e fiori dal mondo. In autunno hanno aperto il Conte Cozio e il mito di Stradivari e Vedova Tintoretto. In dialogo, concludendo l’anno con il progetto in Corte Medievale Il castello ritrovato. Palazzo Madama dall’età romana al Medioevo, rafforzando il legame tra il museo e la storia della città. Accanto al ricco programma di incontri e conferenze, nel 2025 il museo ha proseguito e rafforzato lo sviluppo di progetti dedicati alle scuole, alle circoscrizioni e a tutto il territorio. Alla formazione dei dipendenti comunali sono state dedicate numerose visite guidate, che hanno continuato a registrare un’ampia e partecipe adesione. Si conferma inoltre il forte interesse per i corsi di storia dell’arte, caratterizzati da una grande partecipazione, costante nel tempo.
Il MAO Museo d’Arte Orientale diretto da Davide Quadrio ha vissuto nel 2025 un anno di particolare vitalità, consolidando il proprio ruolo di spazio di dialogo interculturale e di riferimento per la lettura contemporanea delle culture asiatiche. La programmazione espositiva si è articolata tra la conclusione di Hanauri. Il Giappone dei venditori di fiori e i progetti primaverili ed estivi Paesaggi da sogno. Le 53 stazioni della Tōkaidō, Adapted Sceneries e Haori. Gli abiti maschili del primo Novecento narrano il Giappone. L’autunno ha segnato uno dei momenti centrali dell’intera programmazione con l’apertura della grande mostraChiharu Shiota. The Soul Trembles, affiancata da una nuova edizione di Declinazioni Contemporanee, confermando il MAO come luogo di confronto tra patrimoni storici e linguaggi artistici del presente, come dimostra anche la costante e partecipe adesione del pubblico ai numerosi concerti, incontri e appuntamenti dei diversi public program legati alle mostre.
Nel corso delle quattro giornate di apertura,Artissima ha registrato 34.500 presenze tra ospiti, visitatori e professionisti del settore. Sono stati presentati 63 progetti monografici, assegnati 13 premi, riconoscimenti e supporti, ed è stato attivato un fondo di acquisizione.
Le 176 gallerie provenienti da 36 Paesi e 5 continenti, selezionate all’interno di un progetto curatoriale di elevata qualità, hanno portato a Torino una proposta di altissimo profilo, capace di tenere insieme ricerca e mercato, contribuendo a consolidare la reputazione internazionale della fiera come piattaforma di fiducia e innovazione nel panorama delle fiere d’arte contemporanea.
Artissima riconferma così la propria duplice natura di fiera e istituzione: luogo di scambio economico ma anche di elaborazione critica, capace di operare come progetto di diplomazia culturale. L’edizione 2025 ha ulteriormente rafforzato il dialogo con istituzioni internazionali, network museali e nuovi soggetti del collezionismo, aprendo riflessioni sul valore civile e simbolico dell’arte nella società contemporanea.
Con cinque nuove opere realizzate per la straordinaria edizione 2025 da artisti internazionali quali Tracey Emin, Soundwalk Collective con Patti Smith e Philip Glass, Chiara Camoni, Riccardo Previdi e Gintaras Didžiapetris, Luci d’Artistaconferma il percorso di evoluzione quale progetto di arte pubblica strutturato e riconoscibile, configurandosi sempre più come un museo della luce diffuso e a cielo aperto. Accanto alla collezione principale, il format si consolida attraverso programmi stabili quali Costellazione, rete di collaborazioni con musei e istituzioni su scala territoriale e nazionale, e Duet, piattaforma di dialogo e cooperazione internazionale, contribuendo a rafforzare il ruolo di Luci d’Artista come soggetto attivo nel panorama artistico contemporaneo. Una visione che supera i confini stagionali e cittadini, ampliando la notorietà e la fruizione internazionale di un progetto e di una collezione di rilievo crescente.
I progetti internazionali
In coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico, nel corso del 2025 la Fondazione Torino Musei ha sviluppato e attuato una articolata strategia di internazionalizzazione, progettando e realizzando otto mostre in diversi paesi di Europa e Asia. Tra queste Crown of Elegance. Court Life and Art of Savoy in the 18th Century al Guangdong Museum di Guangzhou, che ha richiamato 143.500 visitatori, Shadow and Void: Buddha10 all’esea di Manchester,Encounters from Afar. Paintings from Turin’s Civic Gallery of Modern and Contemporary Art al Chengdu Art Museum, e Horses. Symbols of Millenary Power from the Mediterranean to Jiangnan al Museum of Wu di Suzhou, che con 180.000 biglietti emessi in sei mesi di apertura rappresenta il più rilevante successo del settore.
Nel complesso, i progetti realizzati all’estero hanno coinvolto circa 435.000 visitatori e contribuito in modo significativo alla valorizzazione internazionale del patrimonio museale, con oltre 550 opere delle collezioni esposte fuori dai confini nazionali.
La Fondazione Torino Musei ha inoltre rafforzato la propria presenza nel campo della cooperazione e della formazione internazionale attraverso la realizzazione dell’International Training Program in Museums, promosso e sostenuto dalla Museum Commission dell’Arabia Saudita, in collaborazione con il Victoria and Albert Museum di Londra e il Grand Egyptian Museum del Cairo. Nell’ambito di questo progetto, la Fondazione ha coordinato il programma italiano, offrendo un percorso formativo di alto profilo che ha coinvolto sessanta giovani professionisti sauditi, confermando il ruolo dell’istituzione come interlocutore qualificato nei processi di scambio e sviluppo museale a livello globale.
Il 2025 è stato inoltre un anno significativo dal punto di vista organizzativo, segnato dalla nomina di Marco Minoja quale nuovo Segretario Generale della Fondazione Torino Musei, un passaggio importante in un percorso di consolidamento e sviluppo che guarda al futuro, rafforzando governance, sostenibilità e capacità progettuale dell’ente.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino chiude il 2025 con un totale di oltre 760.000 presenze alla Mole Antonelliana.
“È un risultato importante che conferma il trend positivo di crescita del nostro museo, anche se ha risentito della chiusura dell’ascensore panoramico per manutenzione programmata nei mesi di giugno e luglio” sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema.
“La nostra fondazione consolida il suo ruolo di hub culturale a livello locale, nazionale e internazionale – aggiungono Ghigo e Chatrian – con un coinvolgimento totale di quasi un milione di presenze se si contano tutte la attività afferenti al museo: il Cinema Massimo, Festival CinemAmbiente, Lovers Film Festival, Torino Film Festival e Torino Film Lab, oltre alle mostre e alle iniziative realizzate in collaborazione con prestigiosi enti e realtà culturali.

MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile chiude il 2025 come un anno di profonda trasformazione e di riposizionamento culturale, segnato da un rinnovamento dei linguaggi, degli spazi e delle prospettive del Museo. Un lavoro di profondità e intensità che agisce sulla ridefinizione del Museo come spazio di ricerca, interpretazione e produzione culturale.
Nel 2025 il MAUTO ha registrato 372.200 visitatori, in linea con lo scorso anno nonostante le parziali chiusure dovute ai lavori di aggiornamento del percorso espositivo e la scelta di mostre più di nicchia.
Sul dato complessivo, i visitatori paganti sono stati pari al 67% mentre il 7% sono gli ingressi con Abbonamento Musei e il 9% con la Torino Piemonte Card. Il rimanente 16% sono gli ingressi gratuiti (bambini sotto i 6 anni, accompagnatori, ospiti, media, partecipanti ad eventi, pubblico GP). Il 20% dei visitatori ha effettuato l’acquisto dei biglietti online.
Aprile si attesta come il mese di maggiore affluenza con un totale di 40.754 visitatori.
Il secondo mese migliore dell’anno 2025 è stato agosto con 33.954 presenze.
Nel corso del 2025 il MAUTO ha rinnovato parti significative del percorso espositivo e inaugurato due nuove sezionidedicate al futuro della mobilità e al design, ridefinendo il rapporto tra collezione, progetto e contemporaneità. Centrale in questo processo è stata la riscrittura dell’apparato didascalico, pensata per restituire la collezione come patrimonio culturale e per offrire una lettura critica dell’automobile come fenomeno storico, sociale e simbolico.
Con The Future Unfolds, sezione dedicata all’innovazione e alla mobilità sostenibile, e con Spazio Design, area di oltre 2.000 mq dedicata alla creatività industriale e al processo progettuale, il Museo ha ampliato il proprio campo di ricerca e narrazione. A novembre ha preso avvio Convergenze, progetto curatoriale a cura di Giacinto Di Pietrantonio, che introduce un dialogo strutturato tra automobile e arte contemporanea lungo l’intero percorso espositivo.
Nell’ottica di raggiungere gli obiettivi che si era dato a inizio anno – l’apertura a nuovi pubblici attraverso una diversificata serie di azioni di valorizzazione dello straordinario patrimonio conservato e la produzione di contenuti inediti capaci di parlare i linguaggi della contemporaneità – il Museo ha attivato collaborazioni interistituzionali con diversi interlocutori al fine di restituire una lettura attuale e trasversale della propria storia.
Il fantasma del castello di Agliè
A cura di Piemonteitalia.eu
Leggi l’articolo:
https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/il-fantasma-del-castello-di-agliè
A cura di piemonteitalia.eu
ESPERIENZE
Avigliana, situata in un punto di transito tra Italia e Francia, nell’anfiteatro morenico compreso tra il Monte Pirchiriano, sul quale sorge la Sacra di San Michele, e la collina di Rivoli, in passato godette di molto prestigio…
Leggi l’articolo ↘️
https://www.piemonteitalia.eu/it/esperienze/il-borgo-di-avigliana-una-tappa-imperdibile-della-francigena