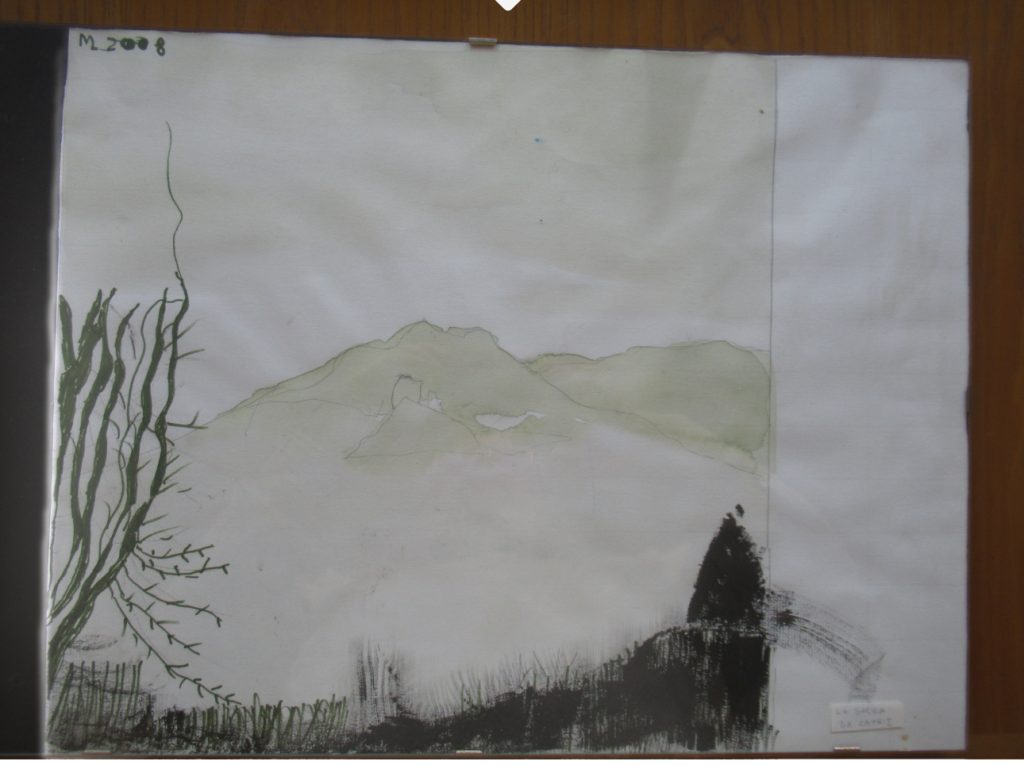Teatro Superga, Nichelino (TO)
Sabato 22 novembre, ore 21
Dario Ballantini porta sul palco del Teatro Superga, sabato 22 novembre, un omaggio personale e toccante all’amico e grande cantautore Lucio Dalla con Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta. Uno spettacolo che parla di Lucio Dalla attraverso la vita di Dario che, da fan, giovane imitatore e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e rappresentazioni, fino al loro incontro, avvenuto vent’anni dopo, in cui i ruoli si sono invertiti facendo si che Lucio diventasse un sostenitore di Dario, come pittore e trasformista. Ballantini con i musicisti, racconta i passaggi della carriera di Dalla, cantando con la voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui. Tra un brano e l’altro, scorrono le decine di foto tratte dai disegni di Ballantini sui diari scolastici che rivelano la maniacale passione per Dalla.
Info
Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO)
Sabato 22 novembre 2025, ore 21
Da Balla a Dalla
Con Dario Ballantini
Progetto e regia Massimo Licinio
Scritto e cantato da Dario Ballantini
Musicisti: Francesco Bendinelli, Federico Gaspari, Tancredi Lo Cigno, Nicola Sciarpa, Matteo Zecchi
Biglietti: platea 23 euro, galleria 17,25 euro
www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it
IG + FB: teatrosuperga
Orari biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19
I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it



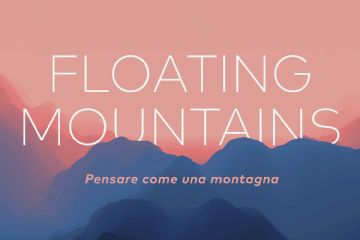





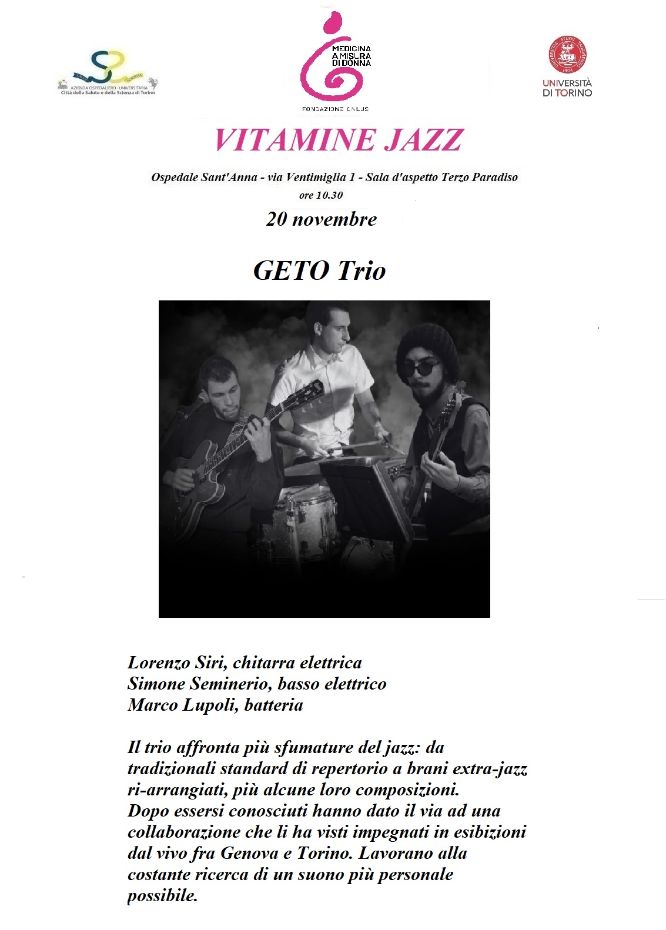





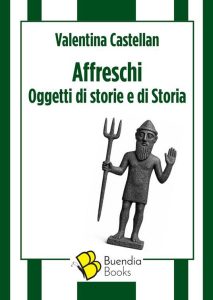




 Scrive bene Anna Maria Borgna: “Michele si avventura nel mondo della pittura con l’audacia di un nuotatore nel suo elemento: cattura e domina lo spazio, traccia con forza le forme e accosta con intensità i colori preferiti (tra cui il viola, il giallo e il rosso) usando a volte pastose materie, a volte colori ad acqua trasparenti, lasciandosi andare a pennellate rapide o lente e morbide, oppure aggredendo il foglio con segni graffianti di spatola, fino a che non è appagato dal risultato”. E fa capolino un po’ di qua e un po’ di là. Del resto, i campi su cui correre e agguantare la lunga scala che porta alla “luna” sono tanti. E inaspettati. Fra i lavori in legno di geometrica, astratta spazialità, notiamo anche una “chitarra classica”. Un lavoro a quattro mani magnificamente realizzato insieme all’amico – fraterno Andrea Albrile, fra i massimi “passionate luthiers” di Torino, che racconta: “Il legno gioca con i colori così come l’arte di Michele incontra la mia passione per la liuteria … E proprio per gioco, attraverso questi anni, ci siamo divertiti a dare nuova vita a ritagli e forme, a capovolgere i cosiddetti errori e scarti di lavorazione … fino all’incontro dei nostri due mondi nella chitarra classica esposta in mostra”.
Scrive bene Anna Maria Borgna: “Michele si avventura nel mondo della pittura con l’audacia di un nuotatore nel suo elemento: cattura e domina lo spazio, traccia con forza le forme e accosta con intensità i colori preferiti (tra cui il viola, il giallo e il rosso) usando a volte pastose materie, a volte colori ad acqua trasparenti, lasciandosi andare a pennellate rapide o lente e morbide, oppure aggredendo il foglio con segni graffianti di spatola, fino a che non è appagato dal risultato”. E fa capolino un po’ di qua e un po’ di là. Del resto, i campi su cui correre e agguantare la lunga scala che porta alla “luna” sono tanti. E inaspettati. Fra i lavori in legno di geometrica, astratta spazialità, notiamo anche una “chitarra classica”. Un lavoro a quattro mani magnificamente realizzato insieme all’amico – fraterno Andrea Albrile, fra i massimi “passionate luthiers” di Torino, che racconta: “Il legno gioca con i colori così come l’arte di Michele incontra la mia passione per la liuteria … E proprio per gioco, attraverso questi anni, ci siamo divertiti a dare nuova vita a ritagli e forme, a capovolgere i cosiddetti errori e scarti di lavorazione … fino all’incontro dei nostri due mondi nella chitarra classica esposta in mostra”.