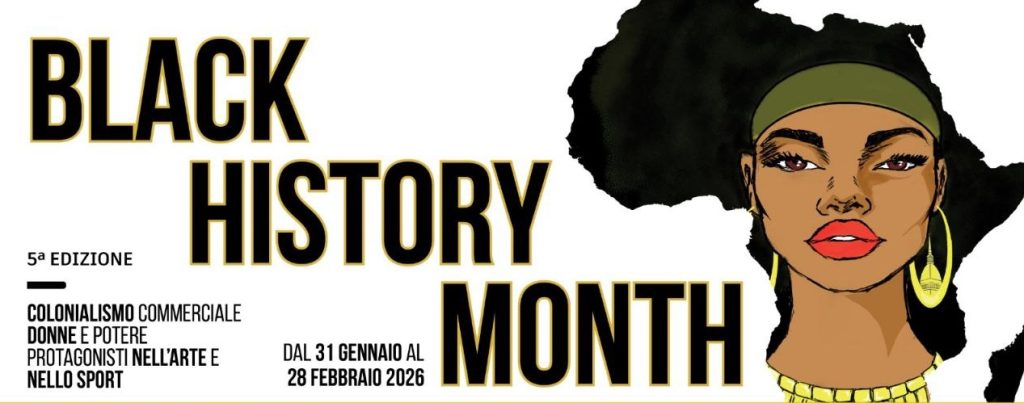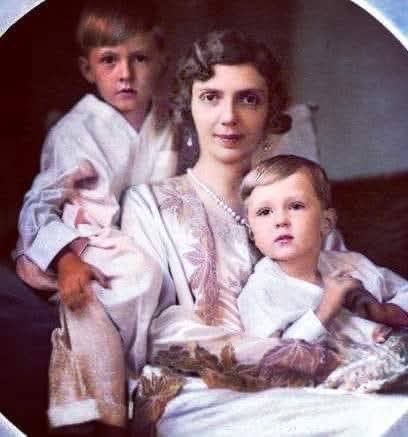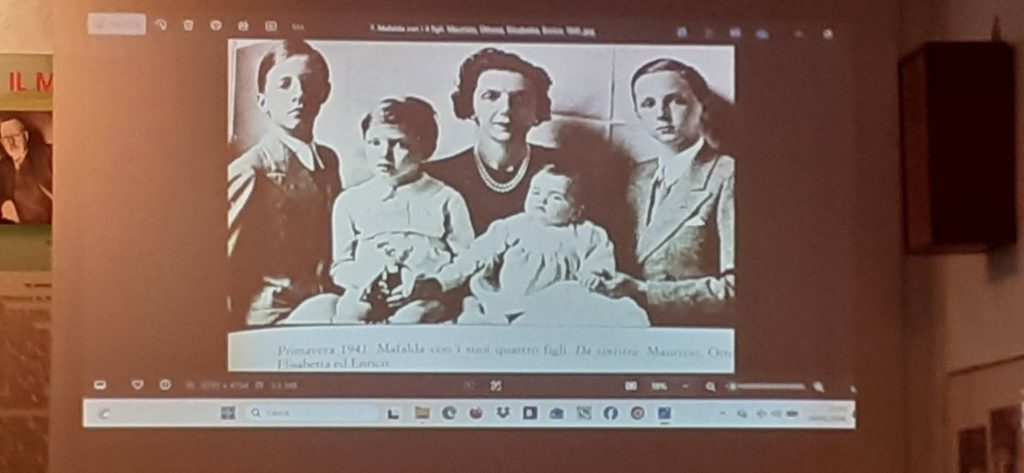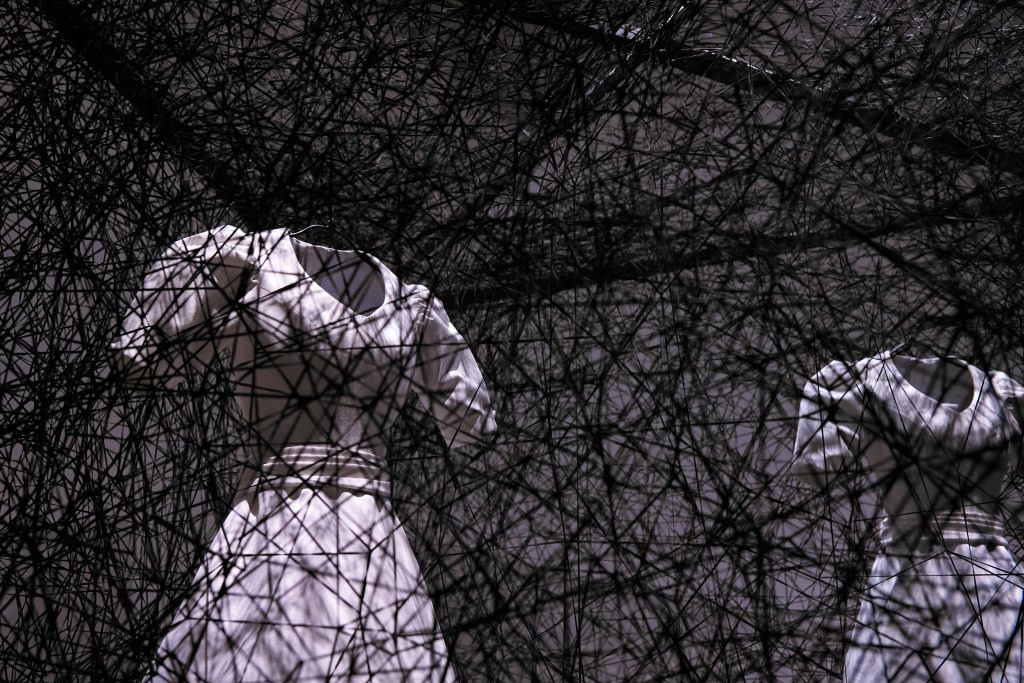La Palazzina di Caccia di Stupinigi si racconta come luogo di festa e di spettacolo, e domenica 1 febbraio un appuntamento speciale unirà una visita tematica dedicata alla vita mondana della residenza all’opera lirica “Tosca” di Giacomo Puccini, eseguita dall’Ensemble Belliners. L’evento prenderà avvio alle 15.45 con “La festa e lo spettacolo a Stupinigi”, una visita tematica della Palazzina che accompagnerà i visitatori alla scoperta degli spazi che hanno ospitato cerimonie, matrimoni, banchetti e momenti di intrattenimento. Si tratta di un percorso che restituisce il ruolo centrale di Stupinigi come luogo di ritrovo prima e dopo le battute di caccia, pensato per il divertimento della corte. Alle 17 la musica diventerà protagonista con la “Tosca” di Puccini, proposta in una versione originale dell’Ensemble Belliners. L’opera viene presentata in una rivisitazione cameristica per quartetto d’archi e oboe, con musiche trascritte da Gabriele Colombo, dalle partiture di Giacomo Puccini. Nonostante la riduzione e d’organico rispetto alla versione operistica originale, la tensione drammatica dell’opera è mantenuta attraverso una narrazione che accompagna l’esecuzione musicale. Tutti i momenti musicali più significativi sono presenti e alter ATI al racconto della vicenda.
L’Ensemble Belliners nasce nell’agosto 2023 dopo anni di collaborazione tra i musicisti durante il percorso di studi al Conservatorio di Torino. Il gruppo si distingue oer un linguaggio musicale e comunicativo innovativo, con spettacoli sempre molto apprezzati. Il loro repertorio è ampio, ma particolarmente incentrato sul melodramma. I componenti dell’Ensemble sono Giovanni Putzulu e Francesco Costamagna ai violini, Simone De Matteis alla viola, Mitja Liboni al violoncello e Gabriele Colombo, oboe, corno inglese e narratore.
Concerto gratuito compreso nel biglietto d’ingresso. Visita tematica: 5 euro oltre al biglietto d’ingresso: intero 12 euro – ridotto 8 euro – gratuito per persone con disabilità e accompagnatori, minori di sei anni e possessori di abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card. Prenotazione obbligatoria per la visita tematica entro il venerdì precedente allo 011 6200601 – stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it
Orari: da martedì a venerdì 10-17.30, ultimo ingresso ore 17 / sabato, domenica e festivi 10-18.30, ultimo ingresso ore 18.
Mara Martellotta