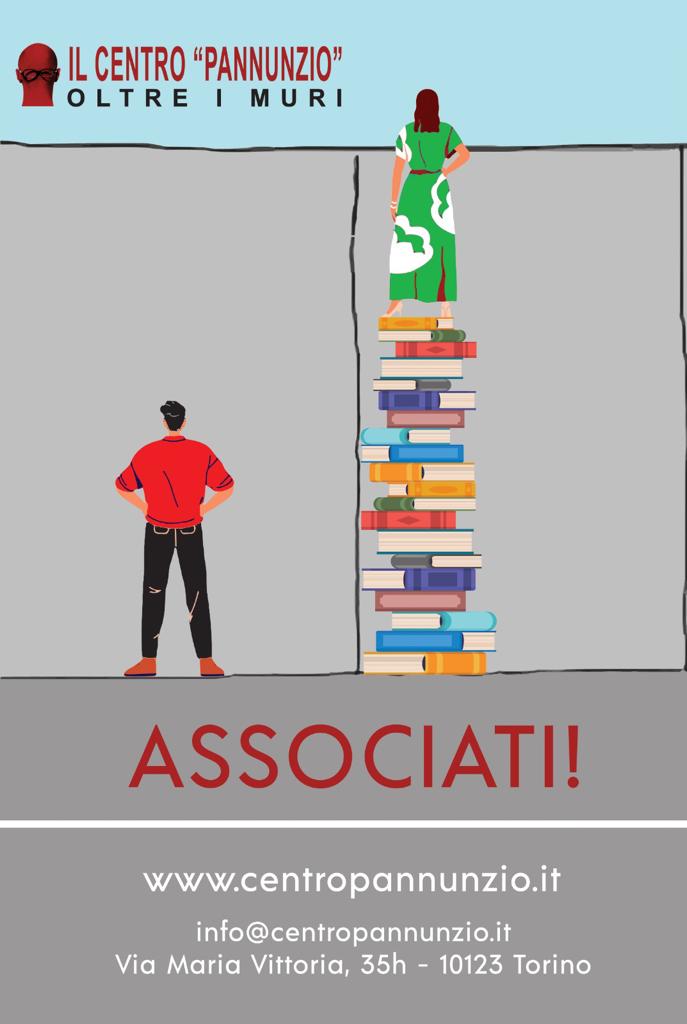Il 2024 consolida l’andamento positivo per donazioni e trapianti in Piemonte. Le donazioni di organi hanno raggiunto il secondo miglior risultato di sempre e hanno permesso di realizzare 496 trapianti . Ha anche portato in dote un traguardo prestigioso: 10.000 trapianti eseguiti presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Questo è un primato nazionale, raggiunto grazie alla presenza di tutti i programmi di trapianto in un’unica Azienda Sanitaria, razionale utilizzato solo da questa Regione. Città della Salute si conferma l’ospedale al vertice di questa attività in Italia per la quarta volta negli ultimi cinque anni; Torino si conferma capitale dei trapianti.
Questi risultati dimostrano la grande sensibilità dei nostri cittadini e la professionalità e organizzazione della nostra sanità. I dati dell’attività sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa presenti l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, il Direttore del Centro Regionale Trapianti Federico Genzano Besso, il Coordinatore Regionale Donazioni e Prelievi di Organi e Tessuti Anna Guermani ed il Direttore Generale facente funzioni dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Emanuele Ciotti.
“Il Piemonte si conferma un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo nel campo della donazione e dei trapianti. Questo straordinario traguardo deve spronarci a rafforzare il nostro impegno per raggiungere nuovi obiettivi di progresso. Un sincero ringraziamento va a tutti i professionisti, in particolare della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che, in queste complesse attività, uniscono eccellenza tecnica e straordinarie qualità umane. Un riconoscimento doveroso anche alle Associazioni dei donatori di sangue e a quelle attive nella donazione e nei trapianti di organi, tessuti e cellule. L’ultimo, ma più intenso, ringraziamento è rivolto ai donatori e alle loro famiglie, il cui altruismo ha reso possibile salvare tante vite umane”- afferma l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.
Donazioni stabilmente alte
Il 2024 è stato un anno positivo per le donazioni. I donatori sono stati 171 (39,1 per milione di popolazione – pmp), il secondo miglior risultato di sempre. Nello scenario nazionale – l’Italia in toto è salita da 28.2 a 30.2 pmp – la nostra Regione si pone ancora una volta fra le migliori per procurement di organi. Tutti i programmi si sono consolidati. I donatori di organi con cuore battente (DBD) sono stati 143; il 38,5% di queste donazioni sono avvenute negli ospedali senza neurochirurgia, dimostrando che la donazione di organi può avvenire in ogni ospedale con Terapia Intensiva. I donatori di organi con cuore fermo (DCD) sono stati 28, con un incremento del 22%; gli ospedali autorizzati ad eseguire questa forma di donazione molto complessa per tecnica e organizzazione sono il San Giovanni Bosco, Molinette e Maria Vittoria di Torino, l’Ospedale di Alessandria, l’Ospedale di Cuneo, l’Ospedale di Novara, l’Ospedale di Rivoli; in queste strutture avvengono altresì i prelievi dei donatori identificati in numerosi ospedali della Rete (nel 2024 a Chivasso, CTO, Pinerolo, Orbassano, Savigliano, Moncalieri). I donatori di cornee sono stati 1.191 con un incremento del 16%. Questa forma di donazione ha visto coinvolti anche gli ospedali privi di rianimazione, numerosi reparti di cure oncologiche e Hospice, per il forte valore consolatorio insito nella donazione.Le opposizioni alla donazione sono state al 29,5%, dato sovrapponibile a quello della Nazione. Sempre più rilevante il peso della dichiarazione registrata nel Sistema Informativo Trapianti: dei 263 potenziali donatori, 90 avevano una dichiarazione nella banca dati ministeriale (34%).
Progetto “Una scelta in comune”
Il 2024 è stato anche l’anno nel quale il Piemonte ha visto completarsi l’iniziativa di adeguamento normativo denominata “una scelta in comune” (legge 98/2013). Con la prima dichiarazione registrata dal comune di Sessame (AT) a dicembre e inviata al Sistema Informativo Trapianti, si è concluso un percorso iniziato nel 2014 presso il comune di Settimo Torinese. Il Piemonte è diventata la prima regione, tra le più popolose d’Italia, nella quale tutti i Comuni hanno trasmesso almeno una dichiarazione di volontà alla donazione degli organi in occasione del rinnovo della carta d’identità.
Il focus sui trapianti
L’eccellente risultato registrato nel numero di donazioni, unito alle competenze del Centro Regionale Trapianti e alla capacità tecnica e gestionale dei centri trapianto, ha permesso al Piemonte di raggiungere il secondo miglior risultato di sempre. Nel 2024 sono stati effettuati 496 interventi, per un totale di 536 organi trapiantati, 6 volte in combinazioni simultanee nello stesso ricevente, i cosiddetti trapianti “combinati”: presso l’ospedale Molinette sono stati eseguiti 2 trapianti combinati rene-fegato, 2 rene-pancreas e 2 cuore-fegato. Il trapianto combinato cuore-fegato rappresenta un primato nazionale, essendo la prima volta che questa tipologia di trapianto combinato viene realizzata in Italia.La Città della Salute e della Scienza di Torino si conferma al vertice dell’attività trapiantologica in Italia, con un totale di 449 trapianti eseguiti nel 2024: 440 presso l’ospedale Molinette e 9 presso l’Ospedale Pediatrico. Il centro trapianto di fegato, con i suoi 179 trapianti, e il centro trapianti di rene, con i suoi 219 interventi, confermano il primato nazionale. Molto rilevanti i risultati per il trapianto di cuore, con 28 trapianti effettuati alle Molinette – che comprendono 6 organi da donatori DCD – e 5 presso l’Ospedale Pediatrico, nonché per il trapianto di polmoni, con 22 interventi realizzati. Unica altra sede di trapianto in Piemonte, l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara ha effettuato 47 trapianti di rene.
La qualità dei programmi di trapianto è in linea con i migliori standard internazionali. La donazione da vivente, realtà importante in Piemonte, ha visto 15 trapianti di rene e un trapianto di fegato a dicembre, con un papà che ha donato una parte del proprio fegato a beneficio della figlia. Il trapianto di tessuti migliora la qualità della vita e la nostra Regione si distingue anche in questo ambito le Banche dei Tessuti sono attive per tutte le richieste dei chirurghi specialisti, e i trapianti del 2024, vicini ai 1.400, confermano i valori del 2023.Nel corso del 2024, 3.390 giovanissimi si sono messi a disposizione per donare le loro cellule staminali emopoietiche o CSE (midollo osseo), con un aumento di quasi il 50% rispetto al 2023.Il Piemonte si conferma un punto di riferimento a livello nazionale non solo per l’elevato volume di attività trapiantologica, ma anche per il contributo fornito in diversi ambiti strategici. La regione ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di protocolli e linee guida nazionali e europee, tra cui i nuovi programmi di allocazione degli organi, il registro della malattia renale cronica e le Linee Guida Europee sulla Biovigilanza nei trapianti di Organi, Tessuti e Cellule. Inoltre, si distingue come centro di eccellenza per la diagnosi di malattie genetiche che possono beneficiare del trapianto, rafforzando così il proprio valore nel panorama sanitario nazionale. Malgrado l’impegno e i risultati della rete trapiantologica, sono ancora molti i pazienti che attendono di ricevere un organo nelle nostre liste: al 31 dicembre del 2024 ne registriamo 621 in attesa di trapianto di rene, 66 di fegato, 143 di cuore e 73 di polmone. È dunque ancora forte il dovere e l’impegno di cura verso questi pazienti.
10.000 trapianti a Torino: primato nazionale
L’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è la prima Azienda Sanitaria in Italia a raggiungere questo traguardo, ottenuto grazie alla centralizzazione di tutti i programmi di trapianto, eccetto quello del rene, assetto organizzativo esclusivo della Regione Piemonte. Torino si conferma, dunque, la capitale dei trapianti.Ripercorrendo velocemente quarant’anni di attività trapiantologica: nel 1981 viene effettuato il primo trapianto di rene, nel 1990 il primo di fegato ed il primo di cuore, nel 1993 il primo di polmone e, infine, nel 1999 il primo di pancreas. E’ un trapianto di rene, eseguito il 31 luglio, a raggiungere il decimillesimo intervento dall’inizio delle attività in Città della Salute. A fine 2024 si contano 10.186 trapianti a Torino. Per celebrare questo importante traguardo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria promuove un evento dedicato ai professionisti della sanità: “I 10.000 trapianti di organo della Città della Salute di Torino: tra sostenibilità e innovazione”, che si terrà il 25 marzo alla Molinette.
Responsabili dei Programmi
Un ringraziamento è indispensabile ai responsabili dei programmi di trapianto e alle loro equipe mediche ed infermieristiche. Per la Città della Salute di Torino sono: Luigi Biancone per il trapianto di rene nell’adulto, Mauro Rinaldi per i trapianti di cuore e polmoni, Renato Romagnoli per i trapianti di fegato e di pancreas, Bruno Gianoglio per quello renale pediatrico e Carlo Pace Napoleone per il trapianto di cuore pediatrico.Per l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, il responsabile del programma di trapianto renale è Vincenzo Cantaluppi.


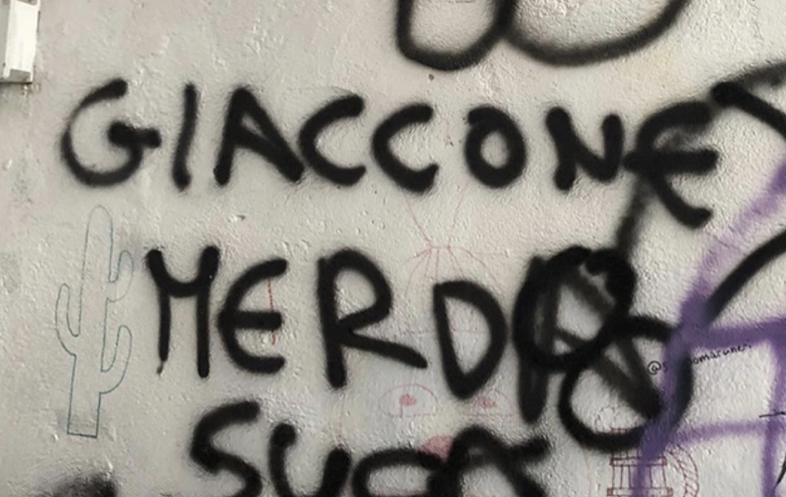









 Il consigliere comunale Silvio Viale con la ben nota intempestività (la malattia del Papa preoccupa tanti, non solo i cattolici) fa la sua ennesima esibizione, che non meriterebbe una citazione, sul crocifisso nell’Aula del consiglio comunale. Dopo le tante provocazioni fuori luogo di Viale la presidente del Consiglio Comunale Grippo ha giustamente sospeso i lavori del consiglio, non potendosi tollerare una mina vagante che vorrebbe essere anticonformista, che perfino con i suoi abiti vuole esibire se stesso, appigliandosi ad ogni scusa. Viale smetta di dirsi radicale, Pannella ripudierebbe i suoi sistemi. Ma soprattutto sono i laici rispettosi di ogni fede che rifiutano Viale che dovrebbe in primis chiarire la sua posizione con le sue pazienti. E’ strano che l’Ordine dei medici e l’ospedale non l’abbiano cautelativamente sospeso. Per uno sguardo ad una studentessa che non ha fatto esposti, il prof. Vercellone nel silenzio codardo di tutti di fatto ha perso il diritto di insegnare.
Il consigliere comunale Silvio Viale con la ben nota intempestività (la malattia del Papa preoccupa tanti, non solo i cattolici) fa la sua ennesima esibizione, che non meriterebbe una citazione, sul crocifisso nell’Aula del consiglio comunale. Dopo le tante provocazioni fuori luogo di Viale la presidente del Consiglio Comunale Grippo ha giustamente sospeso i lavori del consiglio, non potendosi tollerare una mina vagante che vorrebbe essere anticonformista, che perfino con i suoi abiti vuole esibire se stesso, appigliandosi ad ogni scusa. Viale smetta di dirsi radicale, Pannella ripudierebbe i suoi sistemi. Ma soprattutto sono i laici rispettosi di ogni fede che rifiutano Viale che dovrebbe in primis chiarire la sua posizione con le sue pazienti. E’ strano che l’Ordine dei medici e l’ospedale non l’abbiano cautelativamente sospeso. Per uno sguardo ad una studentessa che non ha fatto esposti, il prof. Vercellone nel silenzio codardo di tutti di fatto ha perso il diritto di insegnare.