YOGA SENZA BARRIERE
Con l’arrivo dei giorni più freddi, è comune sentirsi più pigri e meno energici.
Tuttavia, lo yoga offre un’ancora di salvezza per mantenere il corpo attivo e rivitalizzare la mente.
In questo articolo, esploreremo tre pose di yoga – Guerriero 1, Guerriero 2 e Guerriero 3 – che sono particolarmente efficaci per stimolare l’energia interna e mantenere il corpo in equilibrio durante la stagione invernale.
Iniziate in piedi con i piedi distanti quanto le vostre spalle.
Portate il piede destro indietro, mantenendo il tallone a terra e ruotate il corpo verso sinistra.
Sollevate le braccia sopra la testa, unendole o mantenendole separate.
Questa posizione apre il petto e le spalle, fornendo una scarica di energia mentre migliora la forza delle gambe.
Tenete la posizione per 30 secondi, poi ripetete sul lato opposto.
Dalla posizione eretta, allargate le gambe e ruotate il piede destro di 90 gradi.
Piegate il ginocchio destro sopra la caviglia, mantenendo il ginocchio sinistro teso.
Estendete le braccia parallelamente al pavimento, guardando oltre le dita della mano destra.
Questa posa potenzia la resistenza e la stabilità, aiutandovi a ritrovare forza nelle giornate più buie.
Tenete la posizione per 30 secondi, poi cambiate lato.
Dal Guerriero 1, spingete il corpo in avanti trasferendo il peso sulla gamba anteriore.
Sollevate la gamba posteriore, mantenendola dritta e parallela al suolo.
Le braccia dovrebbero essere stese in avanti, parallelamente al pavimento.
Questa posa sfida l’equilibrio e potenzia i muscoli centrali, riempiendo il corpo di nuova vitalità.
Tenete la posizione per 30 secondi e ripetete sull’altro lato.
Queste tre pose di guerriero sono un’aggiunta preziosa alla vostra pratica yoga invernale.
Oltre a stimolare l’energia, contribuiscono anche a migliorare la flessibilità e la concentrazione.
Aggiungete queste pose alla vostra routine quotidiana per affrontare la stagione con una mente e un corpo rinforzati, pronti ad affrontare qualsiasi sfida che possa presentarsi.
Namasté
Serena Fornero – @odakawithserena





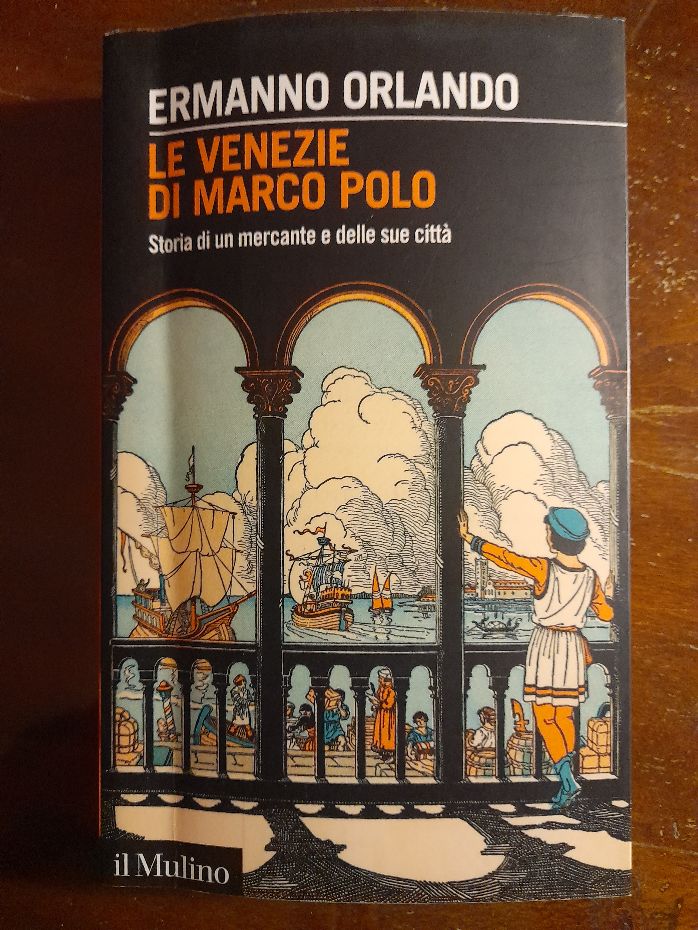

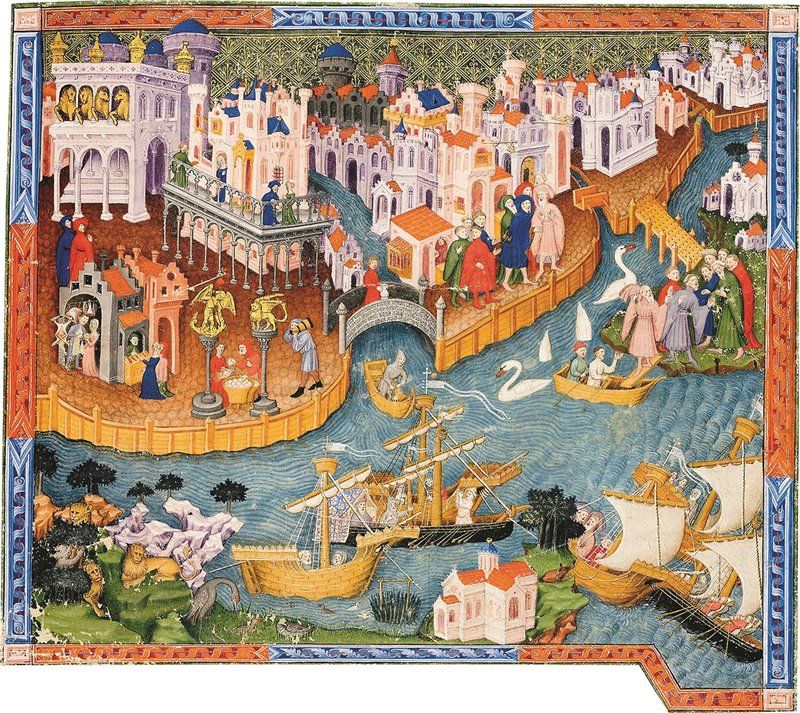






 Torna da gennaio la pace contributiva
Torna da gennaio la pace contributiva