Informazione promozionale
Un caffè, una cioccolata calda con panna, un buon Bicerin…Non importa quale bevanda si desideri gustare, i caffe storici Torino offrono una vasta scelta di proposte se si desidera trascorrere amabilmente il proprio tempo mentre si visita la città, sia che si tratti per piacere che per attività di team building aziendale anche legate a tematiche culinarie/culturali come Torino Golosa, un viaggio alla scoperta dei segreti delle prelibatezze tra storia ed enogastronomia, o per altre questioni.
La città sabauda è famosa per la sua tradizione di colazioni a Torino, un rito che viene celebrato in numerosi locali che vantano un’atmosfera unica e raffinata.
Una pasticceria storica di Torino o per meglio dire, le tante storiche pasticcerie moderne torinesi, offrono molte prelibatezze e dolci tipici che arricchiscono l’esperienza di una colazione elegante, proprio come si usava fare nei salotti borghesi di fine Ottocento e inizio Novecento, quando i caffè erano considerati luoghi di incontro per personalità illustri della letteratura.
Dei tanti Caffè storici Torino, oggi, ve ne segnaliamo alcuni, veri e propri vanti della città, non solo per gli amanti del caffè e dei cioccolatini tipici di Torino, ma per tutti gli amanti dell’architettura, della storia e dei viaggi. Senza indugi, ecco i nostri consigli.
Caffè San Carlo: Re dei bar storici Torino
Con i suoi capitelli corinzi, statue e dorature, il Caffè San Carlo è un’icona e sovrano dei bar storici Torino senza tempo e che racchiude il fascino del Risorgimento e delle floride correnti artistiche che hanno attraversato la città.
Questo caffè storico torinese, situato nell’omonima piazza – considerata dai torinesi una delle più belle della città – è stato il set di numerosi film e fiction grazie alla sua atmosfera unica e suggestiva.
Sedendosi ai suoi eleganti tavolini, si può ammirare la bellezza di Palazzo Solaro del Borgo, capolavoro del Rococò, e delle due chiese gemelle, Santa Cristina e San Carlo, esempi perfetti dell’architettura barocca. Con quasi 200 anni di storia, il Caffè San Carlo è il luogo ideale per una pausa raffinata, immersi nell’arte e nella cultura, gustando la migliore colazione della città, ad esempio.
Un punto di riferimento tra i bar storici di Torino, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in un’esperienza indimenticabile.
Barney’s, caffè di Torino del Circolo dei Lettori
Il Barney’s, situato all’interno del suggestivo Circolo dei Lettori di Torino, è uno dei caffè storici più rinomati della città, un luogo dove tradizione e modernità si fondono alla perfezione.
Qui, è possibile vivere l’esperienza della migliore colazione torinese, immersi in un’atmosfera raffinata e accogliente. Con una selezione di dolci torinesi che spaziano dai classici gianduiotti alle delicate paste artigianali, il Barney’s offre una colazione elegante che soddisfa ogni palato. Un vero e proprio tempio per gli amanti del caffè e della buona lettura, dove ogni dettaglio racconta la storia e la cultura di una città che ha fatto del caffè e della letteratura un’arte.
Baratti&Milano: l’eccellenza della pasticceria torinese e della cioccolateria
In Piazza Castello, sorge uno dei caffè storici torinesi e pasticceria torinese più iconici: Baratti&Milano.
Nato nel 1858, è da oltre un secolo un elegante salotto sabaudo, punto di ritrovo per intellettuali, artisti e figure di spicco della politica e della scienza.
Il suo raffinato stile liberty evoca atmosfere d’altri tempi, rendendolo uno dei bar famosi di Torino, perfetto per chi ama i locali particolari con un fascino senza tempo.
Fiore all’occhiello di questa storica caffetteria è la sua pasticceria torinese e la cioccolateria d’eccellenza, con specialità imperdibili. Tra i piaceri da gustare spicca il Bicerin, l’iconica bevanda calda della tradizione torinese, preparata con cioccolato fondente, caffè e latte montato, perfetta per le giornate più fredde. Da provare anche il Caffè Baratti&Milano, un espresso arricchito con crema di nocciole, panna e granella di nocciole, una coccola raffinata adatta a qualsiasi momento della giornata.
La Farmacia del Cambio, caffè di Torino dalle brioches celebri e virali
Questo storico caffè di Torino è molto più di una semplice caffetteria: è un’esperienza sensoriale e culturale che unisce sapori pregiati, architettura d’epoca e un’atmosfera senza tempo.
Nella centralissima Piazza Carignano, la proprietà dello storico ristorante Del Cambio, vero e proprio caffè storico di Torino, ha rilevato un’antica farmacia trasformandola in una raffinata pasticceria. Questo locale, tra i Torino locali particolari più affascinanti, unisce arredi in legno, cristalleria e vetrine dall’atmosfera vintage a un’offerta di dolci ultra-contemporanei, diventando un punto di riferimento per le pasticcerie moderne della città. Tra le specialità spiccano i celebri Crubik e la Sfera, croissant a forma di cubo e sfera che hanno conquistato i social, insieme al pain suisse, alla girella con gocce di cioccolato e arancia, e alla brioche al cacao farcita di crema al gianduia. Non mancano torte moderne, monoporzioni eleganti e lievitati salati, ideali per chi cerca una colazione alternativa senza rinunciare al gusto e alla raffinatezza. Un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, regalando un’esperienza indimenticabile.
Locali storici di Torino: Pfatisch
Uno dei locali storici di Torino che ancora oggi conserva il fascino di un’epoca dorata è senza dubbio la Pasticceria Pfatisch, fondata nel 1915 dal maestro cioccolatiere Gustavo Pfatisch.
Questa pasticceria storica Torino ha visto passare tra i suoi tavoli figure illustri come i principi di Savoia, Cesare Pavese, Primo Levi, Indro Montanelli, Mario Soldati e Norberto Bobbio. Situata in un meraviglioso edificio Liberty di via Sacchi, progettato dall’architetto Pietro Fenoglio, la pasticceria ha mantenuto intatti i suoi interni Art Déco, diventando un autentico gioiello inserito nell’Associazione Locali Storici d’Italia.
Ma la vera sorpresa si trova nel seminterrato: un laboratorio di produzione completo, dedicato alla lavorazione artigianale del cioccolato torinese. Oggi questa perla fa parte del Choco-Story Torino, il museo del cioccolato che accompagna i visitatori in un viaggio dalle civiltà precolombiane fino all’evoluzione della cioccolateria torinese, con un focus sui cioccolatini tipici di Torino. Un’esperienza imperdibile per golosi di tutte le età, perfetta anche per le famiglie con bambini.
Caffè Platti: bellissimo e ottocentesco caffè storico Torino
Fondato nel 1870, il Caffè Platti è uno dei caffè storici di Torino più eleganti e raffinati.
Situato in Corso Vittorio Emanuele II, questo caffè storico Torino da oltre un secolo riesce a mantenere intatta un’atmosfera d’altri tempi, con sontuosi lampadari e un banco bar in stile anni Venti. I colori caldi e i magnifici stucchi rendono l’ambiente ancora più fiabesco, trasformando ogni visita in un’esperienza unica.
In passato, il Caffè Platti è stato frequentato da intellettuali e personalità di spicco come Luigi Einaudi, Giulio Einaudi, Cesare Pavese, Luigi Lavazza e il Senator Agnelli.
Ma il Platti è anche un luogo simbolico della storia sportiva: proprio di fronte al locale, nel 1897, un gruppo di studenti del Liceo Massimo D’Azeglio fondò quello che sarebbe diventato uno dei club calcistici più importanti d’Italia, la Juventus.
Tra le prelibatezze che offre, non può mancare di citare la sua pasticceria torinese, con la sua iconica Torta Platti, un dolce dal cuore morbido e una vellutata copertura al gianduja, la cui ricetta è gelosamente custodita.
Oltre alla pasticceria storica di Torino, il Caffè Platti propone anche un’ampia selezione di tramezzini ideali per un pranzo veloce.
Cosa dovresti assolutamente ordinare? Senza dubbio i deliziosi dolci torinesi e la pasticceria mignon. Per una merenda sostanziosa, non perdere la Plattina, la leggendaria torta del caffè in dimensioni ridotte.
Caffe storici Torino, come non citare Caffè Al Bicerin
Nel cuore del Quadrilatero Romano, il Caffè Al Bicerin è uno dei più celebri caffe storici Torino, nonché uno dei bar famosi Torino, grazie alla sua lunga tradizione e all’invenzione della storica bevanda piemontese che porta il suo nome. .
Nato a fine Settecento, questo caffè storico di Torino è il luogo in cui è stato creato il Bicerin, un raffinato mix di caffè, cioccolato e crema di latte, oggi riconosciuto come bevanda tradizionale piemontese e divenuto un autentico simbolo cittadino.
Perfetto per chi desidera una colazione elegante, il locale accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera senza tempo, tra boiserie in legno, un bancone storico e piccoli tavolini in marmo che raccontano la storia e il fascino di una Torino d’altri tempi.
Colazioni a Torino: non solo caffè storici
Diamo uno sguardo anche ad altri locali particolari Torino
Nel panorama delle colazioni a Torino, il Bar Tiratisù si distingue come uno dei locali particolari Torino, perfetto per gli amanti dei dolci e delle esperienze gourmet. Situato nel cuore della città, questo locale è un vero paradiso per chi desidera iniziare la giornata con una colazione ricercata e golosa.
La sua specialità? Le brioches proposte in diverse varianti e preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, accanto a un’ampia selezione di dolci torinesi. Con il suo ambiente accogliente e moderno, il Bar Tiratisù è la scelta ideale per chi vuole concedersi un momento di dolcezza in un contesto elegante e innovativo.
La Torteria Berlicabarbis è uno dei locali particolari Torino, un angolo di dolcezza che combina il fascino delle pasticcerie moderne con il calore di una tradizionale sala da tè.
Nata nel 2012, ha conquistato i torinesi con la sua straordinaria selezione di dolci torinesi, tra cui una ventina di torte preparate ogni giorno, con le cheesecake come protagoniste indiscusse. Impossibile resistere ai croissant al pistacchio, grandi e golosi, il cui nome richiama proprio l’espressione dialettale “Berlicabarbis”, che significa “da leccarsi i baffi”.
Oltre alle prelibatezze di pasticceria, il locale vanta un’incredibile selezione di 130 tipi di tè e tisane e ben 15 caffè alla piemontese, in cui il caffè si fonde con cioccolato, gianduia e granella di pistacchio, regalando un’esperienza unica per ogni amante del dolce e del buon vivere.
In via Cavour 10, Perino Vesco è molto più di un semplice panificio: unisce l’arte della panificazione a un’ampia offerta di dolci, rendendolo un indirizzo imperdibile tra i migliori caffè di Torino e un esempio di pasticcerie moderne in città.
Dal salato al lato dolce, le torte da forno – con la langarola alla nocciola in testa – le crostate, i plumcake, gli strudel e le tartellette soddisfano ogni palato.
Camera di commercio ed eccellenze torinesi: un ultimo ma non meno importante aspetto
Il Presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina, ha sottolineato l’importanza e la responsabilità di essere nominati Maestri del Gusto, chiedendo ai 218 premiati di essere ambasciatori del gusto torinese e di partecipare attivamente agli eventi nazionali e internazionali. L’iniziativa della Camera di commercio mira a promuovere l’eccellenza dell’enogastronomia torinese, rendendola un punto di forza per aumentare l’attrattività del territorio sia per i residenti che per i visitatori stranieri.
Questi sono solo alcuni tra i caffe storici Torino e bar colazione dove fermarsi in caso di una visita in città, una semplice passeggiata o per occasioni più importanti come meeting aziendali a Torino, compleanni, incontri e quant’altro.
Tuttavia, siamo certi che resterete soddisfatti da una di queste proposte.
Tra le pasticcerie moderne di Torino, Dolce Pasticceria si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo una selezione di dolci torinesi e creazioni contemporanee che conquistano al primo assaggio.
Un vero paradiso per gli amanti della qualità, con una produzione artigianale che esalta i migliori prodotti pasticceria a Torino. Ogni giorno, dalle vetrine, spiccano eleganti monoporzioni, crostate, torte classiche e innovative, accanto ai grandi protagonisti della tradizione. L’attenzione per la qualità delle materie prime e la cura nella preparazione rendono ogni creazione un’esperienza unica, perfetta per una colazione golosa, una pausa dolce o per festeggiare un’occasione speciale.
Questi sono solo alcuni tra i caffe storici Torino e bar colazione dove fermarsi in caso di una visita in città, una semplice passeggiata o per occasioni più importanti come meeting aziendali a Torino, compleanni, incontri e quant’altro.
Tuttavia, siamo certi che resterete soddisfatti da una di queste proposte.






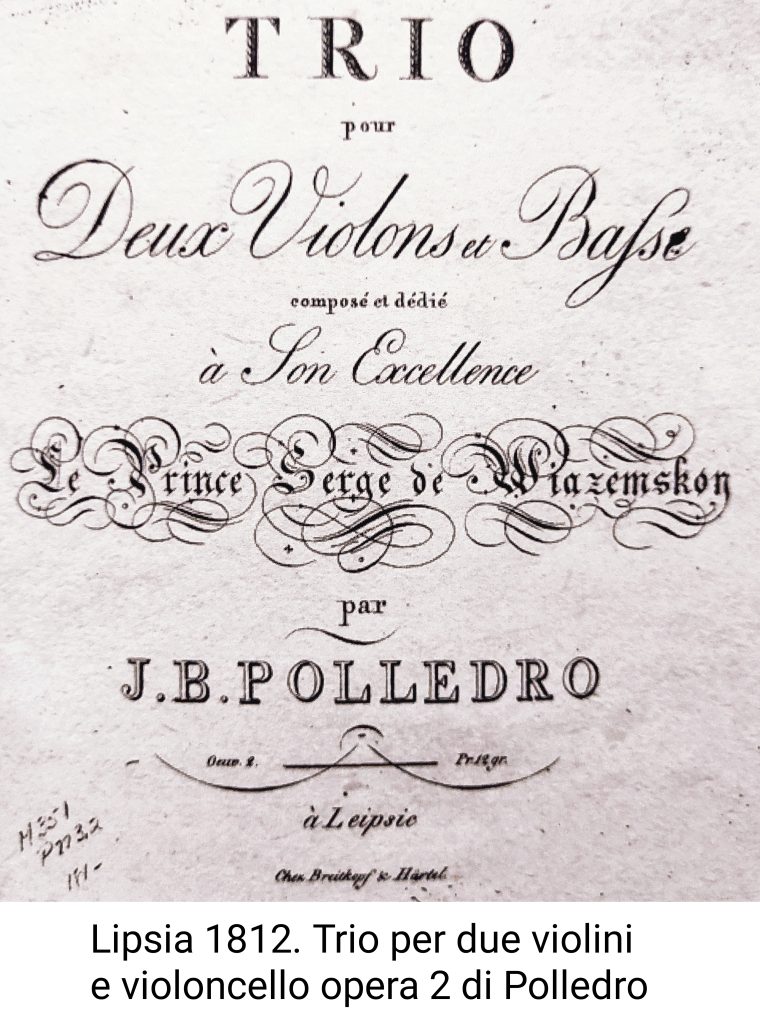
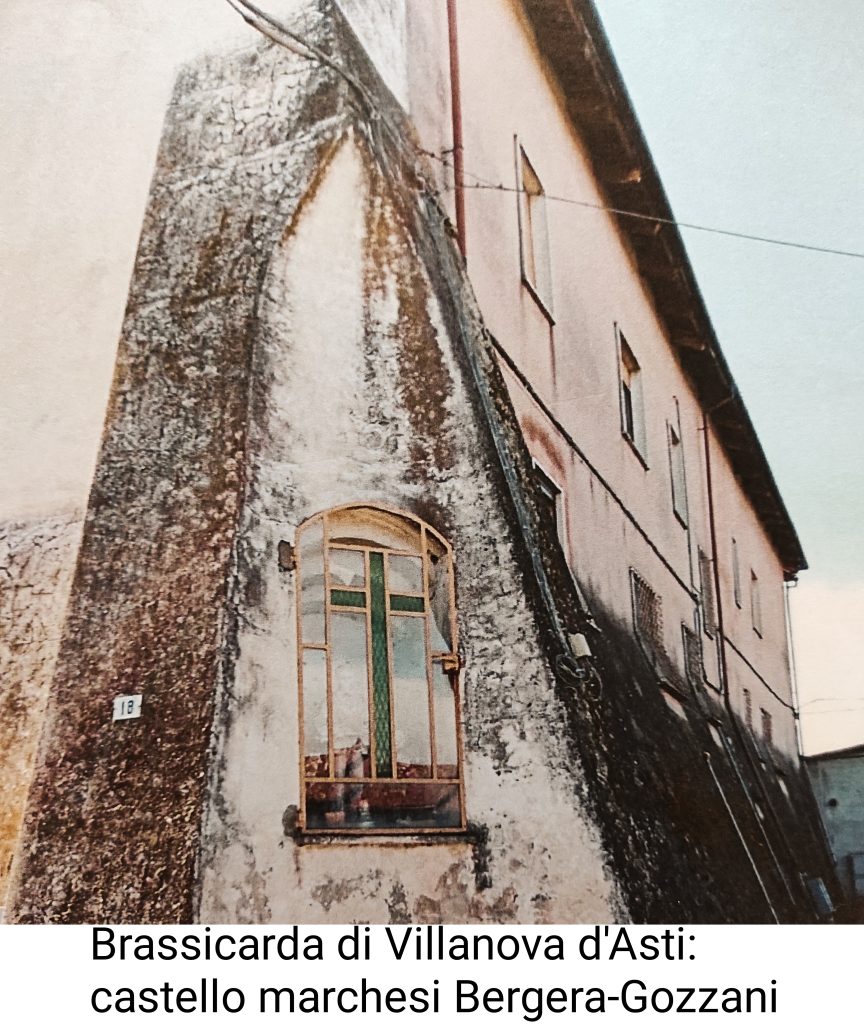
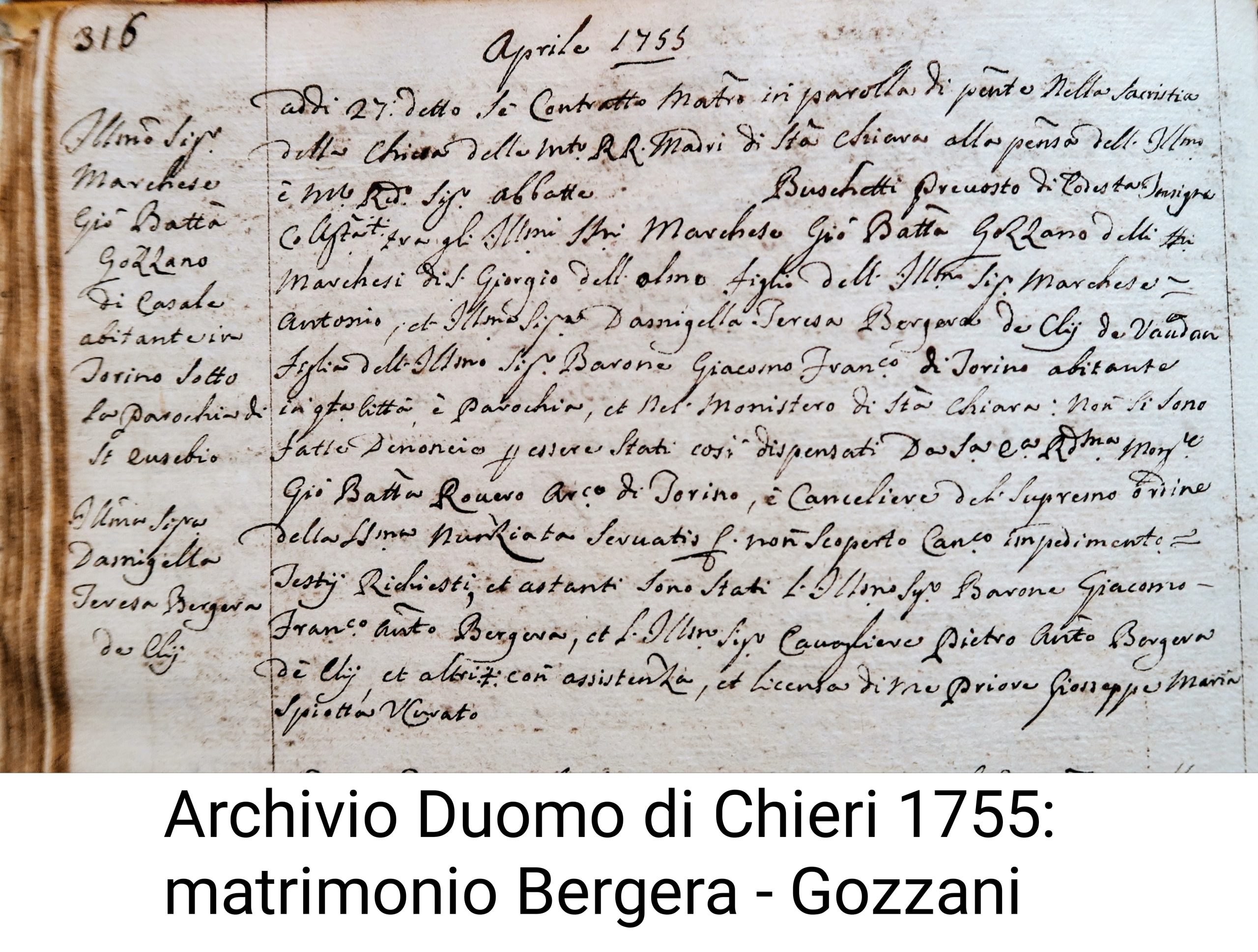
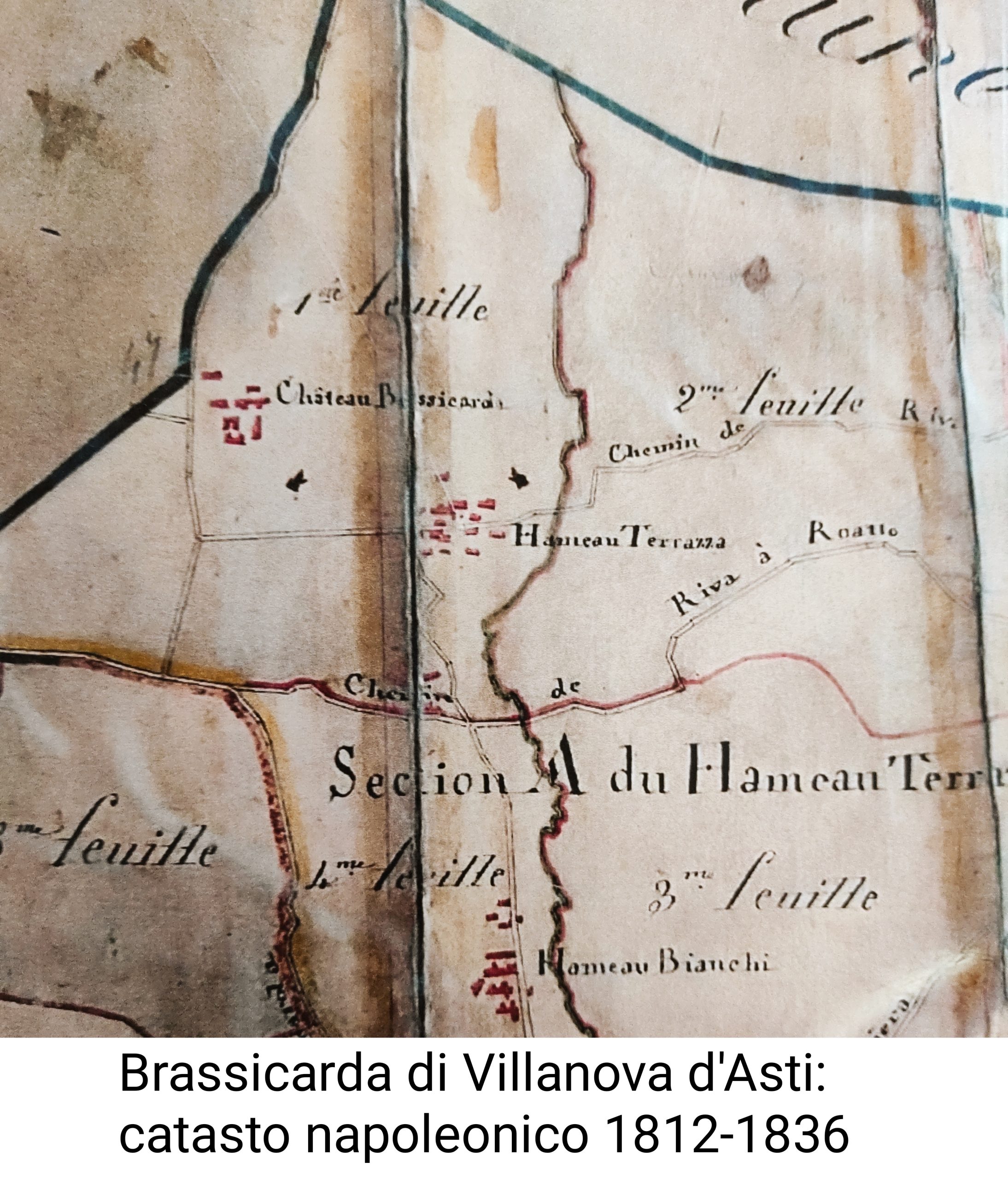


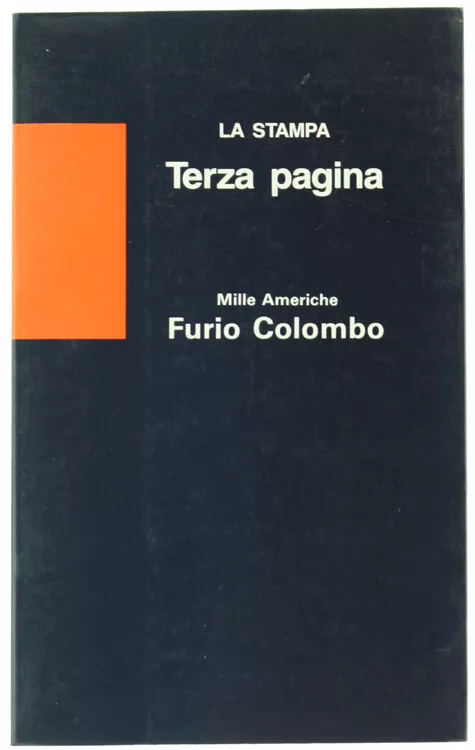

 In questo giorno del ricordo voglio raccontare per la prima volta un episodio. Amico per molti anni di Valerio Zanone, di cui ho sempre apprezzato la cultura, ho avuto con lui un qualche dissenso. In particolare una volta gli chiesi come mai i laici, i liberali, i democratici per decine di anni avessero ignorato il tema delle foibe e dell’esodo. Anche i democristiani si comportarono in modo analogo. Zanone non ebbe esitazione nel rispondermi che le foibe erano un tema missino e che non si doveva portare acqua alla destra fascista senza aggiungere altro. Rimasi senza parole. In tempi successivi posi la stessa domanda a Giovanni Spadolini che in modo più articolato e raffinato culturalmente disse le stesse cose di Zanone. Solo l’onesta’intellettuale dell’ antifascista nativo di Fiume Leo Valiani che in giovinezza era stato comunista portò’ il vecchio senatore a dirmi che bisognava superare l’errore di aver ignorato le foibe , “una tragedia della storia italiana”. Mi disse anche che Mario Pannunzio non aveva ignorato quella tragedia e che era un dovere dei giovani riscattare l’errore grave che “la mia generazione” aveva commesso. C’erano ancora in circolazione politici che erano stati fascisti e che avevano tentato di cancellare il passato da nascondere anche ignorando la storia. Ricordo che una volta Davide Lajolo, già gerarca fascista e combattente in Spagna dalla parte di Franco, diventato poi partigiano e deputato comunista, si alzò da tavola dove stavamo cenando perché ritenne una provocazione intollerabile il fatto che io avessi avviato un timido discorso sulle foibe alla presenza della poetessa esule da Zara Liana De Luca. Intervenne un altro commensale e l’ira di Lajolo si mitigò, anche se ribadì : “questi discorsi lasciamoli ai fascisti”. E non aggiunse altro, riprendendo il pranzo. Questo era il clima degli anni 70. I comunisti negavano perfino la possibilità di parlare delle foibe, ma anche i non comunisti non erano tanto meglio. Il trattato di Osimo che Valiani definì “indegno” e che fu una capitolazione definitiva e impacciata nei confronti di Tito fu opera di un governo di centro – sinistra del 1975 . Dietro c’era la regia del PCI, ma il
In questo giorno del ricordo voglio raccontare per la prima volta un episodio. Amico per molti anni di Valerio Zanone, di cui ho sempre apprezzato la cultura, ho avuto con lui un qualche dissenso. In particolare una volta gli chiesi come mai i laici, i liberali, i democratici per decine di anni avessero ignorato il tema delle foibe e dell’esodo. Anche i democristiani si comportarono in modo analogo. Zanone non ebbe esitazione nel rispondermi che le foibe erano un tema missino e che non si doveva portare acqua alla destra fascista senza aggiungere altro. Rimasi senza parole. In tempi successivi posi la stessa domanda a Giovanni Spadolini che in modo più articolato e raffinato culturalmente disse le stesse cose di Zanone. Solo l’onesta’intellettuale dell’ antifascista nativo di Fiume Leo Valiani che in giovinezza era stato comunista portò’ il vecchio senatore a dirmi che bisognava superare l’errore di aver ignorato le foibe , “una tragedia della storia italiana”. Mi disse anche che Mario Pannunzio non aveva ignorato quella tragedia e che era un dovere dei giovani riscattare l’errore grave che “la mia generazione” aveva commesso. C’erano ancora in circolazione politici che erano stati fascisti e che avevano tentato di cancellare il passato da nascondere anche ignorando la storia. Ricordo che una volta Davide Lajolo, già gerarca fascista e combattente in Spagna dalla parte di Franco, diventato poi partigiano e deputato comunista, si alzò da tavola dove stavamo cenando perché ritenne una provocazione intollerabile il fatto che io avessi avviato un timido discorso sulle foibe alla presenza della poetessa esule da Zara Liana De Luca. Intervenne un altro commensale e l’ira di Lajolo si mitigò, anche se ribadì : “questi discorsi lasciamoli ai fascisti”. E non aggiunse altro, riprendendo il pranzo. Questo era il clima degli anni 70. I comunisti negavano perfino la possibilità di parlare delle foibe, ma anche i non comunisti non erano tanto meglio. Il trattato di Osimo che Valiani definì “indegno” e che fu una capitolazione definitiva e impacciata nei confronti di Tito fu opera di un governo di centro – sinistra del 1975 . Dietro c’era la regia del PCI, ma il



