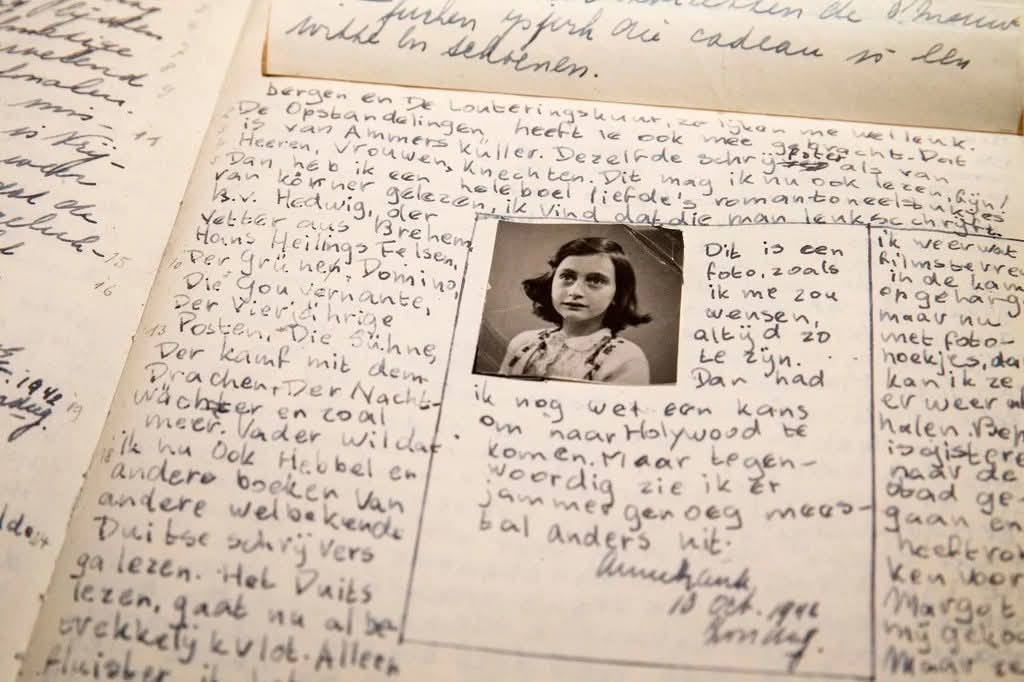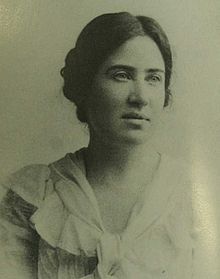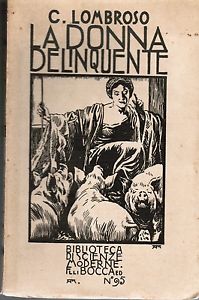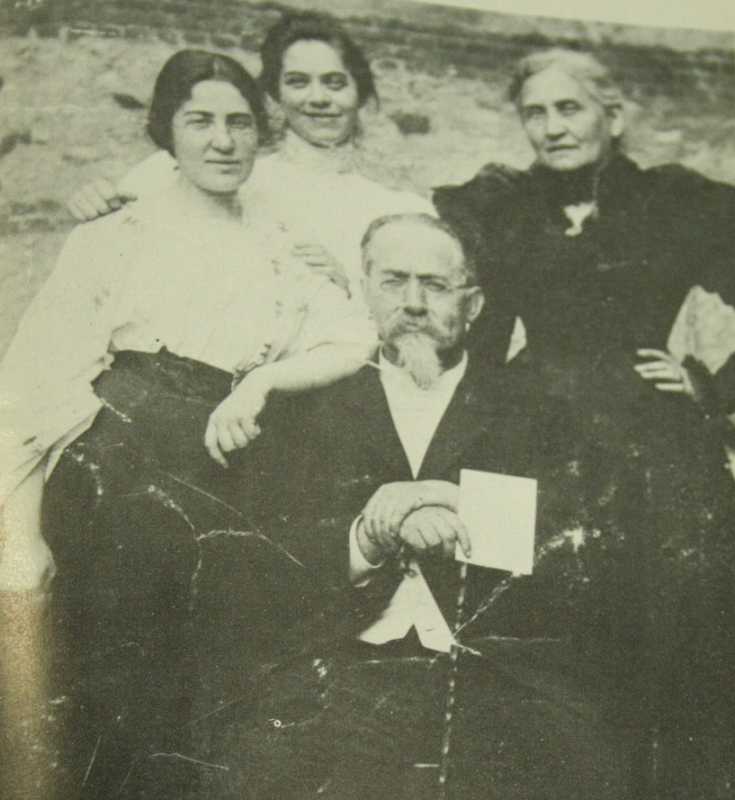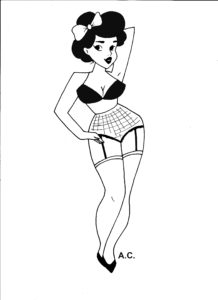È stato presentato oggi, presso il Salone d’Onore della Fondazione CRT, il volume “I marmi del Re”, dedicato allo straordinario intervento di restauro e consolidamento della facciata juvarriana di Palazzo Madama, simbolo identitario della città e patrimonio UNESCO, promosso dalla Fondazione Torino Musei e interamente sostenuto dalla Fondazione CRT, principale sostenitore privato del bene con 18 milioni di euro complessivamente stanziati.
La pubblicazione – curata dall’architetto Gianfranco Gritella, direttore dei lavori, ed edita da Electa – restituisce, attraverso parole e immagini, l’intero percorso tecnico, artistico e umano di questo complesso e innovativo intervento.

L’opera si concentra sull’intervento di consolidamento e restauro della sezione centrale della facciata realizzata tra il 1718 e il 1721 su progetto di Filippo Juvarra. attraverso un’indagine filologica e storica il volume esplora le vicende e le caratteristiche de i restauri attuati tra Ottocento e Novecento condotti da Alfredo d’Andrade.
Alcuni capitoli indagano l’impiego dei marmi provenienti dalle antiche cave delle Alpi Cozie, riscoperte ed esplorate puntualmente e rilevate con droni e specifiche tecnologie laser di ultima generazione, studiando i luoghi di estrazione, i metodi di lavorazione, trasporto e montaggio dei blocchi
L’indagine archeologica sull’architettura ha permesso, in maniera inedita, di ricostruire le tecnologie e le macchine utilizzate nel cantiere storico con disegni e rilievi che descrivono tutti gli elementi scultorei e lapidei che compongono la facciata.
Il restauro – avviato nel 2022 e concluso nel settembre 2024 – è stato interamente finanziato dalla Fondazione CRT, con un contributo straordinario di 2,9 milioni di euro, e promosso dalla Fondazione Torino Musei con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino.
L’intervento ha riguardato il consolidamento strutturale dell’avancorpo centrale con “protesi” reversibili in acciaio, il restauro dei marmi e dei serramenti (11 finestroni barocchi, i più grandi del Piemonte), il recupero dei sotterranei e, in particolare, il delicato restauro delle quattro monumentali statue allegoriche del “Buon Governo” – Giustizia, Liberalità, Magnanimità e Abbondanza – dello scultore carrarese Giovanni Baratta, protagoniste di uno scenografico volo nel cielo di Torino durante la fase di smontaggio.
Si è trattato di una spettacolare, complessa e delicata operazione “chirurgica”, capace di “mixare” antiche tecniche artigianali e metodologie all’avanguardia, recuperando i marmi originali, accanto all’impiego di materiali contemporanei.
Tutto il restauro è stato preceduto da una complessa campagna diagnostica e di rilievi approfondita durante il cantiere con l’impiego di apparecchiature laser, georadar e indagini tomografiche mediante risonanza magnetica al fine di conoscere la consistenza interna dei blocchi lapidei di colonne e pilastri.
Un tratto distintivo del progetto è stato l’approccio partecipativo e inclusivo del cantiere: grazie all’ascensore allestito sul ponteggio e accessibile anche alle persone con disabilità, centinaia di visitatori hanno potuto vivere da vicino il cantiere, ammirando da un punto di vista inedito le architetture torinesi, dalla Mole Antonelliana a Superga. Un’esperienza unica di valorizzazione del patrimonio culturale che ha coinvolto la comunità.
Foto Perottino




 L’associazione nazionale ex internati ( Anei ) compie 80 anni e tiene a Torino in questi giorni il suo congresso nazionale anche in ricordo del suo primo presidente , l’avvocato Gaetano Zini Lamberti, ufficiale del “Nizza Cavalleria” e dopo la guerra noto esponente liberale. Gli Internati, tra i prigionieri italiani nel corso della II guerra mondiale , furono quelli che, deportati dopo l’8 settembre 1943, si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e poi con i fascisti della Rsi. Il loro numero fu di 600-700 mila. L’associazione venne fondata a Torino il 29 aprile 1945. È giusto che il suo ottantesimo congresso si tenga a Torino dove è nata.
L’associazione nazionale ex internati ( Anei ) compie 80 anni e tiene a Torino in questi giorni il suo congresso nazionale anche in ricordo del suo primo presidente , l’avvocato Gaetano Zini Lamberti, ufficiale del “Nizza Cavalleria” e dopo la guerra noto esponente liberale. Gli Internati, tra i prigionieri italiani nel corso della II guerra mondiale , furono quelli che, deportati dopo l’8 settembre 1943, si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e poi con i fascisti della Rsi. Il loro numero fu di 600-700 mila. L’associazione venne fondata a Torino il 29 aprile 1945. È giusto che il suo ottantesimo congresso si tenga a Torino dove è nata.



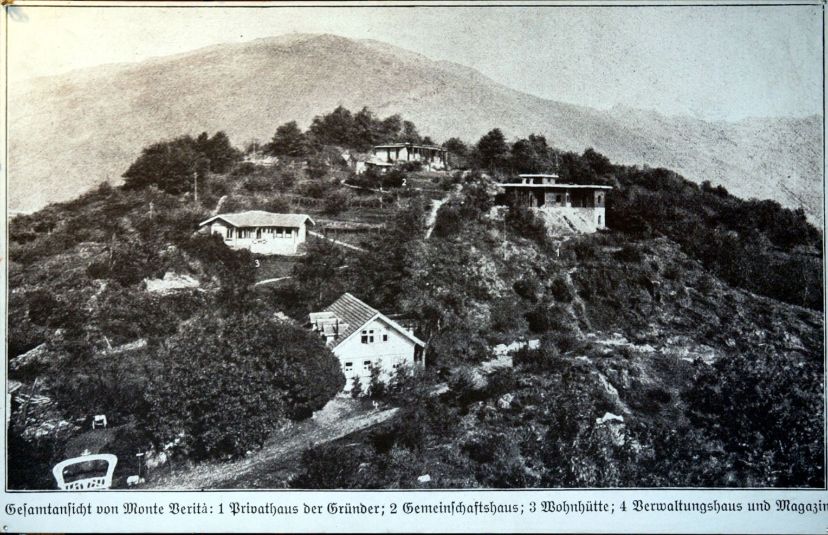

 Nel basamento vi sono quattro bassorilievi in bronzo che rappresentano due avvenimenti storici ( “Il Congresso di Parigi” e “Il ritorno delle truppe sarde dalla Crimea”) e gli stemmi della famiglia Cavour incorniciati da una corona d’alloro e da una ghirlanda di frutti.
Nel basamento vi sono quattro bassorilievi in bronzo che rappresentano due avvenimenti storici ( “Il Congresso di Parigi” e “Il ritorno delle truppe sarde dalla Crimea”) e gli stemmi della famiglia Cavour incorniciati da una corona d’alloro e da una ghirlanda di frutti.