Alla scoperta delle sale più belle della prima reggia d’Italia
A seguito del DPCM 18 ottobre 2020, i Musei Reali osservano una nuova modalità di apertura.
Il Palazzo Reale, l’Armeria e la Cappella della Sindone restano aperti dal martedì alla domenica in orario 9-19.
La Galleria Sabauda è visitabile martedì, mercoledì, sabato e domenica in orario 9-19.
Il Museo di Antichità è visitabile da giovedì a domenica compresi in orario 9-19.
Per tutto il mese di ottobre prosegue comunque la variegata proposta di attività ed eventi dei Musei Reali, alla scoperta dell’affascinante itinerario di storia, arte e natura del complesso museale.
DALL’ANTICO AL CONTEMPORANEO. CONVERSAZIONI SULL’ARTE PER RIFLETTERE SU UN FUTURO SOSTENIBILE
Venerdì 23 ottobre – dalle 17.00 alle 18.30. Cinque storici dell’arte e archeologi responsabili delle collezioni museali invitano il pubblico a condividere una riflessione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile individuati dall’ONU con l’Agenda 2030.
Le opere d’arte e i reperti archeologici scelti nel ricchissimo patrimonio dei Musei Reali saranno il punto di partenza per approfondire alcuni dei 17 Global Goals:
Goal 5 Parità di genere – Annamaria Bava, Donna e artista: Sofonisba Anguissola
Goal 3 Salute e benessere – Giorgia Corso, La Madonna che allatta: valori antichi e attuali di un gesto universale
Goal 2 Sconfiggere la fame – Franco Gualano, La tavola del re e il pane per i poveri
Goal 6 Acqua pulita e igiene per tutti – Gabriella Pantò, L’acqua nella civiltà romana: testimonianze dal Museo di Antichità
Goal 6 Acqua pulita e igiene per tutti – Sofia Villano, La dea Latona e il poeta Ovidio: l’acqua come bene comune
L’incontro avverrà in videoconferenza, fino a esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link: https://museireali.my.webex.com/museireali.my-it/j.php?MTID=m80b6b906210ea90f8873a12adb985747
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE
YOGA NEI GIARDINI REALI. UN RISVEGLIO DEI SENSI
Sabato 24 ottobre – ore 10. Nell’ariosa cornice dei Giardini Reali, è possibile praticare yoga con una lezione all’aria aperta della durata di un’ora. Un’occasione unica per riscoprire sé stessi, riconnettendosi con la terra e l’ambiente circostante. In caso di maltempo la lezione si sposterà nella Sala da Ballo del secondo piano di Palazzo Reale. Ultimo appuntamento del mese di ottobre.
Costo: € 15
Per prenotazioni e informazioni, 011 19560449 oppure info.torino@coopculture.it
BENVENUTO A PALAZZO! SCOPRI I MUSEI REALI
Sabato 24 e domenica 25 ottobre – ore 12 e ore 15. Itinerario Benvenuto a Palazzo! alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria, la Cappella della Sindone e il restauro “a vista” dell’altare.
Percorso della durata di un’ora per gruppi di massimo otto persone.
Costo: € 7, oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18).
Per la visita individuale, è possibile scaricare “MRT”, l’app ufficiale dei Musei Reali, con l’audioguida completa di oltre 35 ascolti. Per saperne di più si può acquistare al Museum Shop la guida a stampa I Musei Reali di Torino pubblicata da Allemandi Editore e realizzata in collaborazione con CoopCulture.
TRA IL SALOTTO E LA CUCINA
Sabato 24 e domenica 25 ottobre – ore 10-11-12 e 15-16-17. Visite guidate alle Cucine Reali e all’Appartamento della Regina Elena, al piano terreno di Palazzo Reale, condotte dai volontari dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale”. I percorsi durano un’ora, con biglietto acquistabile alla cassa dei Musei Reali il giorno stesso.
Costo: € 7, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18.
ARTOO E LE MERAVIGLIE DEI MUSEI REALI
Domenica 25 ottobre alle 10.30 e alle 15.30. È arrivato un orso ai Musei Reali! Si chiama Artoo (https://artoobear.com/), ama l’arte e gli piace ascoltare i racconti dei bambini. Artoo ha bisogno del loro aiuto per comprendere le meravigliose opere dei Musei Reali. Il 25 ottobre li aspetta per un percorso esperienziale unico: un’occasione ideata appositamente per le famiglie per conoscere l’arte attraverso la voce dei più piccoli.
Attività per bambini da 4 a 8 anni, accompagnati da un adulto
Costo: attività gratuita, ingresso gratuito per i bambini, ingresso speciale a 10 € per gli adulti, gratuito per possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card
Prenotazione obbligatoria: artoo@artoobear.com
MOSTRE IN CORSO
CAPA IN COLOR
Nelle Sale Chiablese, fino al 31 gennaio 2021, si potrà visitare Capa in color, la mostra monografica dedicata al fotografo di fama mondiale Robert Capa, nata da un progetto di Cynthia Young, curatrice della collezione al Centro Internazionale di Fotografia di New York. La mostra, che presenta oltre 150 immagini a colori, lettere personali e appunti dalle riviste su cui furono pubblicate, intende illustrare il particolare approccio dell’autore verso i nuovi mezzi fotografici e la sua straordinaria capacità di integrare il colore nei lavori da fotoreporter, realizzati tra gli Anni ‘40 e ‘50 del Novecento.
L’esposizione è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). I biglietti possono essere acquistati in cassa oppure online sul sito www.capaincolor.it. Prenotazioni e informazioni al numero 338 1691652 o via e-mail info@capaincolor.it.
È possibile prenotare percorsi e laboratori destinati alle scuole e ideati da CoopCulture: le attività, con un occhio attento alle connessioni tra la straordinaria mostra e le collezioni dei Musei Reali, si svolgono dal martedì al sabato nella fascia oraria 9.30-10 per un accesso a mostra chiusa e in tutta sicurezza per le classi. Prenotazioni e informazioni al numero 338 1691652 o via e-mail info@capaincolor.it
BEYOND WALLS – OLTRE I MURI
Dopo il Champ de Mars di Parigi, le tappe di Andorra, Ginevra, Berlino, Ouagadougou e Yamoussoukro, l’artista franco-svizzero Saype ha scelto Torino come settimo sito della sua monumentale opera di Land Art ecologica dedicata alla fratellanza universale e alle connessioni tra uomini e culture. Una gigantesca catena di mani intrecciate è comparsa sui prati del giardino della Porta Palatina, dipinta con pigmenti eco-compatibili appositamente brevettati. Un messaggio di solidarietà e di fratellanza per un’opera che unisce idealmente Torino al resto del mondo. In parallelo, i Musei Reali sostengono il progetto nella volontà di connettere il patrimonio delle arti classiche alle espressioni artistiche contemporanee, contribuendo a realizzare uno dei più importanti interventi artistici su scala globale degli ultimi anni. Il progetto comprende anche Beyond Walls. Torino 2020, la prima mostra personale dell’artista allestita al primo piano della Galleria Sabauda, per ricostruire poetica, carriera e tecnica dei Foot Murales che hanno reso celebre Saype in tutto il mondo. L’esposizione è visitabile fino al 17 gennaio 2021 con il biglietto ordinario del museo.
INCĒNSUM
L’esposizione, organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Per Fumum, illustra con opere che si datano a partire dal III millennio a.C., il percorso delle Vie dell’Incenso. Le fonti antiche riportano l’itinerario compiuto dalle lacrime del deserto, il frankincenso o olibano, prodotto principalmente in Oman e Yemen, che dall’antica Arabia Felix risaliva verso le terre dei Nabatei, giungendo fino al Mediterraneo, attraversando Israele o spingendosi fino ad Alessandria d’Egitto. Questo è da sempre legato alla creazione di pregiate essenze profumate che verranno ricreate lungo il percorso. La mostra conta sui prestiti del National Museum di Mascate (Sultanato dell’Oman), del Museo Egizio e del Museo d’Arte Orientale di Torino, del Museo delle Civiltà di Roma, del Museo Etnoarcheologico Castiglioni di Varese.
Aperta fino al 10 gennaio 2021 e visitabile ogni venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 14 alle 17 con ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali.
TOWARD2030. WHAT ARE YOU DOING?
Fino al 17 gennaio il pubblico potrà visitare l’esposizione dedicata al progetto TOward2030. What are you doing? Ideato da Lavazza e dalla Città di Torino per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto ha previsto la realizzazione di 18 opere murali ispirate ai Sustainable Development Goals elaborati dall’ONU, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile più il Goal Zero, pensato da Lavazza per divulgare gli obiettivi stessi. La mostra, curata da Roberto Mastroianni e Filippo Masino, presenta nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda fotografie e filmati degli artisti al lavoro, mentre nel Boschetto dei Giardini Reali sono riproposti gli scatti delle 18 opere d’arte urbana presenti a Torino, oltre ai lavori di alcuni artisti dei collettivi Il Cerchio e le Gocce, Monkeys Evolution e Truly Design, realizzati durante il live painting inaugurale con il coordinamento di MurArte Torino.
***
MUSEI REALI TORINO
Orari
Dal martedì alla domenica: 9 – 19 Orario biglietteria: 9 – 18 Ultimo ingresso ore 18
Il Palazzo Reale, l’Armeria e la Cappella della Sacra Sindone restano aperti dal martedì alla domenica in orario 9-19.
La Galleria Sabauda è visitabile martedì, mercoledì, sabato e domenica in orario 9-19.
Il Museo di Antichità è visitabile da giovedì a domenica compresi in orario 9-19.
La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì in orario 9-13 e 14-18; sabato 9-13; domenica chiuso (solo consultazione con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it).
Biglietti
Intero: € 10
Ridotto: € 2 (ragazzi dai 18 ai 25 anni)
Gratuito per i minori 18 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card. L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.
Sabato, domenica e festivi
Intero: € 15
Ridotto: € 13 per partecipanti a visite guidate e per soci FAI
Ridotto: € 2 (ragazzi dai 18 ai 25 anni)
Gratuito per i minori 18 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card. L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.
Visite ed appuntamenti speciali
Gli appuntamenti sono inseriti nel fine settimana e secondo un calendario consultabile sul sito museireali.beniculturali.it e sulla pagina dedicata www.coopculture.it/heritage.cfm?id=284
Nel rispetto delle norme vigenti, negli spazi interni i gruppi saranno formati da un numero massimo di 8 partecipanti.
La biglietteria presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1, è aperta dalle 9 alle 18.
Informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì (9-13) al numero 011 19560449
Prenotazione Scuole: 848 082408, edu@coopculture.it
Prenotazione Gruppi: 06 39967450, tour@coopculture.it
Informazioni e prenotazioni guide autorizzate: info.torino@coopculture.it
Informazioni: info.torino@coopculture.it
Acquisto on-line: www.coopculture.it/heritage.cfm?id=284
Web: Coopculture.it



 Conficcato in una nicchia di un grande masso compare il volto di un personaggio dell’antichità. Si parla di Maometto, il profeta dell’Islam, o di un Giove romano o forse di qualcun altro. In bassa Val di Susa, a una quarantina di chilometri da Torino, i colori dell’autunno e le prime nebbie d’ottobre rendono quel luogo ancora più incantato e anche un po’ fiabesco. Ma intorno a quella figura maschile persiste la disputa, ormai vecchia di decenni, tra borgonesi e storici. I valsusini non hanno dubbi: quel volto scolpito nella roccia è quello di Maometto ma gli studiosi la pensano molto diversamente. Maometto non c’entra nulla, sostengono i ricercatori, si tratta piuttosto di una divinità romana. Eppure quel gigantesco masso caduto in valle a ridosso di una stradina accanto al bosco è rotolato per centinaia di metri dall’alto di una montagna dove i saraceni musulmani passavano, stazionavano e poi scendevano in valle per uccidere e distruggere paesi e borgate. Chissà che non siano stati proprio loro a incidere su quella roccia il volto del fondatore della religione islamica? Vale comunque la pena passare da queste parti quando si va in alta valle a sciare o a visitare Susa e la Novalesa o a mangiare la polenta in qualche rifugio. Si lascia l’auto dove è possibile e dopo una brevissima camminata eccolo lì, è talmente piccolo nell’enorme masso che quasi non si vede ma poi, avvicinandosi, emerge una piccola nicchia a forma di tempietto a quattro-cinque metri dal suolo. I borgonesi lo chiamano “il Maometto di Borgone”. Indossa una tunica e un mantello, ha le braccia sollevate verso l’alto e ai piedi si scorge un animale mentre sul frontone compare un’iscrizione, quasi
Conficcato in una nicchia di un grande masso compare il volto di un personaggio dell’antichità. Si parla di Maometto, il profeta dell’Islam, o di un Giove romano o forse di qualcun altro. In bassa Val di Susa, a una quarantina di chilometri da Torino, i colori dell’autunno e le prime nebbie d’ottobre rendono quel luogo ancora più incantato e anche un po’ fiabesco. Ma intorno a quella figura maschile persiste la disputa, ormai vecchia di decenni, tra borgonesi e storici. I valsusini non hanno dubbi: quel volto scolpito nella roccia è quello di Maometto ma gli studiosi la pensano molto diversamente. Maometto non c’entra nulla, sostengono i ricercatori, si tratta piuttosto di una divinità romana. Eppure quel gigantesco masso caduto in valle a ridosso di una stradina accanto al bosco è rotolato per centinaia di metri dall’alto di una montagna dove i saraceni musulmani passavano, stazionavano e poi scendevano in valle per uccidere e distruggere paesi e borgate. Chissà che non siano stati proprio loro a incidere su quella roccia il volto del fondatore della religione islamica? Vale comunque la pena passare da queste parti quando si va in alta valle a sciare o a visitare Susa e la Novalesa o a mangiare la polenta in qualche rifugio. Si lascia l’auto dove è possibile e dopo una brevissima camminata eccolo lì, è talmente piccolo nell’enorme masso che quasi non si vede ma poi, avvicinandosi, emerge una piccola nicchia a forma di tempietto a quattro-cinque metri dal suolo. I borgonesi lo chiamano “il Maometto di Borgone”. Indossa una tunica e un mantello, ha le braccia sollevate verso l’alto e ai piedi si scorge un animale mentre sul frontone compare un’iscrizione, quasi  cancellata dal tempo, con lettere latine. Per la tradizione popolare della zona quella figura rapresenta Maometto e molte leggende antiche si fanno risalire alle invasioni dei Mori che oltre mille anni fa devastarono la Valle di Susa lasciando terribili ricordi nella gente, poi tramandati per generazioni. Ma allora chi è rappresentato in quel bassorilievo? Le ipotesi avanzate sono diverse ma il Profeta avrebbe poco a che vedere con quel ritratto. Si tratterebbe invece, secondo gli storici, del volto di Giove Dolicheno, una divinità anatolica venerata dai soldati romani nel II-III secolo. Gli arabi arrivarono in Val di Susa alcuni secoli dopo la morte di Maometto. Valicate le Alpi marittime i predoni musulmani giunsero in Liguria e in Piemonte e nell’anno 906 furono avvistati per la prima volta nelle grotte dell’alta Val di Susa che furono usate come basi per assaltare e depredare i borghi valsusini, saccheggiando e uccidendo gli abitanti del luogo. La stessa celebre Abbazia di Novalesa, all’epoca uno dei più importanti centri culturali e religiosi del Piemonte, fu incendiata nel 912 dai saraceni e i monaci furono costretti a fuggire a Torino mettendo in salvo codici e manoscritti della biblioteca. Ma il mistero in bassa valle resta e la domanda se la pongono in molti: quel volto misterioso è di Maometto o di un Giove? Gli studiosi, come detto, non hanno più dubbi, si tratta di una divinità romana, ma per i borgonesi l’uomo misterioso resta Maometto. Lasciamo quindi a Borgone il suo “Maometto” in bella mostra su quella rupe che attira turisti e gitanti diretti in alta valle. Una capatina da Maometto è sempre gradita ai borgonesi.
cancellata dal tempo, con lettere latine. Per la tradizione popolare della zona quella figura rapresenta Maometto e molte leggende antiche si fanno risalire alle invasioni dei Mori che oltre mille anni fa devastarono la Valle di Susa lasciando terribili ricordi nella gente, poi tramandati per generazioni. Ma allora chi è rappresentato in quel bassorilievo? Le ipotesi avanzate sono diverse ma il Profeta avrebbe poco a che vedere con quel ritratto. Si tratterebbe invece, secondo gli storici, del volto di Giove Dolicheno, una divinità anatolica venerata dai soldati romani nel II-III secolo. Gli arabi arrivarono in Val di Susa alcuni secoli dopo la morte di Maometto. Valicate le Alpi marittime i predoni musulmani giunsero in Liguria e in Piemonte e nell’anno 906 furono avvistati per la prima volta nelle grotte dell’alta Val di Susa che furono usate come basi per assaltare e depredare i borghi valsusini, saccheggiando e uccidendo gli abitanti del luogo. La stessa celebre Abbazia di Novalesa, all’epoca uno dei più importanti centri culturali e religiosi del Piemonte, fu incendiata nel 912 dai saraceni e i monaci furono costretti a fuggire a Torino mettendo in salvo codici e manoscritti della biblioteca. Ma il mistero in bassa valle resta e la domanda se la pongono in molti: quel volto misterioso è di Maometto o di un Giove? Gli studiosi, come detto, non hanno più dubbi, si tratta di una divinità romana, ma per i borgonesi l’uomo misterioso resta Maometto. Lasciamo quindi a Borgone il suo “Maometto” in bella mostra su quella rupe che attira turisti e gitanti diretti in alta valle. Una capatina da Maometto è sempre gradita ai borgonesi.


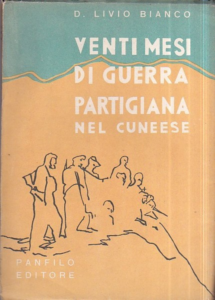 L’incontro tra italiani e francesi fu organizzato per firmare gli accordi che sancivano rapporti di solidarietà, intesa, collaborazione e lotta contro la dominazione nazifascista. Queste intese rivestirono un importante valore storico, rappresentando la comunanza politica tra i due movimenti in lotta, il reciproco desiderio di stabilire relazioni e ricercare collaborazioni di tipo militare. All’appuntamento si giunse grazie alle relazioni politiche avviate da Costanzo Picco, sottotenente della IV armata rimasto in territorio francese dopo lo sbandamento dell’8 settembre 1943, che stabilì i contatti fra la resistenza francese e italiana tramite Detto Dalmastro, comandante del III settore del Comitato di Liberazione Nazionale. Un primo incontro avvenne il 12 maggio 1944 in alta montagna, al bivacco sul Colle Sautron, per iniziativa della Brigata “Giustizia e Libertà della Valle Maira”, al quale presero parte in rappresentanza dei partigiani italiani Detto Dalmastro, Costanzo Picco, Luigi Ventre — comandante della brigata Valle Maira — e Giorgio Bocca, comandante della brigata Valle Varaita. I francesi erano rappresentati da Jacques Lecuyer, del Comité de Libération National, e da diversi comandanti delle formazioni di maquisards. Al Colle del Sautron ci si accordò per un secondo incontro da tenersi a Barcelonnette, nella valle dell’Ubaye, a una trentina di chilometri dal confine italiano. Al rendez vous del
L’incontro tra italiani e francesi fu organizzato per firmare gli accordi che sancivano rapporti di solidarietà, intesa, collaborazione e lotta contro la dominazione nazifascista. Queste intese rivestirono un importante valore storico, rappresentando la comunanza politica tra i due movimenti in lotta, il reciproco desiderio di stabilire relazioni e ricercare collaborazioni di tipo militare. All’appuntamento si giunse grazie alle relazioni politiche avviate da Costanzo Picco, sottotenente della IV armata rimasto in territorio francese dopo lo sbandamento dell’8 settembre 1943, che stabilì i contatti fra la resistenza francese e italiana tramite Detto Dalmastro, comandante del III settore del Comitato di Liberazione Nazionale. Un primo incontro avvenne il 12 maggio 1944 in alta montagna, al bivacco sul Colle Sautron, per iniziativa della Brigata “Giustizia e Libertà della Valle Maira”, al quale presero parte in rappresentanza dei partigiani italiani Detto Dalmastro, Costanzo Picco, Luigi Ventre — comandante della brigata Valle Maira — e Giorgio Bocca, comandante della brigata Valle Varaita. I francesi erano rappresentati da Jacques Lecuyer, del Comité de Libération National, e da diversi comandanti delle formazioni di maquisards. Al Colle del Sautron ci si accordò per un secondo incontro da tenersi a Barcelonnette, nella valle dell’Ubaye, a una trentina di chilometri dal confine italiano. Al rendez vous del 









 E’ vero che in Istria e Dalmazia ci furono
E’ vero che in Istria e Dalmazia ci furono