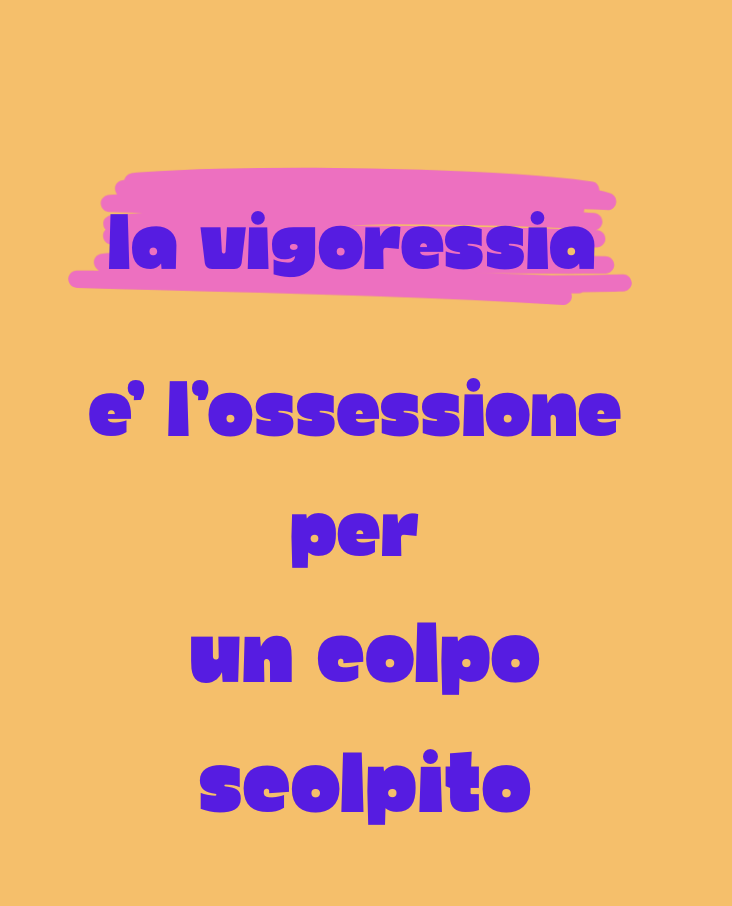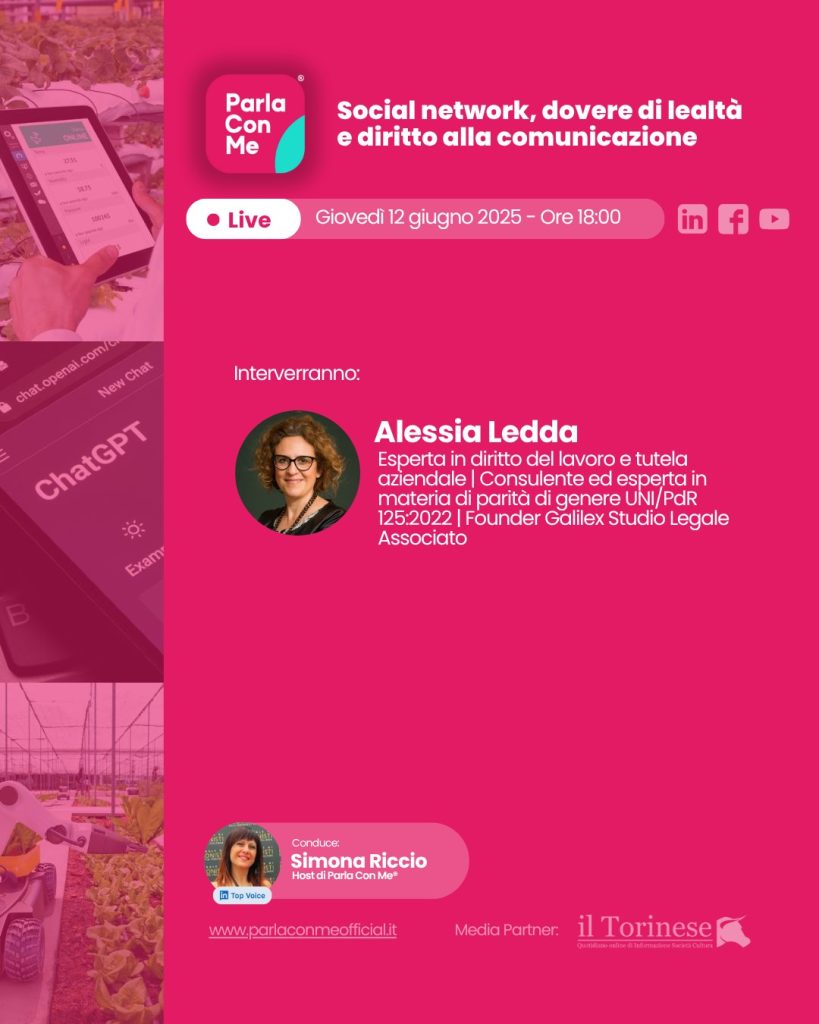I recenti referendum e l’assetto bellico in continua evoluzione hanno messo in risalto, se mai ve ne fosse stata la necessità, come nel nostro Paese le minoranze, a qualsiasi livello, anziché costruire qualcosa di concerto con la maggioranza democraticamente eletta stanno alla finestra a guardare e, a cose fatte, inveiscono contro la maggioranza perché ha fatto così, perché loro avrebbero fatto cosà, e così via.
Ad un’analisi immediata appare evidente che non fare nulla, e criticare chi fa, sia molto più comodo, più riposante a costo di farsi venire le piaghe da decubito stando tutto il giorno al bar o al parco o davanti alla TV anziché girare, incontrare, fare sopralluoghi et similia. Minoranza che vuole gli stessi diritti della maggioranza senza averli conquistati nell’urna.
Ad un’analisi più accurata è palese che chi critica, troppo spesso non abbia assolutamente le capacità amministrative richieste ad un politico, ma trascorra più tempo a consultare i propri consulenti che ad analizzare le necessità e, parafrasando Shakespeare, combattendole porre fine ad esse.
Va da sé che un Paese dove i gay sfilando al Pride sventolano la bandiera di un Paese che i gay li uccide anziché del Paese avversario, unica democrazia in quell’area, non ha futuro; un Paese dove non si gode per i successi ottenuti dalla controparte ma per le proprie argomentazioni contro “a prescindere”, idem; un Paese dove si scende in piazza se viene ceduto un calciatore, ma non manifesta se viene aumentata l’IVA è già in putrefazione.
Siamo sicuramente tra i più ignoranti nel mondo occidentale per quanto riguarda la politica, quelli che hanno il minor senso civico, dove le minoranze quando vedono un dito che indica la Luna guardano criticamente il dito, osservando se abbia le unghie curate o se le dita siano storte.
Proseguono così le fazioni già presenti ai tempi di Dante, tra Guelfi e Ghibellini, dove non conta salvare la città ma garantirsi il predominio.
Molti individui, prestati alla politica, non hanno mai realizzato nulla, professionalmente parlando, e proprio perciò non sanno distinguere tra bene e male, innocuo e nocivo, corretto e sbagliato; ancora grazie se, ricevuta un’eredità, non l’hanno persa in qualche investimento totalmente azzardato; un personaggio dello spettacolo, eletto in Parlamento molti anni fa, non partecipò a nemmeno una seduta dei lavori, ma ora percepisce il vitalizio.
Sono in politica dal 1979, quando aiutai Sergio Pininfarina nella sua candidatura alle Europee; ho incontrato moltissimi politici della vecchia guardia (ma anche della nuova) soprattutto quando trascorrevo settimane a Roma: da Zanone ad Andreotti, Pajetta, Lama (lo incontrai a Torino l’8 marzo 1986 quando lasciò la CGIL per entrare in politica) fino a Bontempo, Fini, Staiti di Cuddia, Goria, Anselmi, Fassino, Damiano ed altri. Di molti non condividevo la linea politica, per alcuni non provai immediata simpatia ma da una cosa erano tutti accomunati: la correttezza, l’umiltà e l’interesse a fare bene il loro lavoro. Escludendo qualche caso specifico e qualche spettacolo circense in aula, i politici di vecchio stampo avevano un obiettivo preciso: giungere a risultati.
Ora molti, troppi politici a vario livello, pensano a denigrare anziché erigere, distruggere anziché migliorare.
Nell’ebraismo esiste un precetto chiamato תיקון עולם (tiqqun olam) che impone, quando sarà ora, ad ogni ebreo di lasciare il mondo un po’ meglio di come lo si è trovato; ecco, chiunque sia investito di una carica politica, a qualsiasi livello, dovrebbe appropriarsi di questo precetto: contribuire, anche in minima parte, anche con azioni apparentemente inutili, a migliorare questo nostro mondo. I nostri avi sono morti in battaglia, per secoli, per farci stare meglio: noi non possiamo impegnarci a farlo per la durata di un mandato onorando il voto assegnatoci dagli elettori? E se i voti non sono stati sufficienti a farci vincere, facciamoci una domanda e diamoci una risposta.
Sergio Motta