Caro direttore, la Globoconsumatori associazione nazionale consumatori, dal sottoscritto fondata nel 2006 e della quale sono tutt’ora Presidente Nazionale, conta 55 filiali in Italia e circa 300.000 associati. Siamo una Onlus senza scopo di lucro, un centro di iniziativa e aggregazione per la promozione dei diritti dei cittadini consumatori ed utenti.
 Globoconsumatori nasce da dirigenti che contano una lunga esperienza nel mondo del consumerismo italiano ed europeo.
Globoconsumatori nasce da dirigenti che contano una lunga esperienza nel mondo del consumerismo italiano ed europeo.
La proposta è quella di rappresentare in maniera sempre più efficace, in base anche all’evolversi delle situazioni, le attività di intervento a difesa dei diritti fondamentali dei cittadini/consumatori.
Quanto sopra poiché i soci promotori, nella piena consapevolezza della necessità di attuare forme e modi innovativi di azioni anche politiche a tutto favore dei cittadini. Particolarmente per le categorie meno abbienti e deboli. Globoconsumatori si prefigge dunque di affrontare le sfide economico-sociali in un contesto generale che, sia a livello europeo e nazionale sia a livello regionale, è diventato sempre più complicato e contraddittorio. Si mantiene apartitica, laica ed aperta alla partecipazione democratica.
Ci occupiamo a 360° della tutela dei diritti dei cittadini/consumatori in base al Codice del Consumo (d.lgs 206/2005), con diverse specializzazioni, tra le quali i ricorsi avverso i verbali di presunte infrazioni al CDS, comparto nel quale godiamo di una certa credibilità (circa 10.000 ricorsi anno a livello nazionale, con un accoglimento del 96%) e, siamo stati i primi in Italia ad aver avuta sentenza di accoglimento dal GDP di Milano che ha dichiarati, in base alle motivazioni da noi espresse in ricorso, NON Omologati gli autovelox in Italia, aprendo così uno storico dibattito giurisprudenziale in merito che, alla data odierna vede allineati il 90 % dei GDP nazionale. Hai ricevuto una contravvenzione e vuoi fare ricorso? Se decidi di affidarti a noi fai la scelta giusta perché abbiamo il 96 % di ricorsi accolti relativi agli autovelox per mancata omologazione.
Mario Gatto
Presidente nazionale Globoconsumatori
www.globoconsumatori.it, www.sanzioniesicurezzastradale.it

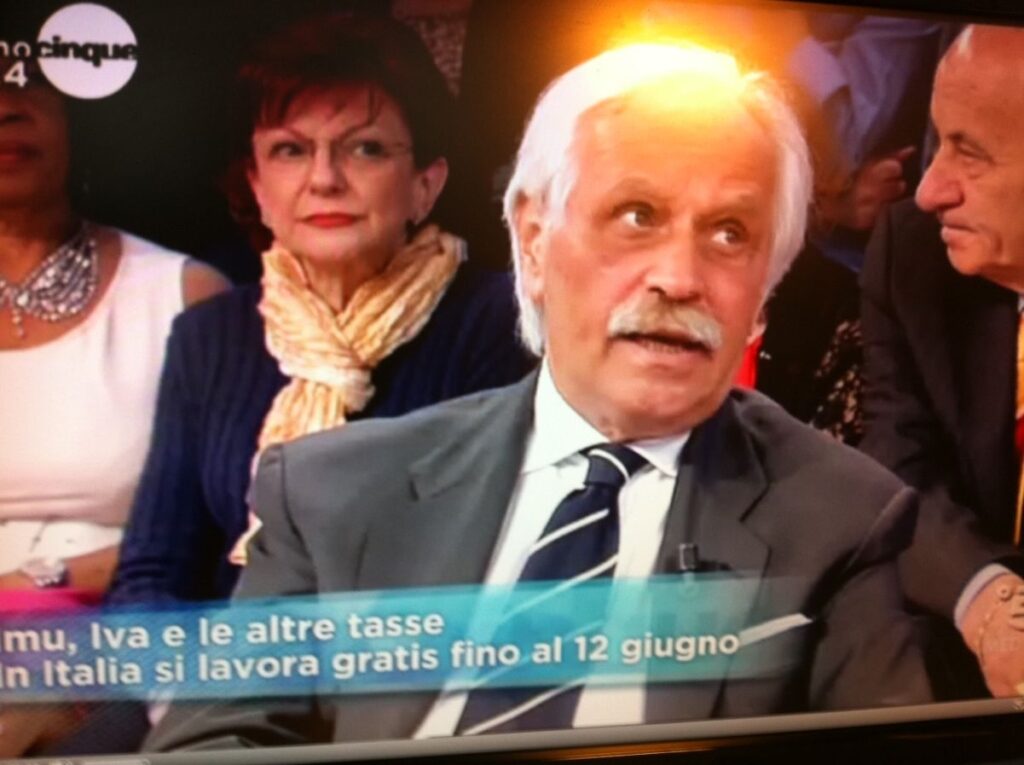
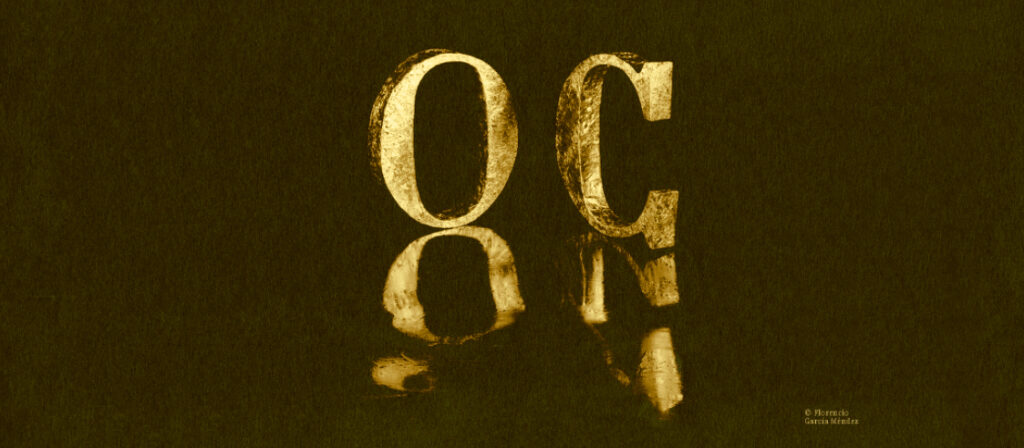


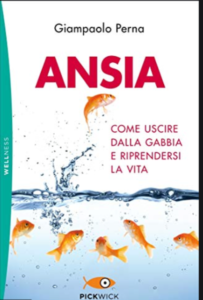 Entrata in una libreria del centro in cerca di qualcosa da leggere il mio occhio, attento a captare qualsiasi cosa facesse rima con
Entrata in una libreria del centro in cerca di qualcosa da leggere il mio occhio, attento a captare qualsiasi cosa facesse rima con 






