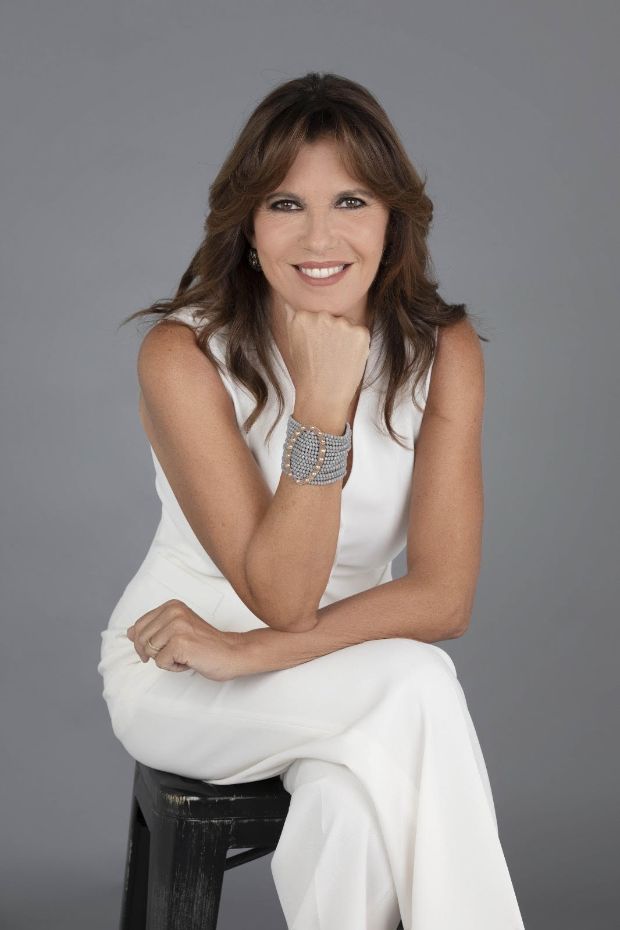Oltre Torino: storie miti e leggende del torinese dimenticato
È l’uomo a costruire il tempo e il tempo quando si specchia, si riflette nell’arte
L’espressione artistica si fa portavoce estetica del sentire e degli ideali dei differenti periodi storici, aiutandoci a comprendere le motivazioni, le cause e gli effetti di determinati accadimenti e, soprattutto, di specifiche reazioni o comportamenti. Già agli albori del tempo l’uomo si mise a creare dei graffiti nelle grotte non solo per indicare come si andava a caccia o si partecipava ad un rituale magico, ma perché sentì forte la necessità di esprimersi e di comunicare. Così in età moderna – se mi è consentito questo salto temporale – anche i grandi artisti rinascimentali si apprestarono a realizzare le loro indimenticabili opere, spinti da quella fiamma interiore che si eternò sulla tela o sul marmo. Non furono da meno gli autori delle Avanguardie del Novecento che, con i propri lavori “disperati”, diedero forma visibile al dissidio interiore che li animava nel periodo tanto travagliato del cosiddetto “Secolo Breve”. Negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale nacque un movimento seducente ingenuo e ottimista, che sognava di “ricreare” la natura traendo da essa motivi di ispirazione per modellare il ferro e i metalli, nella piena convinzione di dar vita a fiori in vetro e lapislazzuli che non sarebbero mai appassiti: gli elementi decorativi, i “ghirigori” del Liberty, si diramarono in tutta Europa proprio come fa l’edera nei boschi. Le linee rotonde e i dettagli giocosi ed elaborati incarnarono quella leggerezza che caratterizzò i primissimi anni del Novecento, e ad oggi sono ancora visibili anche nella nostra Torino, a testimonianza di un’arte raffinatissima, che ha reso la città sabauda capitale del Liberty, e a prova che l’arte e gli ideali sopravvivono a qualsiasi avversità e al tempo impietoso.
Torino Liberty
Il Liberty: la linea che invase l’Europa
Torino, capitale italiana del Liberty
Il cuore del Liberty nel cuore di Torino: Casa Fenoglio
Liberty misterioso: Villa Scott
Inseguendo il Liberty: consigli “di viaggio” per torinesi amanti del Liberty e curiosi turisti
Inseguendo il Liberty: altri consigli per chi va a spasso per la città
Storia di un cocktail: il Vermouth, dal bicchiere alla pubblicità
La Venaria Reale ospita il Liberty: Mucha e Grasset
La linea che veglia su chi è stato: Il Liberty al Cimitero Monumentale
Quando il Liberty va in vacanza: Villa Grock
 Articolo 9. La linea che veglia su chi è stato: il Cimitero Monumentale
Articolo 9. La linea che veglia su chi è stato: il Cimitero Monumentale
Il Liberty al Cimitero Monumentale
Il Cimitero Monumentale, un tempo chiamato Cimitero Generale, si trova a Nord della città, in una zona non lontana dalla Dora Riparia, nell’area del Regio Parco. Nel 1827 la città di Torino ne deliberò l’edificazione decidendo di situarlo lontano dal centro abitato, in sostituzione del piccolo cimitero di San Pietro in Vincoli, nel quartiere Aurora. L’opera si poté attuare grazie alla donazione di 300 mila lire piemontesi del marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo. Aperto nel 1828, su progetto dell’architetto Gaetano Lombardi, con disegno a pianta quadrata dagli angoli smussati, il Monumentale fu presto ingrandito con una parte aggiunta a cura dell’architetto Carlo Sada Bellagio, collaboratore di Pelagio Palagi e vincitore del concorso per la realizzazione della chiesa dedicata al primo vescovo torinese, San Massimo. Seguirono poi necessari ampliamenti, e negli anni tra Ottocento e Novecento l’alta società borghese di Torino affidò a celebri scultori il mandato per la costruzione di imponenti edicole funerarie, a solenne affermazione del prestigio raggiunto dalle singole famiglie. Proprio l’estetica Liberty, sintesi raffinata di natura, tecnica e arte, riuscì ad interpretare il compianto pietoso verso il defunto, delineando il triste tema della morte attraverso pure ed efficaci metafore di una grande arte funeraria.
Tra le opere che possiamo visionare in rigoroso e rispettoso silenzio vi è il Monumento Porcheddu, dedicato al grande ingegnere Giovanni Antonio Porcheddu, che ha introdotto in Italia la tecnica delle costruzioni in cemento armato. Figura essenziale per l’imprenditoria torinese, alla sua impresa si devono imponenti opere, quali l’immenso Stadium del 1911 (demolito nel 1946), il progetto dello stabilimento Fiat Lingotto del 1922, il Ponte Risorgimento a Roma. Il monumento, realizzato dallo scultore Edoardo Rubino e dal decoratore Giulio Casanova, è composto da un semplice sacello marmoreo su cui è posto un corpo femminile, lievemente ricoperto da un lenzuolo che ne lascia scoperto il volto e che scivola appena oltre i bordi del sepolcro. Da una parte e dall’altra di questo, quattro figure femminili, due per ciascun lato, vegliano il feretro: quelle che stanno dal lato del capo porgono su questo le mani un poco rialzate come in segno di protezione, dall’altro lato una delle due donne veglia sul corpo con il capo reclino e l’altra alza il braccio sorreggendo una lampada. La compostezza delle figure lascia trasparire una sobrietà di sapore classico, nei gesti, nei panneggi, nella postura, mentre un delicato senso di pietas avvolge con intensità l’intera struttura compositiva. Sullo sfondo compare una particolare croce con tralci stilizzati di rose nella parte verticale e motivi dorati nel lato orizzontale. Al centro della croce una corona di rose bianche è posta intorno all’inquadratura dorata con la scritta “IHS” (sigla intesa come “Gesù salvatore degli uomini”, ma in realtà è la trascrizione latina abbreviata del nome greco di Gesù). Sulla volta del portico che accoglie il gruppo scultoreo, un cielo stellato d’oro mosaicato su fondo blu inquadra una grande croce.
Un’altra opera che richiama la mia attenzione in questo luogo di assordante silenzio è il Monumento Kuster, realizzato da Pietro Canonica nel 1921. Esso mostra una figura femminile con abito  succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.
succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.
È ancora un’altra fanciulla ad essere al centro della composizione funebre del Monumento Maganza, posta tra colonnine in marmo verde Roja, una giovane dal volto delicato, da cui traspare una espressione affranta; una sottile tunica le avvolge lieve il corpo esile, ha un’acconciatura alla moda, con i capelli corti, il volto, appena piegato e reclinato sulla mano sinistra, sembra voler trasmettere un messaggio di triste rimpianto. Alle spalle, marmorei tralci di fiori e, dietro, la croce. Soffermiamoci ancora sull’opera che si trova sulla sinistra, entrando dall’ingresso principale del Cimitero. Si tratta di un gruppo statuario che comprende una figura velata da un ampio panneggio, rappresentata mentre sta per avvolgere in un abbraccio simbolico una giovane figura femminile in piedi, con le braccia abbandonate lungo il corpo e il capo reclinato su una spalla. Dal basamento crescono steli e boccioli di rosa che paiono voler avvolgere i corpi sovrastanti: si tratta di una sintesi di decorazione Art Nouveau, completata dalla dedica dei committenti. L’opera fu eseguita da Cesare Redduzzi, scultore affermato e insegnante di scultura presso l’Accademia Albertina, più noto ai Torinesi come l’autore dei gruppi scultorei allegorici: l’arte, il lavoro, e l’industria, collocati nel 1909 a coronare le testate verso corso Moncalieri del ponte dedicato a Umberto I.
Moltissimi sono i monumenti funebri di squisito gusto Liberty davanti ai quali sarebbe opportuno soffermarsi, e numerose le figure femminili modellate con l’estetica della Nuova Arte, o che, con il loro atteggiamento da “dive” affrante del cinema muto, sorvegliano le anime di chi non c’è più e accompagnano silenziose gli sguardi di chi le va a trovare.
Alessia Cagnotto