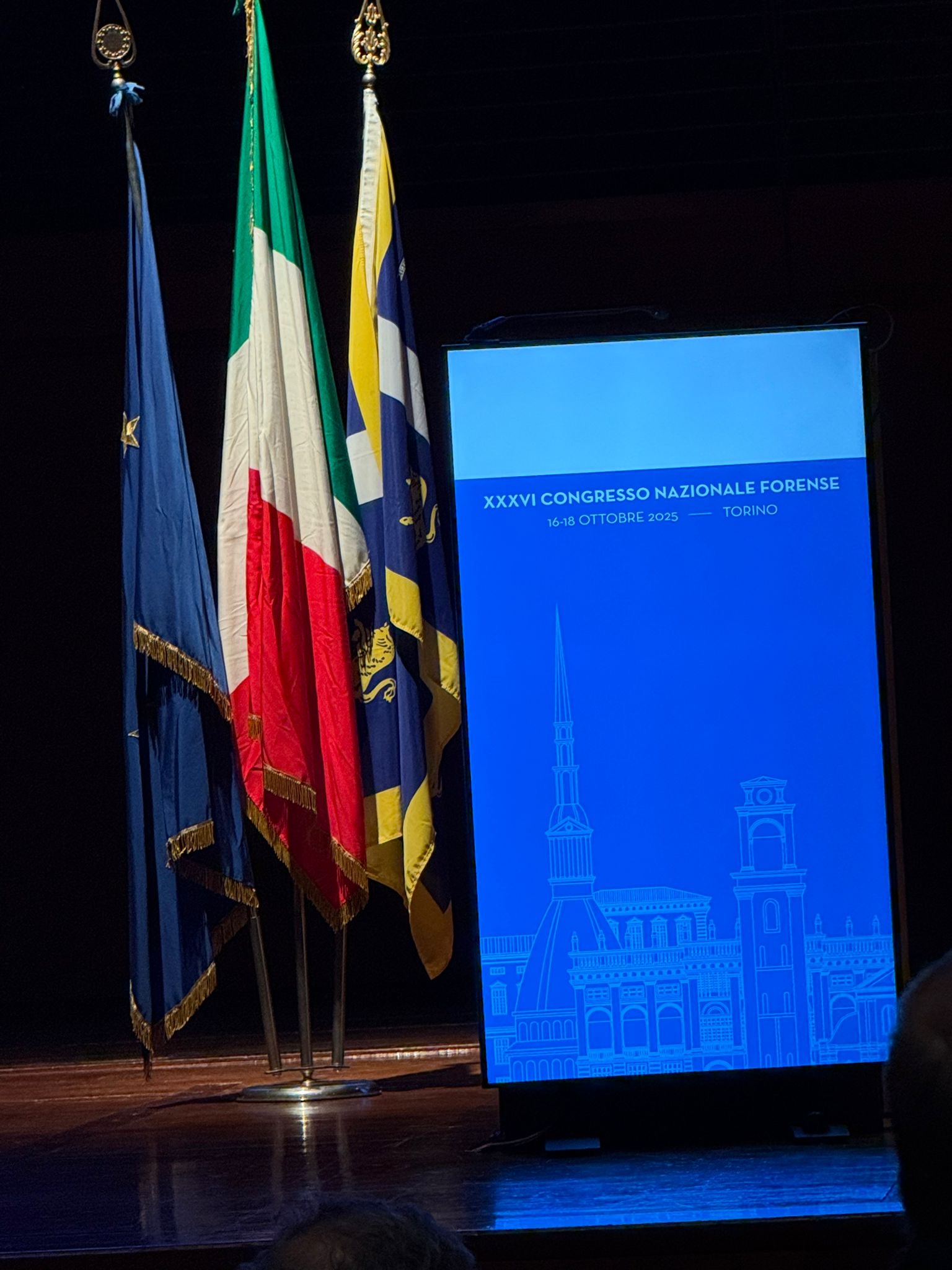Che leggi
RUBRICA A CURA DI IRMA CIARAMELLA*
Alla lettura dell’ANSA della morte di Alice ed Ellen Kessler, le gambe più famose della nostra TV, la memoria è corsa immediatamente al loro sorriso impeccabile a quelle gambe interminabili e a quel ritmo inconfondibile: Da-Da-Un-Pa.
Poi, la lettura della riga che cambia musica: sono morte insieme, con una procedura di suicidio assistito.
Le Kessler se ne sono andate come hanno vissuto: insieme, libere, padrone di sé. Due donne che hanno regalato leggerezza all’Italia del boom economico, che aveva bisogno di sognare di guardare oltre, hanno scelto proprio il 17 novembre per far calare il sipario sulla loro storia.
A Monaco di Baviera, nel loro Paese, dove il suicidio assistito è riconosciuto come diritto personalissimo alla morte autodeterminata, avevano pianificato ogni dettaglio: colloqui medici, valutazione della loro capacità decisionale, verifica della volontà, fino alla scelta del giorno. Non eutanasia attiva, ma supporto alla loro decisione che era giunto il momento di tagliare il filo della loro vita. Un addio che ancora ci parla di eleganza, autonomia, dignità.
In Germania questo è’ legale.
Dal 2020 il Bundesverfassungsgericht ha riconosciuto il diritto della persona di decidere se, quando e come porre fine alla propria vita: un’espressione della dignità umana e un diritto della persona. Da allora l’assistenza al suicidio, in Germania, è lecita se svolta con garanzie rigorose. Ed è proprio quel percorso che le Kessler hanno seguito, fin nei dettagli finali, destinando, coerentemente, per testamento anche i loro beni a organizzazioni umanitarie.
In Italia sarebbe stato possibile?
No. O almeno: solo in casi molto specifici.
Il nostro ordinamento rimane ancorato all’art. 580 c.p., con una lettura costituzionalmente orientata da sentenze anche recentissime della Corte Costituzionale con un’unica finestra di non punibilità aperta dalla sentenza Cappato–Dj Fabo. La Corte ribadisce che non esiste un diritto generale al suicidio assistito. E le sentenze della Corte Costituzionale svolgono una attività di colmare un vuoto normativo ( anche quella recentissima del 2025). Nel nostro Paese non c’è’ una legge organica, né una procedura uniforme: i requisiti cambiano a seconda della Regione di residenza e di appartenenza al SSN, e secondo interpretazioni che in mancanza di un quadro organico, sono lasciate alla soggettività degli interpreti locali. Il fine vita, da noi, è ancora una questione di coordinate geografiche (vedi approfondimento sotto) *
Ma la biografia delle Kessler ci dice di più’.
Dietro le due icone di fama e bellezza c’erano due bambine cresciute nella Germania dell’Est, un padre alcolista e violento, una madre che loro stesse considerano da ‘proteggere’. La danza come passione assoluta. A quattordici anni la fuga nella Germania dell’Ovest, e una promessa scolpita nella paura: “Mai più dipendere da un uomo”. Promessa mantenuta per tutta la vita: nessun matrimonio, relazioni affettive importanti ma autonome; il rifiuto della maternità, scelta consapevole alla luce delle loro carriere e dell’abdicazione ai ruoli familiari tradizionali; la gestione congiunta delle case, del lavoro, delle finanze; e infine un testamento orientato alla solidarietà (lasciti ad Onlus).
È un femminismo concreto e silenzioso, lontano dagli slogan ma potentissimo: l’indipendenza economica come presupposto per liberarsi da ogni forma di violenza o subordinazione; libertà di costruire il proprio progetto di vita senza matrimonio, né maternità obbligata; l’autodeterminazione sul corpo e sul fine vita, perché decidere come morire è la naturale continuità di una vita vissuta rivendicando la libertà di ‘ disporre’ di sé. Persino la loro determinazione di morire insieme appare oggi come l’estensione estrema di un patto di sorellanza, che ha sostituito per loro i modelli familiari tradizionali.
La loro scelta interroga il giurista e il legislatore. Se due donne lucide, informate, non fragili, né in ‘difficoltà relazionale’ scelgono il suicidio assistito come compimento coerente della propria biografia, il diritto deve poter accogliere (e normare) questa decisione? Oppure deve impedirla in nome di una vocazione protettiva di una vita che deve estendersi elasticamente sempre più anche resta poco o nulla della forza -non solo fisica – e dello spirito vitale complici trattamenti sanitari capaci di protrarre ogni giorno di più l’ultimo respiro? Possiamo accettare che in Italia l’accesso al fine vita dipenda ancora dalla disponibilità delle strutture sanitarie e dalla capacità – anche economica – di sostenere un contenzioso?
Le Kessler, senza proclami, hanno tenuto insieme le due parole cardine dei diritti del XXI secolo: dignità e autonomia.
E la domanda che ci consegnano, più che un testamento morale, è un’agenda politica:
Che leggi servono per trasformare una scelta individuale in un diritto regolato, garantito, sottratto alla clandestinità e alle diseguaglianze?
* Irma Ciaramella, avvocata
Approfondimento
Il tema del fine vita resta uno degli argomenti più delicati del dibattito giuridico e politico italiano. In assenza di una disciplina organica, è stata la Corte costituzionale a definire negli ultimi anni i confini entro cui l’aiuto al suicidio può considerarsi lecito, costruendo un modello fondato sul bilanciamento tra la tutela della vita e il diritto all’autodeterminazione del paziente.
Il punto di partenza è la legge n. 219/2017, che ha riconosciuto il diritto di ciascuno a rifiutare cure e trattamenti anche salvavita. La questione arriva alla Consulta con il caso Cappato–DJ Fabo, che apre il problema dell’aiuto al suicidio all’interno dell’ordinamento italiano.
1. L’ordinanza n. 207/2018: la Corte chiama il Parlamento
La Consulta rileva che l’art. 580 c.p. potrebbe essere incostituzionale in alcuni casi-limite e concede al Parlamento un anno per legiferare. Identifica già i criteri: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamenti vitali, piena capacità decisionale.
2. La sentenza n. 242/2019: il perimetro della non punibilità
Constatata l’inerzia legislativa, la Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 580 c.p. e stabilisce quando l’aiuto al suicidio non è punibile. Le condizioni sono cumulative:
• patologia irreversibile e prognosi infausta;
• sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili;
• dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
• piena capacità di intendere e volere;
• previo accesso (o rifiuto consapevole) alle cure palliative.
La procedura deve svolgersi sotto controllo del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Le pronunce del 2024 e 2025: conferma e chiusura del perimetro
• Sentenza n. 135/2024: conferma il requisito della dipendenza da trattamenti vitali, ritenuto essenziale per delimitare il campo dei casi ammessi.
• Sentenza n. 66/2025: ribadisce che solo il legislatore può ampliare la platea dei soggetti ammissibili; la Consulta mantiene il perimetro definito nel 2019.
Situazione attuale
L’assenza di una legge nazionale lascia un quadro frammentato: i comitati etici territoriali applicano i principi costituzionali senza linee guida uniformi, mentre alcune Regioni (Emilia-Romagna e Toscana) hanno avviato proprie discipline.
Le pronunce della Corte hanno costruito un sistema di garanzie minimo e coerente, evitando arbitri e offrendo tutela ai pazienti più vulnerabili. Ora la responsabilità è del Parlamento: trasformare questa architettura giurisprudenziale in una normativa chiara, uniforme e rispettosa dei diritti fondamentali.
PATROCINANTE IN CASSAZIONE



 Che leggi
Che leggi Il 36° Congresso Nazionale Forense, ospitato a Torino e promosso dal Consiglio Nazionale Forense insieme all’Ordine degli Avvocati torinese, ha restituito un quadro complesso dello stato dell’avvocatura italiana. La professione vive una fase di transizione strutturale, segnata da un calo costante di nuove iscrizioni e da un cambio generazionale che riflette non solo il mutato scenario economico, ma anche l’impatto profondo delle tecnologie digitali — prima fra tutte, l’intelligenza artificiale.
Il 36° Congresso Nazionale Forense, ospitato a Torino e promosso dal Consiglio Nazionale Forense insieme all’Ordine degli Avvocati torinese, ha restituito un quadro complesso dello stato dell’avvocatura italiana. La professione vive una fase di transizione strutturale, segnata da un calo costante di nuove iscrizioni e da un cambio generazionale che riflette non solo il mutato scenario economico, ma anche l’impatto profondo delle tecnologie digitali — prima fra tutte, l’intelligenza artificiale. Per il Presidente del CNF, Francesco Greco, la sfida è costruire un modello di IA “interna e controllata”, al servizio della categoria, che garantisca la tutela dei dati sensibili e la parità di accesso agli strumenti digitali anche per gli avvocati più giovani o non integrati in grandi Law Firm che non può permettersi Algoritmi addestrati su misura costosi.
Per il Presidente del CNF, Francesco Greco, la sfida è costruire un modello di IA “interna e controllata”, al servizio della categoria, che garantisca la tutela dei dati sensibili e la parità di accesso agli strumenti digitali anche per gli avvocati più giovani o non integrati in grandi Law Firm che non può permettersi Algoritmi addestrati su misura costosi.