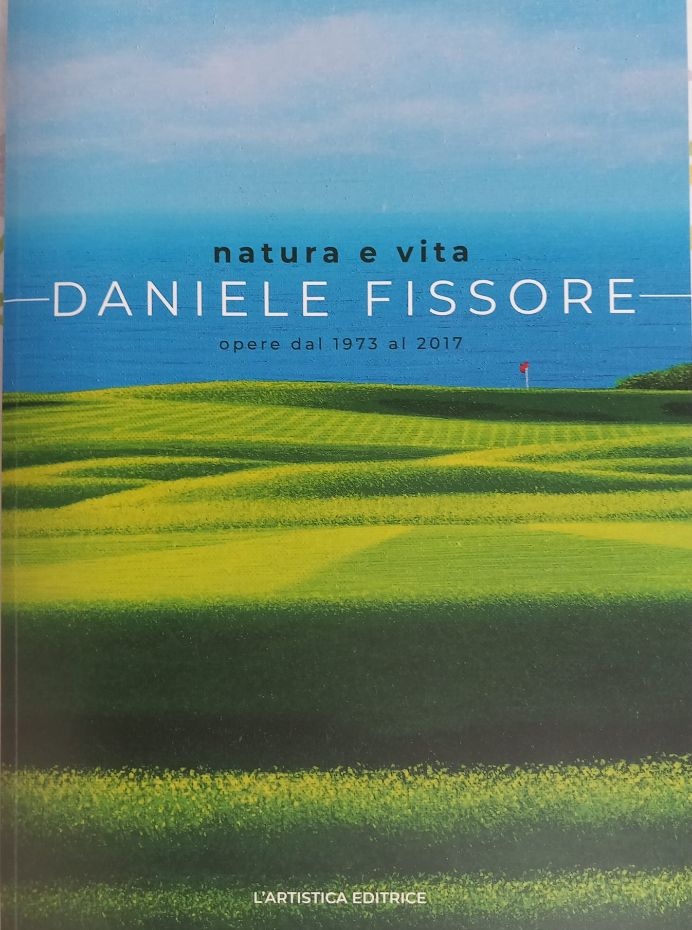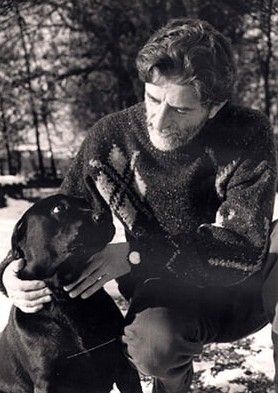Al Museo MIIT di corso Cairoli 4 si tiene una doppia mostra dal 12 giugno al 4 luglio prossimo, la prima dal titolo “Akshida Lad- Soft Impressions”, la seconda dedicata all’artista Fadilja Kajosevic.
“La mostra personale di Akshita Lad al museo MIIT di Torino- afferma il curatore e direttore del MIIT, Guido Folco – prosegue il percorso internazionale dell’artista che l’ha vista protagonista in Italia e all’estero in numerosi eventi prestigiosi svoltisi in questi ultimi anni all’insegna della sua arte e del suo pensiero. Le opere di Akshita Lad si inseriscono, infatti, perfettamente in una visione virtuosa della natura, del mondo, dello spirito dell’uomo. Il suo è un invito rivolto a tutti a rallentare la frenesia dell’esistenza moderna per mettersi in contatto con se stessi e il pianeta. È come se si trattasse di una pittura meditativa, quasi una autoanalisi incentrata sulla propria energia vitale, sul senso ultimo della vita, su quanto sia importante connettersi con la natura per recepire la bellezza e la purezza. Si tratta di una rinascita che l’artista intende proporci attraverso la sua pittura soffusa, che vive di trasparenze e intimità espressiva, sospesa in un universo onirico e metafisico, ma al contempo molto reale, tangibile, perché comunque sempre ispirato al reale.
Akshita Lad lavora sui toni, sui colori, sulle trasparenze cromatiche, sulle velature dei pigmenti che sulla tela siano impalpabili, leggeri, lievi, effimeri come lo scorrere del tempo,
Spazio e tempo sono, in effetti, elementi fondamentali della sua arte, di cui il primo viene declinato attraverso forme solo suggerite, abbozzate, immaginate, mentre il secondo scandisce i giorni, le stagioni, le diverse atmosfere del sentire intimo dell’artista.
Questo tempo immaginifico di luoghi inventati diventa metafora dello spirito in cui immergersi per ritrovare un’osmosi profonda con la natura e con il creato”.
Akshita Lad vive e lavora a Dubai. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.
“La mia arte – afferma Akshita Lad – è un riflesso della bellezza e della ricchezza emotiva intessute nei momenti di quiete della vita.
Attraverso pennellate morbide, sfumature di colore trasparenti e composizioni senza tempo, cerco di evocare serenità, gioia e un senso di interconnessione. Il mutare delle stagioni, l’effimera danza della luce e la forza silenziosa della natura mi ispirano continuamente. Ogni dipinto invita l’osservatore a fermarsi, respirare e riconnettersi con l’energia silenziosa che ci circonda e vive dentro di noi. L’arte, per me, è una dolce preghiera, una celebrazione delle silenziose meraviglie della vita”.
 La mostra personale di Fadilja Kajosevic al Museo MIIT di Torino narra l’avventura di una donna artista internazionale che, nel mondo femminile, ha trovato l’ispirazione per la sua ricerca e sperimentazione. Ella interpreta l’essere e il Creato come un tutt’uno perfettamente in simbiosi, simbolicamente fuse in un unico afflato verso la purezza e la sacralità. Angeli, Lune, Soli, presenze silenti abitano i suoi dipinti accesi da vibranti cromatismi e bagliori di luce, sempre equilibrati nella composizione e nella dinamica del percorso esistenziale e interiore. Una pittura intimista, universale, in cui il tema dell’armonia domina ogni scena, quasi si trattasse di scenografie teatrali dai mille personaggi. L’artista incarna un’originale presenza contemporanea nel mondo della creatività.
La mostra personale di Fadilja Kajosevic al Museo MIIT di Torino narra l’avventura di una donna artista internazionale che, nel mondo femminile, ha trovato l’ispirazione per la sua ricerca e sperimentazione. Ella interpreta l’essere e il Creato come un tutt’uno perfettamente in simbiosi, simbolicamente fuse in un unico afflato verso la purezza e la sacralità. Angeli, Lune, Soli, presenze silenti abitano i suoi dipinti accesi da vibranti cromatismi e bagliori di luce, sempre equilibrati nella composizione e nella dinamica del percorso esistenziale e interiore. Una pittura intimista, universale, in cui il tema dell’armonia domina ogni scena, quasi si trattasse di scenografie teatrali dai mille personaggi. L’artista incarna un’originale presenza contemporanea nel mondo della creatività.
Mara Martellotta




 Qui espone l’artista bavarese che è stata dagli anni Settanta a Torino, si è trasferita a Ginevra , quindi ha allestito un suo atelier a Bardonecchia dal 1993 e che ha chiuso quest’anno dopo 32 anni di attività, quindi è anche approdata a Genova, sempre dedicandosi all’ umorismo, all’illustrazione e alla decorazione.
Qui espone l’artista bavarese che è stata dagli anni Settanta a Torino, si è trasferita a Ginevra , quindi ha allestito un suo atelier a Bardonecchia dal 1993 e che ha chiuso quest’anno dopo 32 anni di attività, quindi è anche approdata a Genova, sempre dedicandosi all’ umorismo, all’illustrazione e alla decorazione. Nella mostra i suoi disegni sono accompagnati dalle “teste di legno”, dipinte e sagomate di Vip di suo marito Benny Naselli, fumettista e umorista, caricaturista, ritrattista e “uno che scrive”, come lui amava definirsi, e che ci ha lasciato nel 2023.
Nella mostra i suoi disegni sono accompagnati dalle “teste di legno”, dipinte e sagomate di Vip di suo marito Benny Naselli, fumettista e umorista, caricaturista, ritrattista e “uno che scrive”, come lui amava definirsi, e che ci ha lasciato nel 2023.

 In questa mostra singolare c’è tutto il piccolo mondo di Anja da scoprire, le sue favole, i suoi sogni. Un sogno che si è verificato è stato a Gallarate, in una mostra sull’umorismo l’incontro con Benny, il loro matrimonio, l’unione di vita e arte. Realizzano quadri insieme, mostre, viaggi. Anja incoraggia il consorte a scrivere i suoi quattro libri, quello di poesie, di comic-strips, racconti e la sua autobiografia, e a disegnare ritratti e caricature in pubblico.
In questa mostra singolare c’è tutto il piccolo mondo di Anja da scoprire, le sue favole, i suoi sogni. Un sogno che si è verificato è stato a Gallarate, in una mostra sull’umorismo l’incontro con Benny, il loro matrimonio, l’unione di vita e arte. Realizzano quadri insieme, mostre, viaggi. Anja incoraggia il consorte a scrivere i suoi quattro libri, quello di poesie, di comic-strips, racconti e la sua autobiografia, e a disegnare ritratti e caricature in pubblico.



 Nel basamento vi sono quattro bassorilievi in bronzo che rappresentano due avvenimenti storici ( “Il Congresso di Parigi” e “Il ritorno delle truppe sarde dalla Crimea”) e gli stemmi della famiglia Cavour incorniciati da una corona d’alloro e da una ghirlanda di frutti.
Nel basamento vi sono quattro bassorilievi in bronzo che rappresentano due avvenimenti storici ( “Il Congresso di Parigi” e “Il ritorno delle truppe sarde dalla Crimea”) e gli stemmi della famiglia Cavour incorniciati da una corona d’alloro e da una ghirlanda di frutti.