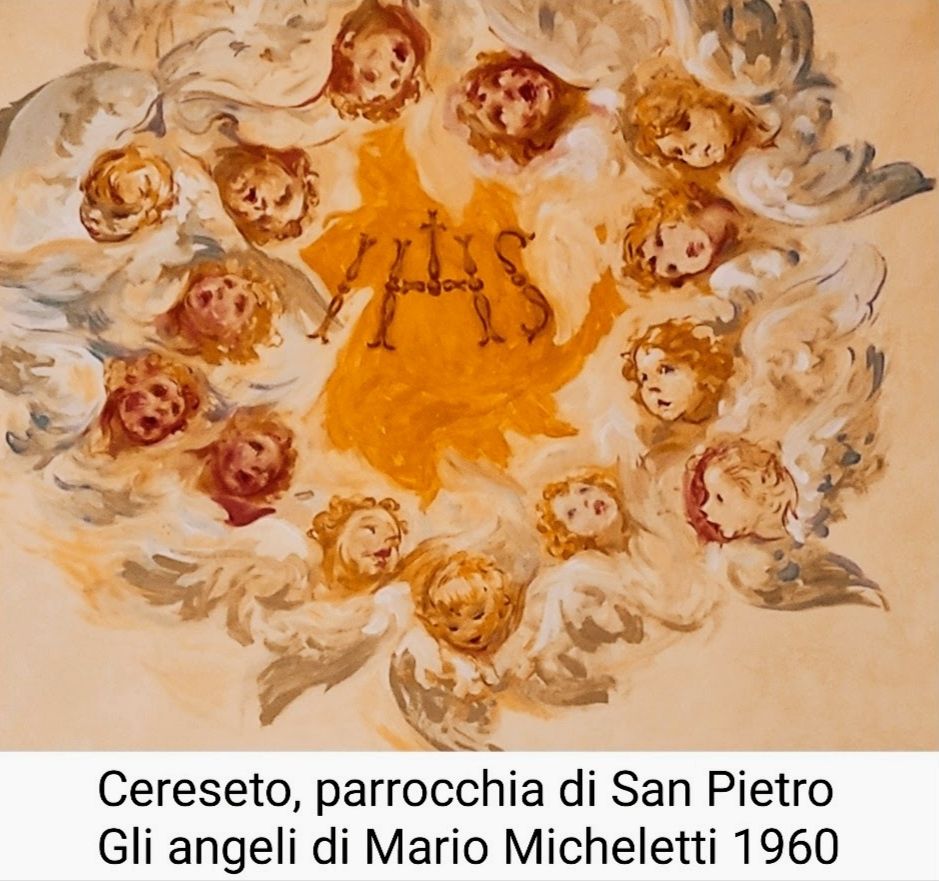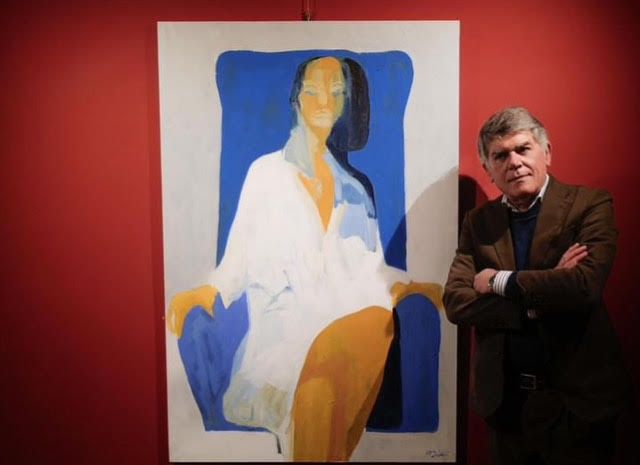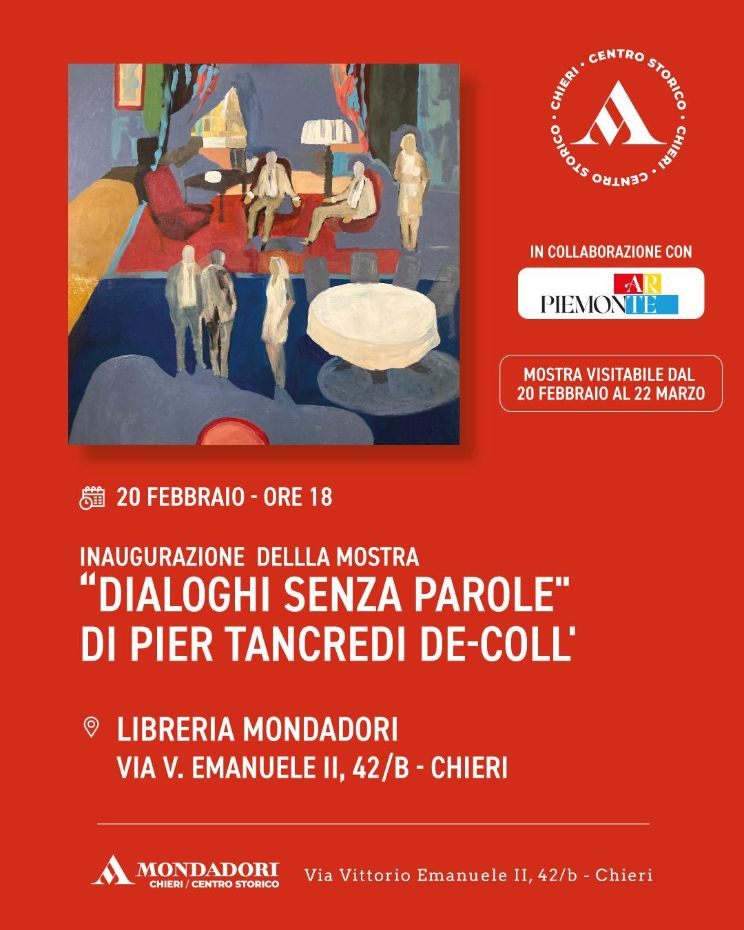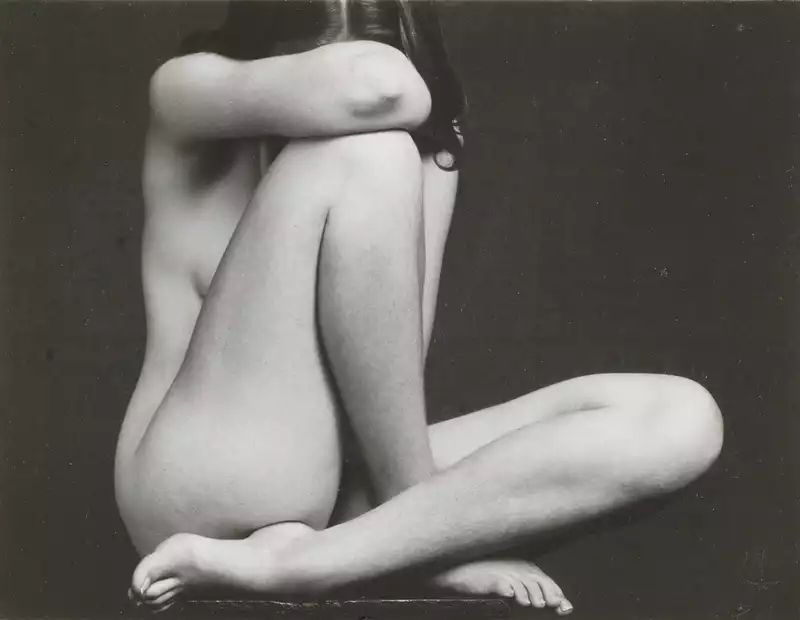Alla Galleria Malinpensa, sino al 28 febbraio, la mostra “Prospettive luminose”
C’è una fantasiosa libertà e vivacità, c’è l’esattezza del disegno, il piacere di allineare in una stessa opera i più vari colori sebbene attenti ai loro ravvicinamenti, la dolcezza delle tonalità pacate e tenui, ci sono gli insegnamenti degli antichi maestri Marco D’Aponte e Alex Ognianoff e tutta l’attenzione di una scuola, c’è una facciata che appare nell’immediato e andando in profondo un esatto mondo pittorico tutto da decifrare, tanti mondi letterari e non soltanto che amano svelarsi a chi guarda, ci sono le tante letture di un’epoca ormai più o meno antica ma sempre pronta a riscoprirsi, c’è il divertimento sempre al colmo di ragioni e di basi solide di scoprire, segni che sono firme, particolari gioiosi, fortunati materiali di riciclo, c’è l’atmosfera del teatro e dell’avventura, dai pupi di Sicilia alle maschere di un mondo goldoniano che l’autore da sempre ha inseguito, ci sono quei “Ghosts” che avvicinano maggiormente a un mondo più nostro. C’è questo e molto altro nelle opere di Massimiliano Gissi, nelle sale della Galleria Malinpensa by La Telaccia di corso Inghilterra 51, sino al 28 febbraio. Oggi cinquantenne, l’artista è passato – c’informano le schede di Monia Malinpensa a cui si deve la curatela della mostra – “dalla grafica computerizzata alla colorazione digitale, all’animazione (presso la Lanterna Magica di Torino) al restauro di belle arti (operando su arredi del Duomo di Torino e della Venaria Reale), sino all’editoria per ragazzi, tra libri e fumetti”. “Visionario” e segnato da autentica originalità, introspettivo al mondo magico e della fiaba, sempre spingendoti alla rivelazione di nuovi messaggi, non facili né tanto meno gratuiti, Gissi ti fa attraversare gli spazi della galleria con parole che dopo poco senti completamente tue, alla scoperta di significati e sensazioni a cui un attimo prima non avevi badato. Acquerelli e tecniche miste da gestire, “espedienti cromatici realizzati sia con acrilici, tempere, gessetti, matite colorate che con finiture scintillanti di glitters e vinavil e oggetti di recupero di varia natura”, ogni mezzo è capace di rendere appieno la compiutezza dell’opera.
È un linguaggio tutto suo proprio quello che Gissi esprime, costruttore di una poetica divenuta immediatamente riconoscibile, che esige una ricerca continua e che oggi sfocia in Prospettive luminose, mostra e luogo dove pare che quel mondo della favola si renda realtà, tangibile e curiosa, “dove ogni colore e forma diventano finestre su mondi inattesi e immaginari”. Colombina e le altre maschere allineano la bellezza dei costumi e sovrapposizioni di materiali, le eterne farfalle che sono il marchio dell’autore e insetti, ciliegie e ricami, stelle e fiori, mentre guardano a un Sandokan la cui ironia raccoglie divertenti animali della giungla, con tanto di “fumetti” pericolosi (un improvviso “roar”), che sembrano guardare al divertimento di Jacovitti. Il Joker produce prodezze su una palla colorata e tra carte che svolazzano (“I’m going slightly mad”, 2021), mentre in “The Sicily’s Theater” i campioni della “Gerusalemme” vestono, all’interno di un sipario rosato, la precisione delle loro multicolori armature, tra elmi e scudi e spade, lasciandosi alle spalle le tende dell’accampamento. Luogo spesso rivisitato, Gissi con grande inventiva, dando spazio alla protagonista o concentrandosi maggiormente ai suoi compagni di viaggio, ci introduce al magico mondo del reverendo Carroll o con ricchezza di particolari ci mostra il divertente “Capitan Nemo” (2025), una macchina futuribile a forma di pesce, labbroni color arancio e tenaglie e luci di direzione e pinne mentre in disparte un granchio antropoformizzato pare il giamaicano Sebastian della “Sirenetta”.
Non soltanto opere su carta e colori riempiono il mondo surreale di Gissi. In piccole vetrine della “Malinpensa” un “Papillon” (2022), scultura polimaterica, raccoglie stoffe ricamate e bottoni rossi, ali argentate, nastri e cordoncini colorati, fili di ferro intrecciati, come un “rock and roll robot” (2023), con tanto d’antenne e lampadine, orologi attaccati sul petto, rivestimenti d’argento e tappi, cuoricini rossi e perle, come il giullare, agghindatissimo, che è diventato “Mister Buffo”, tanto per rivisitare un titolo teatrale. Mondo teatrale che non dimenticate d’osservare con attenzione, prima d’uscire dalla galleria: quei “Saltimbanchi alla corte dei Gonzaga” (2024), vera e propria scenografia, la luna e il castello, le maschere e i pupazzi, la piccola giostra, i pezzi degli scacchi disseminati, le stoffe e l’ordine delle passamanerie e il mappamondo impugnato: tutto è sotto i nostri sguardi, per il vero trionfo della fantasia.
Elio Rabbione
Nelle immagini, alcune opere di Massimiliano Gissi: “Saltimbanchi alla corte dei Gonzaga”, scultura polimaterica, “The Show Queen”, tecnica polimaterica, “The Comedy of Art”, tecnica polimaterica.