Se la aggiudica il Piemonte di Mirella Rocca alla finale
Alicya Ferrero, di Borgaro, proprio come Cristina Chiabotto, due occhi azzurri come il mare, si è presentata in finale a Miss Italia, andata in onda il 15 settembre su Rai Play e vinto dalla lucana Katia Buchicchio, con la fascia di Miss Valle d’Aosta. A rappresentarla in tutta la sua essenza, è stata la fascia di Miss Coraggio, assegnatale al concorso di Patrizia Mirigliani dopo aver ascoltato la sua storia, una vicenda di forza e coraggio che ha emozionato, commosso e fatto riflettere.
“Indossare questa fascia nazionale è un privilegio che va oltre l’apparenza – spiega Alicya – non è soltanto un titolo, ma un simbolo che custodisce volti, emozioni e sogni. È la vicenda della resilienza, della forza, ma anche di quella fragilità che quando viene accolta diventa una risorsa. Questa fascia, Miss Coraggio, ha un significato speciale perché racconta anche la mia vita: sono cresciuta con mia mamma, mentre mio papà ci ha abbandonate. Ogni tanto tornava, ma quei ritorni non portavano serenità. Vederlo andare e venire distrugge a la mia stabilità emotiva, mi faceva sentire ancora più fragile, come se non fossi abbastanza per meritare il suo amore. Quel dolore mi accompagna ancora oggi. A 16 anni la vita mi ha messo davanti a un’altra dura prova: la scoperta di una massa al seno. Per una ragazza così giovane una notizia del genere è un macigno, mi sono chiusa in me stessa, convinta di essere incompresa nel mio dolore. Erano giorni di silenzi e paure che sembravano più grandi dei miei sogni, eppure da quell’esperienza ho scoperto la forza di potermi rialzare anche quando tutto sembrava crollare. Per questo sento che questa fascia mi si addice, perché è il riflesso di una storia di cadute e rinascite, il simbolo di un coraggio che non nasce dall’assenza di paura, ma dalla scelta quotidiana di non lasciarsene vincere. Arrivare in finale è la dimostrazione che ognuno ha un dono unico, anche nei momenti più difficili. Porterò questa fascia con gratitudine e con la certezza che la vera bellezza non è solo esteriore, ma autenticità è verità”.
Alicya studia moda e cultura d’impresa e sogna la grande fiction, dove vorrebbe interpretare ruoli da protagonista.
Mara Martellotta



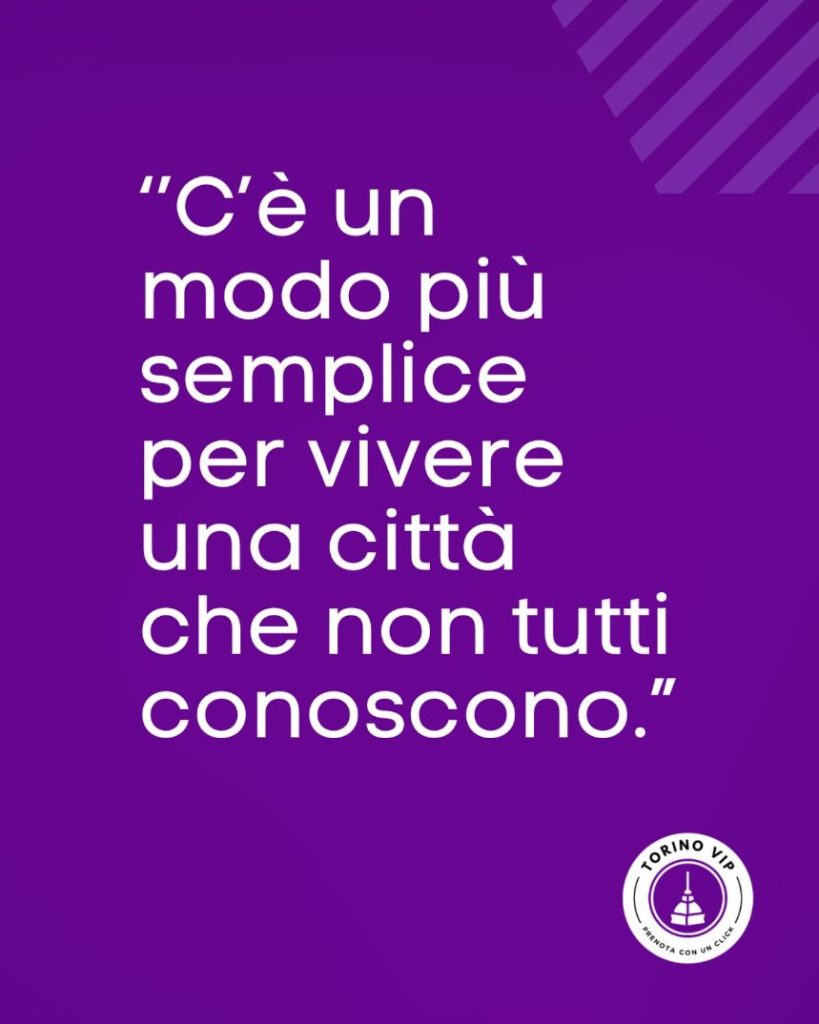










 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni