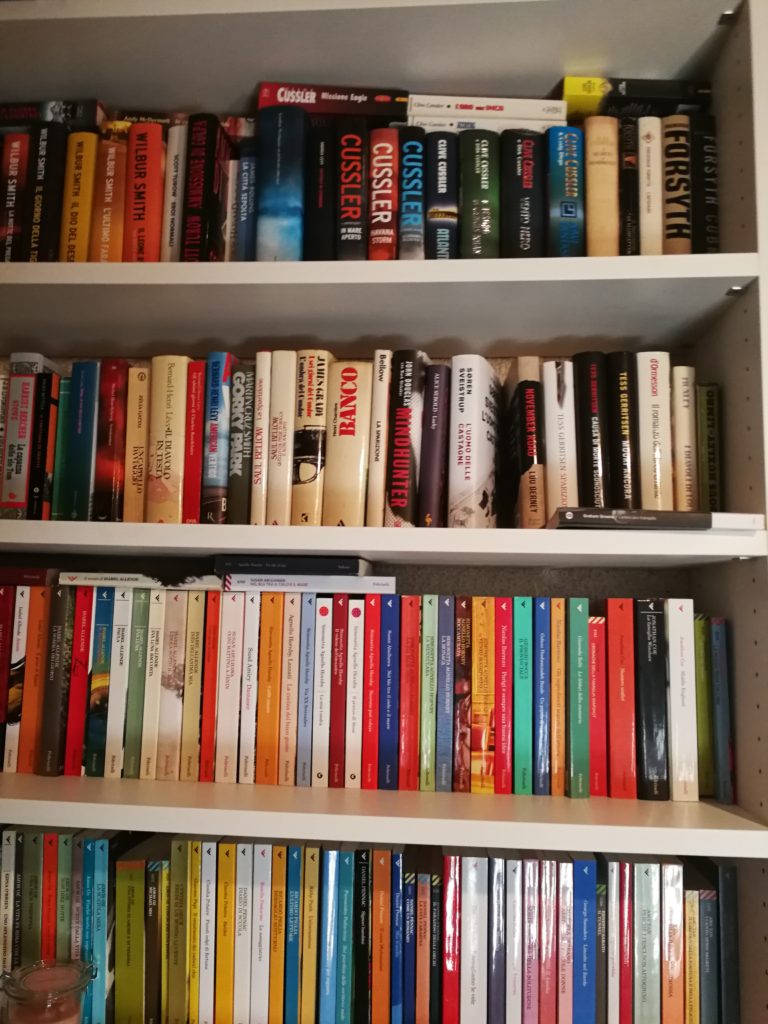CICLO DI CONFERENZE ON LINE in occasione della mostra Ritratti d’oro e d’argento
13 aprile – 22 giugno ore 18
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica
Palazzo Madama propone, dal 13 aprile al 22 giugno 2021, un ciclo di sette incontri di approfondimento tra arte, devozione, tutela e indagini diagnostiche, in occasione della mostra Ritratti d’oro e d’argento, in corso a Palazzo Madama fino al 12 luglio 2021, che intendono offrire, grazie a un taglio interdisciplinare, uno sguardo sia sul contesto in cui si è sviluppata la produzione orafa in Piemonte e Valle d’Aosta tra Tardo Gotico e Rinascimento, sia sulle azioni di ricerca, tutela e valorizzazione, che musei, diocesi, soprintendenze e università stanno portando avanti con un importante lavoro di sinergia.
Il 27 aprile Laura Marino si soffermerà sulle vicissitudini di alcune opere in mostra che, una volta uscite dalla bottega, giunsero in luoghi lontani anche centinaia di chilometri: nel corso dei secoli furono soggette a interventi di aggiornamenti di gusto, a riparazioni o a trasferimenti in nuove sedi, ma anche sottratte al loro contesto, come il san Teobaldo di Alba, trafugato negli anni ’80 del Novecento e recuperato nel 2014.
L’11 maggio don Gianluca Popolla illustrerà il lavoro della Consulta Regionale per i Beni Ecclesiastici di Piemonte e Valle d’Aosta che opera attraverso gli Uffici per l’arte sacra e i beni culturali nelle sedici diocesi piemontesi e in quella di Aosta nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, archivistico e librario.
Il 18 maggio sarà il turno di Fulvio Cervini e Angelo Agostino che presenteranno i risultati delle ricerche condotte sui busti dei santi Ruffino e Venanzio provenienti dalla chiesa vecchia al Castello di Sarezzano, nei pressi di Tortona: un processo di conoscenza basato su analisi storico-artistica e indagine diagnostica in un necessario dialogo interdisciplinare finalizzato a spostare sempre in avanti il fronte della ricerca.
Il 25 maggio a Marco Fratini sarà affidato il compito di tratteggiare, anche attraverso numerosi documenti d’archivio, la raffinata stagione dei principi d’Acaia che a inizio Quattrocento richiesero a orafi locali ricche finiture per abiti e teche per preziose reliquie, tra cui il busto di san Giovenale commissionato da Ludovico d’Acaia a Severino Dorerio per donarlo alla cattedrale di Fossano.
L’8 giugno Simone Baiocco ripercorrerà le vicende delle committenze artistiche destinate alla collegiata di San Secondo di Asti, chiesa identitaria di una città contesa dal XV secolo e fino al 1531 tra le potenti casate dei Savoia, Paleologi, Visconti e Valois-Orlèans.
Il ciclo si concluderà il 22 giugno quando, in prossimità della festa di san Giovanni Battista, patrono della città di Torino, Viviana M. Vallet e Alessandra Vallet presenteranno due interessanti reliquiari di primo Quattrocento, appartenenti al Tesoro della Cattedrale di Aosta: il san Giovanni Battista e il san Grato rappresentano infatti due capolavori dell’arte orafa in cui i tradizionali materiali preziosi dell’oro e dell’argento convivono con un innovativo trattamento pittorico dei volti.
Calendario appuntamenti:
13 aprile 2021, ore 18.00
Prestigio, devozione e perizia tecnica: la bottega di Beltramino de Zuttis
con Cinzia Piglione, storica dell’arte
27 aprile 2021, ore 18.00
Le seconde vite: reliquiari a busto tra viaggi, rimaneggiamenti, restauri e restituzioni
con Laura Marino, Direttrice del Museo San Sebastiano, Cuneo
11 maggio 2021, ore 18.00
Wellness dello spirito: le politiche culturali delle diocesi piemontesi
con don Gianluca Popolla, incaricato beni culturali della Regione Ecclesiastica Piemonte
18 maggio 2021, ore 18.00
Materie insolite. Lo strano caso degli eremiti di Sarezzano
con Fulvio Cervini, Università degli Studi di Firenze, dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS e Angelo Agostino, Università degli Studi di Torino, dipartimento di Chimica
25 maggio 2021, ore 18.00
Gli ori del principe. Manufatti preziosi per gli Acaia con Marco Fratini, storico dell’arte
8 giugno 2021, ore 18.00
La collegiata di San Secondo nel Quattrocento. Committenti e opere d’arte ad Asti
con Simone Baiocco, conservatore di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Torino
22 giugno 2021, ore 18.00
Policromia su argento: i reliquiari di san Giovanni Battista e di san Grato dalla cattedrale di Aosta
con Viviana M. Vallet e Alessandra Vallet, Soprintendenza per i beni e le attività culturali Regione Autonoma Valle d’Aosta
Info: le conferenze si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Tutti i dettagli sul sito di Palazzo Madama www.palazzomadamatorino.it
Prenotazione obbligatoria: t. 0114429629; madamadidattica@fondazionetorinomusei.it
Costo: 16€ per intero ciclo di sette conferenze; 4€ per conferenza singola.
Acquista subito:
https://www.arteintorino.com/acquisti-online/product/4482-sette-lezioni-di-approfondimento.html
MERCOLEDI 14 APRILE
Mercoledì 14 aprile ore 21
GALLERIE DEDICATE ALL’ASIA MERIDIONALE E SUD-EST ASIATICO, REGIONE HIMALAYANA E PAESI ISLAMICI DELL’ASIA.
MAO – visita online nell’ambito del progetto Connessioni d’arte
L’appuntamento con la guida del MAO permette di coinvolgere i partecipanti attraverso immagini di alta qualità in grado di restituire al visitatore punti di vista esclusivi sulle collezioni.
Si parte dalle opere d’arte indiana, con la statuaria di soggetto buddhista e induista di varia datazione, per proseguire il viaggio attraverso il Sud-est asiatico.
Nella galleria dedicata alla regione Himalayana, saranno illustrate le opere d’arte buddhista tibetana che spaziano dalle sculture in legno e metallo ai dipinti a tempera, fino alle preziose copertine lignee intagliate e dipinte. Il percorso si conclude nella galleria dei Paesi Islamici dell’Asia, caratterizzata dalla ricca collezione di vasellame e piastrelle e da una pregevole raccolta di bronzi, manoscritti e raffinati tessuti.
Info e prenotazioni: visita guidata on-line 8€ intero; ridotto 7€ (possessori di Abbonamento Musei).
Prenotazioni al numero 011 5211788 oppure scrivendo a info@arteintorino.com; a seguito della prenotazione saranno inviati dettagli ed estremi bancari per effettuare il pagamento con bonifico oppure sarà possibile effettuare l’acquisto on-line.