SOMMARIO: Pisanu tra Moro e Berlusconi – Gente di Piemonte – Lettere



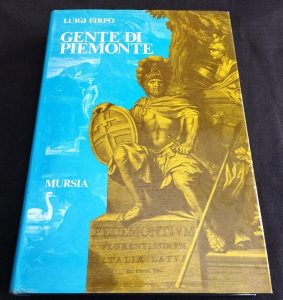
 LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com
LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.comDà fastidio leggere che Steve della Casa, ex Lotta Continua, noto per le imprese violente dell’”Angelo Azzurro” di via Po con conseguenze penali e il vecchio ottuagenario Bruno Gambarotta si occupano della due giorni sul figlio di Piero Gobetti esaltato come grande uomo di cinema. Ho conosciuto Paolo e mi pareva un uomo finito sia per il matrimonio infelice con Carla che si credeva la vera erede di Piero, sia per altri aspetti di vita a tutti noti, ma di cui nessuno parla e sui quali io stesso taccio. Narciso Nada fondatore del Centro “Gobetti” andò via perché non voleva mescolarsi con gli eredi. Ma oggi c’è anche Polito che inizia le sue Messe cantate in anticipo rispetto al 2026 per non perdere tempo. Segretario tuttofare di Bobbio, se ne considera erede al Centro “Gobetti“ che gode di una duplice sede: una in via Fabro e una al Polo del ‘900. Un privilegio ingiustificabile. Non crede che sia il caso di dire basta alle Messe Cantate? Occorre la storia, non le litanie di Polito. Innocenzo Rinucci
















 “Cresce il numero degli spettatori a parità del numero di titoli in programma – 120 suddivisi nelle tre sezioni di concorso e nelle tre sezioni non competitive -: la percentuale di riempimento delle sale arriva all’83%”, si recita dagli uffici di via Montebello, più che forti della quota salita a 38.000 per le presenze, 65 titoli sold out, calcolando ancora una crescita per abbonati e accreditati, per un incasso complessivo di oltre 152.000 euro, incasso che aveva quasi toccato i 130mila nell’edizione del 2024. Si gongola per i mezzi del momento, per una edizione “dal forte impatto social e risultati record di visibilità”, in cui si raggiungono i 7,3 milioni di visualizzazioni (+211%) e 3,3 milioni di persone (232%). Crescono nel 2025 le condivisioni del 116%, “segno di un passaparola di qualità”, del 149% su Instagram e del 23% di salvataggi, a conferma di un interesse sempre più attivo. Finalmente si è constatato come anche la tivù di stato sappia collegarsi per servizi e interviste e resoconti fin sotto le montagne, abbracciando pure la cerimonia d’apertura trasmessa in diretta su Raiplay: per cui sarà soltanto questione d’aver fede e tempo e pure le reti maggiori sapranno organizzarsi. L’impianto organizzativo e i tanti main sponsor – Ministero della Cultura/Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia San Paolo e Fondazione CRT – avranno diritto a qualcosa che vada un po’ più oltre. Legittima attesa da presidenza e direzione. Già ad apertura di programmazione, la Regione metteva in campo “una visione ancora più ambiziosa” attraverso le parole dell’assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli: “Il Torino Film Festival è l’evento cinematografico clou della nostra stagione culturale, un appuntamento che porta a Torino il respiro internazionale del grande cinema. Ma oggi voglio dirlo con chiarezza: Il Piemonte non deve porsi limiti. Possiamo e dobbiamo ambire a diventare uno dei poli cinematografici più importanti d’Europa.” Attraverso “investimenti mirati, un sistema produttivo in crescita e una programmazione capace di attrarre talenti e produzioni internazionali”: non resta che alzare l’asticella, ampliando le presenze di quanti fanno cinema per il mondo e costruendo opportunità nuove e concrete per chi crea.
“Cresce il numero degli spettatori a parità del numero di titoli in programma – 120 suddivisi nelle tre sezioni di concorso e nelle tre sezioni non competitive -: la percentuale di riempimento delle sale arriva all’83%”, si recita dagli uffici di via Montebello, più che forti della quota salita a 38.000 per le presenze, 65 titoli sold out, calcolando ancora una crescita per abbonati e accreditati, per un incasso complessivo di oltre 152.000 euro, incasso che aveva quasi toccato i 130mila nell’edizione del 2024. Si gongola per i mezzi del momento, per una edizione “dal forte impatto social e risultati record di visibilità”, in cui si raggiungono i 7,3 milioni di visualizzazioni (+211%) e 3,3 milioni di persone (232%). Crescono nel 2025 le condivisioni del 116%, “segno di un passaparola di qualità”, del 149% su Instagram e del 23% di salvataggi, a conferma di un interesse sempre più attivo. Finalmente si è constatato come anche la tivù di stato sappia collegarsi per servizi e interviste e resoconti fin sotto le montagne, abbracciando pure la cerimonia d’apertura trasmessa in diretta su Raiplay: per cui sarà soltanto questione d’aver fede e tempo e pure le reti maggiori sapranno organizzarsi. L’impianto organizzativo e i tanti main sponsor – Ministero della Cultura/Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia San Paolo e Fondazione CRT – avranno diritto a qualcosa che vada un po’ più oltre. Legittima attesa da presidenza e direzione. Già ad apertura di programmazione, la Regione metteva in campo “una visione ancora più ambiziosa” attraverso le parole dell’assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli: “Il Torino Film Festival è l’evento cinematografico clou della nostra stagione culturale, un appuntamento che porta a Torino il respiro internazionale del grande cinema. Ma oggi voglio dirlo con chiarezza: Il Piemonte non deve porsi limiti. Possiamo e dobbiamo ambire a diventare uno dei poli cinematografici più importanti d’Europa.” Attraverso “investimenti mirati, un sistema produttivo in crescita e una programmazione capace di attrarre talenti e produzioni internazionali”: non resta che alzare l’asticella, ampliando le presenze di quanti fanno cinema per il mondo e costruendo opportunità nuove e concrete per chi crea.




