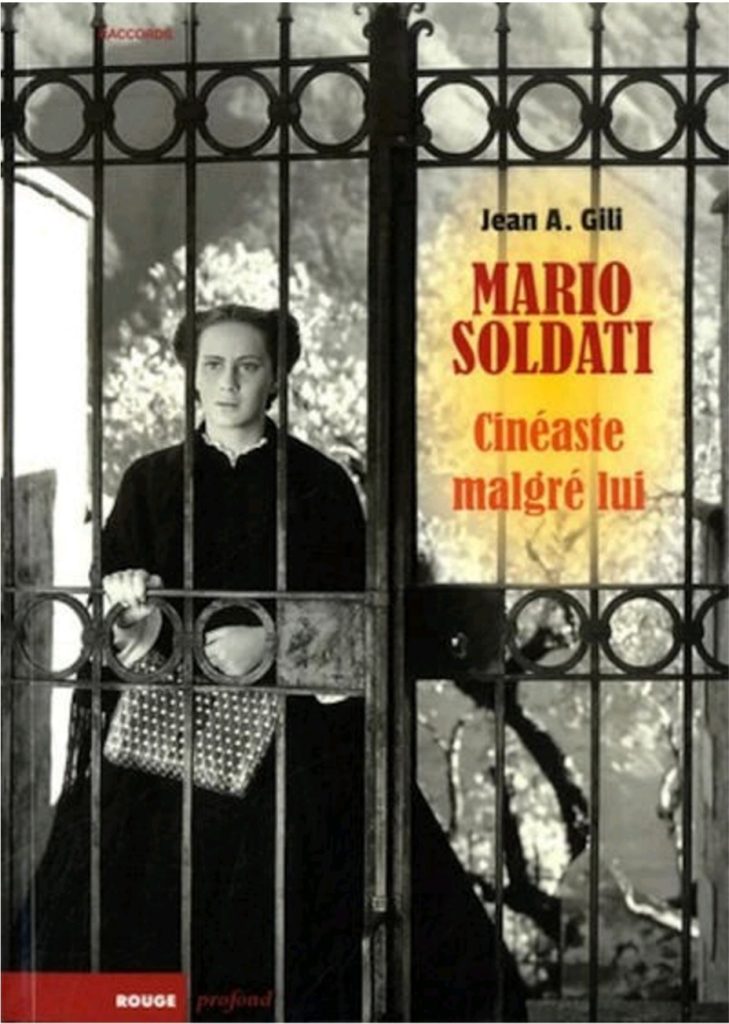MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE ALLE ORE 17,30
in sede (via Maria Vittoria 35h, Torino), incontro sul tema “UNA RIFLESSIONE CON JEAN GILI SU MARIO SOLDATI CINEASTA” (in lingua italiana). In collaborazione con il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri.
Chi conosce almeno un poco la storia del Centro “Pannunzio” di Torino, fondato nel 1968 da Arrigo Olivetti, Mario Soldati, Pier Franco Quaglieni ed altri, ricorda il lungo periodo della presidenza Soldati. Jean GILI, massimo studioso francese del cinema italiano, ha scritto un libro per mettere la lente d’ingrandimento su un aspetto specifico del lavoro creativo del grande scrittore torinese: “Mario Soldati, cinéaste malgré lui” (Rouge Profond, 2022). Il libro ricostruisce minuziosamente i contatti crescenti di Soldati con il mondo del cinema, a partire da quando negli anni ‘30 era di ritorno in Italia dagli Stati Uniti.
Speciale MARTEDÌ in CAMERA
15 novembre 2022 I Ore 18.30 I Gymnasium di CAMERA
Con ‘Advocacy’, termine difficile da tradurre in italiano, si intende un atteggiamento di supporto e promozione nei confronti di politiche in grado di modificare gli assetti sociali, economici o legislativi di un determinato territorio. È la parola scelta dalla fotografa Aïda Muluneh, ospite a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia per un incontro pubblico in programmamartedì 15 novembre alle ore 18.30, per descrivere il proprio lavoro, considerando l’arte e la fotografia come strumenti attivi di cambiamento.
Attraverso immagini dai colori accesi e brillanti, l’artista di origini etiopi residente dal 1985 in Canada combatte gli stereotipi attraverso i quali, solitamente, viene ritratta l’Africa, senza rinunciare a trattare i temi tipici della fotografia documentaria, attraverso una poetica dal forte impegno sociale.
Ho trovato un nuovo linguaggio visivo – commenta Aïda Muluneh – che mi ha dato la libertà di approfondire vari argomenti che non potevo esprimere attraverso il fotogiornalismo. Sto parlando dell’impatto della falsa rappresentazione a cui ha contribuito la fotografia, di come viene visto il mio continente, l’Africa, e di come le persone di colore siano state spesso emarginate dallo sguardo straniero.
Al centro dell’incontro a CAMERA ci sono progetti come Water Life (2018), Road to Glory (2020), Crimson Echo (2022), nei quali, all’interno di paesaggi scarni, i soggetti ritratti mettono in scena gesti e posture teatrali esaltati da una reinterpretazione delle pratiche di body painting e degli abiti tradizionali.
È così che elementi reali e ricostruiti si mescolano in immagini che pongono l’accento su temi di pregnante attualità come la scarsità dell’acqua, la diffusione di malattie tropicali che colpiscono intere comunità o, come nel caso di Road to Glory, realizzato su commissione del Premio Nobel per la Pace 2020, assegnato al World Food Programme, su momenti del passato in cui tragedie e sofferenze hanno colpito alcuni paesi cambiandone inevitabilmente la storia.
In quest’occasione Aïda presenterà anche alcuni dei progetti di valorizzazione del linguaggio fotografico in Africa, come l’Addis Foto Fest, da lei fondato nel 2010, e l’Africa Foto Fair, piattaforma virtuale nata con lo scopo di promuovere la cultura fotografica nel continente, creando ponti fra luoghi e persone.
Intervengono:
Aïda Muluneh, fotografa
Walter Guadagnini, direttore di CAMERA
Per prenotazioni, www.camera.to
Il singolo incontro ha un costo di 3 Euro.
Biografia
Nata in Etiopia nel 1974, Aïda ha lasciato il Paese in giovane età. Ha trascorso la sua infanzia tra Yemen e Cipro e si è stabilita in Canada nel 1985, dove ha iniziato a sperimentare con la fotografia durante gli anni del liceo. Dopo essersi laureata alla Howard University di Washington DC nel 2000, con una specializzazione in cinema, Aida è diventata una fotoreporter del Washington Post. Negli anni successivi ha investito il suo tempo lavorando a numerosi progetti ed esplorando diversi generi fotografici. Nel 2004, una parte del suo lavoro è stata acquistata dalla collezione permanente del National Museum of African Art dello Smithsonian Institute.
 Rubrica settimanale a cura di Laura Goria
Rubrica settimanale a cura di Laura Goria
Elizabeth Cleghorn Gaskell, nasce il 29 settembre 1810 a Londra e muore ad Alton il 12 novembre 1865. Figlia di un pastore unitariano e nipote del ceramista Wedgwood, quando ha appena un anno di vita perde la madre e quando ne ha 4 viene adottata da una zia materna. Cresce nella famiglia Holland in una tranquilla cittadina del Cheshire, a Knutsford, in piena campagna.
La sua è un’educazione liberale e all’insegna della tolleranza religiosa; negli anni della crescita legge moltissimo e viene abituata a formarsi una personale opinione autonoma su svariati argomenti.
Nel 1832 sposa il pastore William Gaskell, e lo aiuterà anche nell’insegnamento serale ai bimbi delle famiglie operaie. Nel 1844 muore il suo unico figlio maschio, dolore che faticò a metabolizzare; un aiuto le venne proprio dalla scrittura.
Il suo primo romanzo fu “Mary Barton” pubblicato anonimo nel 1848, nel quale metteva a nudo la cruda realtà dell’ambiente operaio di Manchester; suscitò reazioni estreme, come la messa al bando del libro che però, proprio per questo clamore, venne notato dal pubblico. Scrisse poi altri romanzi e racconti che riscossero successo; con i guadagni acquistò un cottage a Dalton nell’ Hampshire, dove si spense ad appena 55 anni, lasciando incompiuto il suo ultimo romanzo.
“Vita di Charlotte Brontë” -Neri Pozza- euro 25,00
 Questo libro ha il pregio di riunire due grandi scrittrici che furono anche amiche, nonostante le loro esperienze di scrittura e i loro caratteri differenti.
Questo libro ha il pregio di riunire due grandi scrittrici che furono anche amiche, nonostante le loro esperienze di scrittura e i loro caratteri differenti.
La romanziera conobbe e strinse amicizia con l’altra grande autrice dell’epoca, Charlotte Brontë. Tra le due si sviluppò un fitto e interessante scambio di lettere e quando la Bronte morì, il padre chiese proprio alla Gaskell di scriverne la biografia.
In questo libro ricostruisce la vita dell’amica morta nel 1855; terza di 6 figli del pastore protestante irlandese Patrick Brontë, e di Maria Branwell.
Un atto di amicizia che ora Neri Pozza ripropone in nuova edizione. Un lavoro preciso e approfondito al quale la Gaskell si dedicò per due anni; ordinando la corrispondenza e gli appunti, visitando i luoghi dove la Bronte aveva vissuto, interrogando chi l’aveva conosciuta. Un omaggio che la Gaskell fece alla grande scrittrice, narrando anche i loro scambi e il loro rapporto di grande amicizia, ammirazione e stima reciproca.
Grazie allo studio di fonti di prima mano, la biografa ha ricostruito parecchi dettagli dell’esistenza della Brontë, nata il 21 aprile 1816. Nel 1820 la famiglia si trasferì ad Haworth, nella brughiera dello Yorkshire, in una modesta parrocchia di cui il padre era il curato, e dove l’anno successivo morì la madre sfibrata da 6 gravidanze in 7 anni, minata dal cancro.
Il lutto sarà sempre un ingombrante compagno nella vita di Charlotte; a partire proprio da quello per la morte della madre; anche se lei era ancora troppo piccola per conservarne il ricordo, le rimarrà dentro il vuoto di non avere avuto una mamma ad occuparsi di lei.
Sarà la zia materna, Elizabeth Branwell, a dedicarsi alla famiglia.
Leggiamo dell’allegria delle tre sorelline Bronte, chiaccherone e piene di fantasia, cresciute unite più che mai al cospetto del padre capace di brutale severità (come gettare nel fuoco le scarpette che temeva inducessero le sue bambine ad un’eccessiva vanità).
Poi c’è la spiacevole esperienza del collegio per figlie di ecclesiastici dove Charlotte fu costretta a stare insieme alle sorelle (di lì l’ispirazione per il Lowood in “Jane Eyre”).
Strazianti le morti premature per consunzione delle due sorelle maggiori, di appena 10 e 11 anni, vittime delle spaventose condizioni dell’istituto ( sporcizia, freddo e fame) e che mineranno per sempre la salute di Charlotte ed Emily. La loro dipartita sarà il preludio all’arrivo di una tempesta di tristezza che non lascerà più Charlotte, ma aggiungerà anche grandezza, spessore e valore ai suoi scritti.
Charlotte, nel reportage della Gaskell, è una ragazzina appassionata di disegno, politica e soprattutto di storie, che tutta la famiglia amava inventare, arricchendole di personaggi e avventure. Abilità che caratterizzò Charlotte, la quale non si accontentò della professione di istitutrice presso famiglie benestanti, ma rincorse con tenacia il sogno di scrivere.
Passione e abilità che condivise con le sorelle; nel 1847 tutte e tre pubblicarono i loro romanzi. Charlotte propose prima “Il professore” che però fu rifiutato dagli editori, mentre “Jane Eyre” –accettato e dato alle stampe con lo pseudonimo di Currer Bell- sarà subito un successo. Seguiranno “Shirley” e “Villette”.
Tra il 1848 e il 49 assisterà impotente alle morti del fratello Brandom, poi della sorella Emily ed infine di Anne. Anni pesantissimi in cui resterà sola nella canonica con il padre diventato cieco. Periodo in cui si consoliderà l’amicizia e la fitta corrispondenza con la Gaskell. Poi il matrimonio con il coadiutore della parrocchia paterna, il reverendo Nicholls, nel 1854, e la sua vita che si concluse mentre aspettava il primo figlio, nel 1855, per complicanze della gravidanza.
Alcune opere di Elizabeth Gaskell
“Mary Barton” -Elliot- euro 14,50
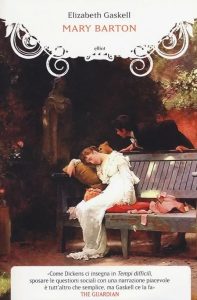 E’ il suo primo romanzo, pubblicato nel 1848 in forma anonima. E’ il crudo e realistico affresco dell’ambiente operaio di Manchester, tra 1830-40, in epoca vittoriana, attraverso le vicende di due famiglie della classe operaia.
E’ il suo primo romanzo, pubblicato nel 1848 in forma anonima. E’ il crudo e realistico affresco dell’ambiente operaio di Manchester, tra 1830-40, in epoca vittoriana, attraverso le vicende di due famiglie della classe operaia.
Da un lato John Barton che porta avanti le sue idee in merito alla distribuzione della ricchezza e le relazioni tra ricchi e poveri.
Dall’altro l’onesto Jem Wilson che cerca di aiutare in tutti i modi Mary, figlia di John. Fa la sarta ed è alle prese con la difficile sopravvivenza, orfana di madre e con un padre depresso che inizia a frequentare le organizzazioni sindacali.
Nel romanzo vengono sviluppati più punti: dall’importanza delle madri in seno alle famiglie, ai sentimenti fraintesi o non capiti, fino ad arrivare all’assassinio.
“Cranford” -Elliot- euro 13,50
Tra 1851-3 è apparso dapprima come racconto “La nostra società a Cranford” sulla rivista “Household Words”, edita da Charles Dickens che apprezzò moltissimo lo scritto e spinse la Gaskell a scrivere il seguito (diventato poi il romanzo “Cranford”).
apprezzò moltissimo lo scritto e spinse la Gaskell a scrivere il seguito (diventato poi il romanzo “Cranford”).
E’ una serie di racconti ambientati nella cittadina provinciale di Cranford, in cui sono descritte figure di donne, nobili e plebee, sposate e non; per lo più nubili che si destreggiano per conservare le apparenze borghesi sebbene dispongano di poco denaro.
Tra il rito del tè e una partita a carte si tengono compagnia, si confidano e si aiutano tra loro, al di là delle differenze di classe. Emerge il quadro ironico e lieve di un mondo femminile in cui gli uomini occupano una posizione di contorno e restano relegati sullo sfondo.
“Ruth” –Elliot- euro 22,00
 Fu pubblicato nel 1853 e all’epoca destò un certo scandalo nella società vittoriana per i temi trattati.
Fu pubblicato nel 1853 e all’epoca destò un certo scandalo nella società vittoriana per i temi trattati.
E’ la storia della giovane orfana Ruth che si mantiene facendo la sarta, e conduce una vita umile, onesta e laboriosa.
Le cose cambiano quando conosce il nobile Henry Bellingham dal quale avrà un figlio illegittimo. Finisce così per diventare una “fallen woman” ovvero una donna perduta ai margini del consesso sociale.
Il romanzo non era ancora stato tradotto in italiano e il merito di questa operazione va alla casa editrice Elliot, che ci fa conoscere un romanzo di grande impegno sociale.
“Mogli e figlie” -editore Jo March- euro 19,00
Iniziò ad essere pubblicato a puntate nel 1864 sulla rivista “Cornhill Magazine” però rimase incompiuto. Ambientato nel villaggio di Hollingford e nei salotti della buona borghesia e della nobiltà che viveva in dimore sontuose, narra le vicende di Molly Gibson.
Hollingford e nei salotti della buona borghesia e della nobiltà che viveva in dimore sontuose, narra le vicende di Molly Gibson.
Mette a confronto le vite di due giovani donne, Molly e Cynthia, dai caratteri opposti. Una sensibile e generosa, l’altra frivola ed esuberante; la vita le ha fatte incrociare con le seconde nozze tra i rispettivi genitori.
Il lettore segue soprattutto l’eroina Molly; i suoi tentativi di crescere formandosi una personalità indipendente, capace di destreggiarsi tra sentimenti, forza di volontà e rigidi schemi sociali.
Il Centro Federico Peirone, il Torino Film Festival e l’Associazione Amici di Deir Mar Musa presentano
Anteprima del Torino Film Festival, martedì 22 novembre ore 20,30, sala 3 cinema Massimo, Torino
Intervengono : il regista Shahab Kermani, Sr Friederike, monaca della comunità di Deir Mar Musa, Immacolata Dall’Oglio, sorella di padre Dall’Oglio
Dietro la storia raccontata dal Film si staglia la figura di padre Paolo Dall’Oglio, il religioso italiano , scomparso a Raqqa in Siria il 29 luglio 2013, che fondò nei primi anni Novanta la comunità di Al- Khalil , più nota col nome di Deir Mar Musa, il monastero Incastonato tra le montagne deserte del Qalamun, in Siria, da lui restaurato. Un magnifico “nido d’Aquila” sulla piana arida di Nebek. Una comunità fondata da padre Dall’Oglio nell’orizzonte particolare di vivere l’armonia islamo-cristiana.
Il film
Durante la guerra civile siriana, alcuni monaci e monache della comunità siro-cattolica di Al-Khalil in fuga dal convento Deir Mar Musa in Siria hanno trovato una nuova casa nel loro monastero “fratello” di Deir Mar Maryiam nella città di Sulaymaniyah, nel Kurdistan irakeno.
Qui hanno accolto molte famiglie in fuga dall’Isis che aveva occupato la piana di Ninive , abitata da molte famiglie cristiane. Come uno dei diversi programmi ospitati dalla comunità, i partecipanti mettono in scena un’opera teatrale sulle basi del poema “La conferenza degli uccelli” del mistico islamico Farid ud Din Attar ( XII secolo) , intrecciando le allegorie del poema con le proprie esperienze personali. È l’estate 2017. L’ISIS è in ritiro . Sono gli ultimi giorni in comunità per questo popolo di origini e credenze diverse, che condivide la vita quotidiana nel piccolo roseto. Il film ci presenta la vita quotidiana nel monastero intrecciata con la preparazione dell’opera teatrale.
Il titolo è tratto direttamente dal Corano , 27:16 , dove si dice che Sulayman ( Salomone ) e Dāwūd ( Davide ) abbiano imparato la lingua, o il linguaggio, degli uccelli ( manṭiq al-ṭayr). Nel poema, gli uccelli del mondo si riuniscono per decidere chi sarà il loro sovrano, poiché non ne hanno. L’ upupa , la più saggia di tutte, suggerisce di trovare il leggendario Simorgh . L’upupa guida gli uccelli, ognuno dei quali rappresenta una colpa umana che impedisce al genere umano di raggiungere l’illuminazione.
Prima del film viene trasmesso un videoclip dello stesso regista sulla protesta delle donne iraniane.
( il film è sottotitolato in Italiano)
Il settimo giorno lui si riposò, io no
|
Venerdì 18 novembre, ore 21 Teatro Concordia, Venaria Reale (TO) Le parole argute e ricche di humour di Enrica Tesio e le musiche eseguite dal vivo da Andrea Mirò
“Il settimo giorno lui si riposò, io no” non è soltanto uno spettacolo: è una seduta di autoaiuto, un monologo sulla vita di una donna come tante, ma con occhiaie uniche nel suo genere! Siamo tutti vittime di una stanchezza pressoché cronica. O crediamo di esserlo. Non molti anni fa perfino il Papa decise di mollare, perché troppo stanco. Nessuno di noi, invece, può dimettersi dalle proprie quotidiane stanchezze. È il punto di partenza dell’esplorazione che Enrica Tesio, blogger e autrice, compie in “Tutta la stanchezza del mondo” (Bompiani, 2022), ironico diario privato di fatiche collettive: la fatica delle madri, quella da social, la stanchezza della burocrazia, del diventare adulti, perfino la stanchezza della bellezza. Dalla pagina al palcoscenico il salto è breve, e obbligato. Perché noi siamo il popolo del multitasking che diventa “multistanching”. Siamo quelli che scorrono le pagine dei social per misurare le vite degli altri, quelli che riempiono di impegni i figli per paura di non stimolarli abbastanza, quelli che la sera si portano il computer in camera da letto per guardare una serie e intanto rispondere all’ultima mail. Quelli che, per riposarsi, si devono concentrare. A fare da contrappunto alle parole argute e piene di humour di Enrica Tesio sono le musiche eseguite dal vivo da Andrea Mirò: una selezione di musiche originali e brani di grandi autori in cui la visione slow della vita si interseca, e si contrappone, alla frenesia dei tempi moderni esprimendo una prospettiva totalmente diversa, avulsa, distante e, probabilmente, salvifica. Da Rino Gaetano a Giorgio Gaber, da Enzo Del Re a Niccolò Fabi, fino a Lucio Dalla passando attraverso i brani della stessa cantautrice astigiana: una trama fatta di sonorità raffinate e suggestioni poetiche per celebrare, in musica, un elogio alla lentezza. Il racconto, a due voci, di due donne straordinariamente talentuose per uno spaccato, attualissimo e incredibilmente ironico, del nostro tempo. |
 |
Sino a domenica 20, “David Copperfield”, nella sala di corso Brescia
Berrettino scuro in testa, maglietta azzurra e tuta blu, sulla pettorina ci sta scritto “Marcido at work”. Sette attori per un lavoro di preparazione lungo tre mesi, forse ancora in divenire, instancabile, duro, faticoso, a riempire il minuscolo palcoscenico e la sala da 50 posti di questa loro scatola teatrale che è il Marcidofilm! di corso Brescia. Il work per questa occasione ha il lungo titolo di “David Copperfield sketch comedy, un carosello dickensiano” (repliche sino a domenica 20, già gli esauriti, una immancabile lista d’attesa, una bella immagine di festa del teatro), all’origine un romanzo di crescita molto “larmoyant”, da tutti conosciuto e frequentato, dell’Inghilterra del XIX secolo, di lavoro e di trame più o meno nell’ombra, di sentimenti grandiosi e di soprusi, di affetti e di intrighi, di lotta eterna tra Bene e Male, una “giostra sentimentale” che ha tutti gli ingredienti per poter anche essere tolta dal proprio perno. Un romanzo, “anzi un romanzone”, che sta nella memoria delle pagine scritte e nello sceneggiato di Anton Giulio Majano, metà dei Sessanta, coppia giovanil/cresciuta divisa tra Chevalier e Giannini. Ovvero la domenica sera si preparavano i fazzoletti. Oggi, a distanza di sessant’anni più o meno, va messo nelle mani giuste a rivoltare il guanto di velluto come più si conviene. Oggi, quell’affondo di grottesco sembra essere quasi d’obbligo.

Un titolo che ribolliva nella mente di vulcano dell’Isi – al secolo Marco Isidori, colonna e anima instancabile della compagnia. Poi si sa, il lockdown, la pandemia con i suoi rimandi, l’impegno non indifferente, si è arrivati ad oggi, per una “riscrittura e adattamento drammaturgico”. Dell’Isi, appunto. Che con aria di sberleffo ti squinterna le pagine, che prende a smontare e rimontare con tutto il divertimento e l’ironia che gli sono possibili, e da gran tempo riconosciuti, la vicenda cardine e le tante sottovicende, dando nello stesso tempo gran spessore – e compiutezza – a quelli che vengono qui definiti sketch e che darebbero l’idea di uno svolgimento e di una vita fine a se stessi, ma che al contrario, come in una interminabile catena, si susseguono e si vitalizzano l’uno con l’altro, in maniera dinamica, schietta, vorticosa, sempre tremendamente graffiante sulla famiglia, sulla società, sull’epoca. Della parte sonora della compagnia ormai si conoscono tutti i pregi, le voci degli attori si alzano, si curvano, si flettono, si frammentano, s’allungano sempre con grande padronanza, in un concerto ben orchestrato. Quel che più colpisce nel corso della serata è il meccanismo dell’intero spettacolo, il suo perfetto amalgamarsi tra racconto e messa in scena, è lo stretto avvicendarsi di episodio su episodio, costruendo una comicità che senza freni e senza fatica prende il posto della drammaticità che conoscevamo. Tutti e sette gli attori danno vita a un carosello vivace e multiforme, entrando e uscendo non soltanto dalle situazioni ma da un personaggio per entrare in un altro – tutto incalza, tutto preme, tutto reclama esistenza e spazio -, con quei salti mortali che raramente si vedono in palcoscenico, in tempi tanto stretti da togliere il respiro.

Paolo Oricco è il protagonista ma è pure capace un istante dopo a calarsi nelle untuosità e nelle ipocrisie di Uriah Heep, grifagno, mellifluo quanto “scarafaggio immondo”, ma pure in tanto altro, Maria Luisa Abate è zie è governanti è madre di Heep con tanto di birignao che non guasta, Isidori amabilmente tromboneggia come mister Spenlow e come il perenne indebitato che è Micawber, i più giovani Valentina Battistone, Ottavia Della Porta, Alessio Arbustini e Vincenzo Quarta si dividono gli altri molti personaggi della storia. Nota non certo ultima dell’immancabile successo del lavoro comune dei Marcido Marcidoris è la scenografia per molti versi “circense” e le sagome inventate da Daniela Dal Cin, novantadue per l’esattezza, prove tratti schizzi colori facce espressioni particolari abiti a rendere appieno l’affresco creato da Dickens, visi e quant’altro posti su supporti verticali ai lati dello spazio scenico, afferrati di volta in volta secondo schemi ben precisi, in un unico vorticare, fatti entrare all’interno quasi come creature vive che reclamano tutta la loro giusta importanza. Sino al finale, dove c’è l’ultimo “divertissement” di far esplodere Aznavour con il suo “Istrione”.
Elio Rabbione
Nelle immagini dello spettacolo, Paolo Oricco; Valentina Battistone e Paolo Oricco; Valentina Battistone, Alessio Arbustini e Paolo Oricco
Nell’ edizione speciale “Salone del Libro”, il romanzo scelto per il progetto nazionale di “lettura condivisa” 2023
Più di 6mila gli studenti coinvolti in tutta Italia
Libertà giustizia e indipendenza: riparte da questi valori essenziali “Un libro tante scuole”, il progetto nazionale di “lettura condivisa” (che riunisce intorno a un grande romanzo studentesse e studenti da tutt’Italia) promosso dal “Salone Internazionale del Libro” di Torino in collaborazione con “Intesa San Paolo” ed il sostegno della “Consulta delle Fondazioni di origine bancaria” di Piemonte e Liguria, con la partecipazione di “Chora Media”. L’obiettivo è come sempre quello di “favorire attraverso la lettura il confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo, nella comunità scolastica”. Per la sua terza edizione, dopo il successo di quelle precedenti – la prima nel 2021 dedicata a “La Peste” di Albert Camus, la seconda nel 2022 a “L’isola di Arturo” di Elsa Morante – questa terza edizione vedrà pubblicare da parte del “Salone del Libro” un altro grande classico della narrativa italiana e internazionale, grazie alla collaborazione di “Giangiacomo Feltrinelli Editore”.

Da fine gennaio sui banchi di scuola approderà, infatti, “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi (Pisa, 1943 – Lisbona, 2012), in un’edizione speciale introdotta da un testo di Dacia Maraini e con una nota di Nicola Lagioia, direttore editoriale del “Salone”. Il libro, uscito nel 1994, vincitore del “Premio Campiello” e del “Premio Viareggio”, ambientato nel Portogallo alla fine degli anni Trenta, agli albori della dittatura di Salazar, è stato scelto “per i valori di libertà che trasmette e per l’accento che pone sull’importanza dell’esercizio dello spirito critico, insegnamenti sempre fondamentali, in particolar modo per i lettori che si affacciano all’età adulta”. Il protagonista, un giornalista solitario che si occupa principalmente di cultura, prende via via coscienza, grazie soprattutto al rapporto con il giovane Monteiro Rossi e la sua compagna, della deriva autoritaria imboccata dal proprio Paese e matura, poco alla volta, la decisione di compiere un gesto di eroica opposizione. Dal romanzo fu tratto l’omonimo film diretto da Roberto Faenza, con Marcello Mastroianniin una delle sue ultime interpretazioni.
“Sostiene Pereira” raggiungerà più di 6mila studentesse e studenti in Italia, che entro la fine di gennaio riceveranno il libro gratuitamente. Il volume, come i precedenti, entrerà poi a fare parte della stessa “Biblioteca del Salone”. La copertina e l’impostazione grafica, anche per questo terzo volume sono state affidate a Riccardo Falcinelli, tra i più noti art director editoriali italiani. Ad accompagnare la lettura del romanzo, sarà, anche questa volta, un “podcast” in sei puntate, dal titolo “Il Salone presenta Antonio Tabucchi”, prodotto in collaborazione con “Chora Media” e scaricabile su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite a partire da febbraio 2023 e che vedrà diverse voci della narrativa contemporanea alternarsi per raccontare le tante sfumature della poetica dello scrittore pisano, le diverse questioni aperte dalla lettura di “Sostiene Pereira”, fornendo una propria specifica chiave di approccio all’opera: da Andrea Bajani a Paolo di Paolo, fino a Dacia Maraini, Romana Petri, Fabio Stassi e Chiara Valerio.
Tra febbraio e aprile 2023 alcune autrici e autori che intervengono nel “podcast” incontreranno dal vivo studentesse e studenti delle scuole nelle diverse sedi delle “Gallerie d’Italia”, i musei di “Intesa San Paolo” a Milano, Napoli, Torino e Vicenza. A Torino interverrà lo scrittore romano Paolo di Paolo.
 Il momento conclusivo del grande percorso di lettura di “Sostiene Pereira”sarà sabato 20 maggio 2023, alla “XXXV Edizione del Salone del Libro”, con un appuntamento corale aperto a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, in cui saranno chiamati a parlare ospiti da sempre legati alle opere di Antonio Tabucchi.
Il momento conclusivo del grande percorso di lettura di “Sostiene Pereira”sarà sabato 20 maggio 2023, alla “XXXV Edizione del Salone del Libro”, con un appuntamento corale aperto a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, in cui saranno chiamati a parlare ospiti da sempre legati alle opere di Antonio Tabucchi.
“ ‘Sostiene Pereira’ – dichiara Nicola Lagioia –è ormai un classico, raro esempio di romanzo italiano contemporaneo celebrato in tutto il mondo. Per le studentesse e gli studenti che avranno l’opportunità di leggerlo rappresenta, insieme, un inno alla libertà e una grande lezione di letteratura civile”.
Per aderire a “Un libro tante scuole”, le scuole devono candidarsi sulla piattaforma SalTo+ (https://saltopiu.salonelibro.it/), entro il31 dicembre 2022.
Info: www.salonelibro.it
g.m.
Nelle foto
– Antonio Tabucchi. galeria
– Cover “Sostiene Pereira”
– Dacia Maraini da FlickrSaloneLibro
Lunedì 14 novembre ore 17.30
via Ottavio Revel 15 – Torino
CENTRO STUDI PIEMONTESI
Presentazione del volume
La diplomazia del disincanto
Costantino Nigra e l’Italia
sul finire dell’Ottocento
di
Andrea Pennini
Torino, Centro Studi Piemontesi, 2022
Con l’autore intervengono
Pierangelo Gentile e Michele Rosboch
Info e prenotazioni: tel. 011/537486 – info@studipiemontesi.it.
La conferenza potrà essere seguita in differita sul Canale YouTube del Centro Studi Piemontesi
Torino e i suoi musei
Con questa serie di articoli voglio prendere in esame alcuni musei torinesi, approfondirne le caratteristiche e “viverne” i contenuti attraverso le testimonianze culturali di cui essi stessi sono portatori. Quello che desidero proporre sono delle passeggiate museali attraverso le sale dei “luoghi delle Muse”, dove l’arte e la storia si raccontano al pubblico attraverso un rapporto diretto con il visitatore, il quale può a sua volta stare al gioco e perdersi in un’atmosfera di conoscenza e di piacere
1 Museo Egizio
2 Palazzo Reale-Galleria Sabauda
3 Palazzo Madama
4 Storia di Torino-Museo Antichità
5 Museo del Cinema (Mole Antonelliana)
6 GAM (Galleria d’Arte Moderna)
7 Castello di Rivoli
8 MAO (Museo d’Arte Orientale)
9 Museo Lombroso- Antropologia Criminale
10 Museo della Juventus
2 Galleria Sabauda
 È qualche anno che abito fuori Torino e l’andare in centro non rientra più tra quelle che posso definire “abitudini”. Il lato positivo è che, quando ci vado, apprezzo maggiormente lo spettacolo che la città mi offre: la folla che si muove disordinata, qualcuno, più frettoloso degli altri, che attraversa correndo la strada anche se c’è il semaforo rosso, i tram che partono scampanellando sui binari, il sali-scendi delle persone dai pullman, qualche cestino troppo pieno e i portici che rimbombano del brusio dei passanti. Piazza Castello è una delle piazze principali dell’antica Augusta Taurinorum, è di forma quadrata e su di essa si affacciano Palazzo Madama e Palazzo Reale, mentre il profilato perimetro è delineato da portici eleganti ed importanti edifici, quali l’Armeria Reale, il Teatro Regio, il Palazzo della Regione Piemonte, la Galleria Subalpina, la Torre Littoria e la piccola Chiesa di San Lorenzo, che si erge all’angolo con via Palazzo di Città, mentre l’affollata via Garibaldi sfocia nella stessa piazza come un fiume nel mare. Poco più oltre s’innesta la Piazzetta Reale, costeggiata da Palazzo Chiablese, dove si trova l’ingresso per i Musei Reali e si accede al passaggio pedonale che porta a Piazzetta San Giovanni. Quando inizia a fare bel tempo si accendono le fontane, ricordo che quando finiva la scuola, noi studenti del Liceo Classico “Gioberti”, come molti altri ragazzi degli istituti vicini, andavamo a buttarci sotto l’acqua fredda per festeggiare l’arrivo dell’estate.
È qualche anno che abito fuori Torino e l’andare in centro non rientra più tra quelle che posso definire “abitudini”. Il lato positivo è che, quando ci vado, apprezzo maggiormente lo spettacolo che la città mi offre: la folla che si muove disordinata, qualcuno, più frettoloso degli altri, che attraversa correndo la strada anche se c’è il semaforo rosso, i tram che partono scampanellando sui binari, il sali-scendi delle persone dai pullman, qualche cestino troppo pieno e i portici che rimbombano del brusio dei passanti. Piazza Castello è una delle piazze principali dell’antica Augusta Taurinorum, è di forma quadrata e su di essa si affacciano Palazzo Madama e Palazzo Reale, mentre il profilato perimetro è delineato da portici eleganti ed importanti edifici, quali l’Armeria Reale, il Teatro Regio, il Palazzo della Regione Piemonte, la Galleria Subalpina, la Torre Littoria e la piccola Chiesa di San Lorenzo, che si erge all’angolo con via Palazzo di Città, mentre l’affollata via Garibaldi sfocia nella stessa piazza come un fiume nel mare. Poco più oltre s’innesta la Piazzetta Reale, costeggiata da Palazzo Chiablese, dove si trova l’ingresso per i Musei Reali e si accede al passaggio pedonale che porta a Piazzetta San Giovanni. Quando inizia a fare bel tempo si accendono le fontane, ricordo che quando finiva la scuola, noi studenti del Liceo Classico “Gioberti”, come molti altri ragazzi degli istituti vicini, andavamo a buttarci sotto l’acqua fredda per festeggiare l’arrivo dell’estate.
Vivere in un qualche luogo significa arricchirlo di ricordi, ma alcuni luoghi più di altri si legano ai vissuti e credo che per me piazza Castello sia proprio uno di quelli: punto di ritrovo “davanti al chiosco di giornali di via Garibaldi” o alla “focacceria”, i festeggiamenti bagnati – e leggermente maleodoranti- alla fine del ginnasio e tanti altri piccoli momenti che riaffiorano tutte le volte che passo di lì. Ma non è per raccontarvi della mia adolescenza che vi ho condotto qui, ma per proporvi di entrare a dare un’occhiata ad una delle varie collezioni che sono conservate all’interno del Palazzo. Nel regale complesso si trova la Galleria Sabauda, una delle raccolte pittoriche più importanti d’Italia, con alla spalle oltre 180 anni di storia. Le opere, oltre 700 dipinti che spaziano dal XIII al XX secolo, sono esposte dal 2014 nella Manica Nuova di Palazzo Reale, all’interno del complesso del Musei Reali di Torino.
Fra i contenuti di maggior interesse spicca una raccolta particolarmente importante di autori rinascimentali piemontesi, fra cui Giovanni Martino Spanzotti, Gaudenzio Ferrari e Defendente Ferrari, un vasto assortimento di opere prodotte dai maggiori nomi della pittura italiana, come Beato Angelico, Duccio di Boninsegna, Piero del Pollaiolo, Andrea Mantegna, Filippino Lippi, Il Veronese, Tintoretto, Guercino, Orazio Gentileschi, Giambattista Tiepolo e uno dei migliori nuclei italiani di dipinti della Scuola Fiamminga, con nomi quali Van Dyck, Rubens, Rembrandt, i Brueghel, Memling e Van Eyck.
La storia della collezione della Pinacoteca è lunga e complessa, inizia il 2 ottobre 1832, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione della collezione di Carlo Alberto, con cui si sancisce che le opere vengano messe a disposizione della comunità e «aperte al pubblico». Allora però la raccolta era esposta a Palazzo Reale, dove rimase fino alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento, quando venne spostata a Palazzo Carignano. Negli anni Ottanta dell’Ottocento le opere erano 550, disposte tra le varie sale dell’edificio, divise per autori (piemontesi ed italiani), grandi formati, nature morte, ceramiche e fiamminghi. Alessandro Bandi di Verme ampliò la galleria di 5 sale e ordinò che i quadri fossero disposti secondo una concezione logica ed estetica.
Negli anni Trenta del Novecento la raccolta prende il nome “Galleria Sabauda”, ma si impoverisce poiché Mussolini cede svariate opere ai musei londinesi. Durante il periodo bellico l’esposizione chiude al pubblico per molto tempo; negli anni Cinquanta la Galleria viene inserita nel piano di rinnovamento dei grandi musei nazionali che necessitano provvedimenti e finalmente, il 24 maggio 1959, la Galleria riapre ufficialmente. Oltrepasso la cancellata, eseguita nel 1840 da Pelagio Palagi a scopo di delimitare la Piazzetta Reale dalla pubblica Piazza Castello, alzo lo sguardo verso le faccione dorate dell’orrorifica Medusa e mi avvio alla biglietteria.
Una volta entrata mi trovo di fronte al lungo corridoio e qui da una parte si affacciano le numerose stanze e dall’altra spiccano le statue romane. A questo punto non mi resta che cercare i numeri delle sale e iniziare il percorso. Le opere esposte sono moltissime, tutte meravigliose, ma alcune incontrano particolarmente i miei gusti, come il dipinto del fiammingo Hans Memling, “Scene della passione di Cristo” (1470). Si tratta di una tela di modeste dimensioni, emblematica di uno degli stili pittorici che più mi piacciono, quello fiammingo. Con “arte fiamminga” si è soliti indicare la produzione artistica del XV-XVI secolo, portata avanti nei Paesi Bassi, caratterizzata da un approccio sensoriale ed analitico della realtà fenomenica delle cose, che si traduce in pittura in una minuziosa descrizione dei più piccoli dettagli, resi in maniera sorprendentemente realistica. A questa tipologia di opera sarebbe il caso di avvicinarsi con una lente d’ingrandimento, alla ricerca di personaggi nascosti, come, in questo caso, il bambino che assiste affacciato alla finestra al crudele destino di Gesù. Mi avvicino alla tela che va letta dall’ alto a sinistra a scendere, percorrendo con lo sguardo le strette vie raffigurate con dovizia di particolari, affollate di personaggi usciti da un presepe nordico, ognuno con caratteristiche proprie. Mi perdo in uno spazio urbano che sembra rifuggire i principi della prospettiva e della verosimiglianza, l’autore ha inserito più di venti scene della Passione di Cristo, così come sono ricordate dai Vangeli. In primo piano, ai lati, vi sono rappresentati i committenti, Tommaso e Maria Portinari, due facoltosi banchieri fiorentini.
All’interno della Galleria vi sono altri quadri fiamminghi, tutti, a mio personalissimo avviso, da osservare avvicinandosi il più possibile, con sguardo indagatore, come si volesse giocare a fare i “detective”. Incontro varie nature morte, composizioni di fiori pomposi, bicchieri e vetri lucenti e piccoli insetti che si inseriscono nel componimento con “nonchalance”; mi imbatto in grandi maestri quali Anton van Dyck, (Principe di Savoia Tommaso Carignano, 1634), Van Weyden e un minuscolo ma non meno affascinate Rembrandt Harmenzoon van Rijn. Non riesco a non fermarmi davanti alla piccola opera, sembra una fotografia scattata al buio, gli occhi si devono abituare all’oscurità che si sta osservando e finalmente percepiscono i dettagli che emergono dall’ombra: una brace ormai spenta illumina una brocca, un attizzatoio e delle aringhe messe a essiccare. La fioca luce, vera protagonista del componimento, si posa anche sul volto dormiente e sulle dita intrecciate dell’anziano signore, vestito di nero e seduto abbandonato su una sedia. La virtuosistica tela quasi monocroma è databile al 1629, il suo significato rimane incompreso, alcuni pensano si tratti di un filosofo o Tobia dormiente, oppure ancora l’allegoria dell’accidia o il ritratto del padre del pittore prossimo alla morte.
Guardo un’ultima volta la piccola composizione, per avere la certezza di non essermi persa nessun dettaglio, poi mi allontano piano, come non volessi svegliare l’assopito vecchio stanco.
Mi aggiro per la pinacoteca continuamente osservata da tutti quei personaggi dipinti, ogni tela cela una storia al suo interno, come nel caso dell’opera di Bartolomeo Passerotti, “Perseo e Andromeda”, nella quale l’autore raffigura l’eroe di ritorno dall’impresa dell’uccisione della mostruosa Gorgone, nel momento in cui si imbatte nella candida fanciulla ancorata allo scoglio, lì imprigionata a causa della spregiudicatezza della madre. Quasi non me ne accorgo, ma sto inconsciamente giocando a riconoscere miti e personaggi studiati sui libri di scuola durante le ore di letteratura, riconosco l’episodio di Ercole che affida Deainira al Centauro Nesso, rappresentato da Pecheux, Apollo e Dafne e Pan e Siringa nelle opere di Filippo Lauri, ancora mi soffermo davanti a Lucrezia, magistralmente rappresentata da Guido Reni nell’atto estremo del suicidio, ma poi anche la tragica vicenda di Diana e Callisto nella tela di Cambiano e infine mi attardo un po’ di fronte all’opera di Galliari, che raffigura un mito che molto concerne Torino, “La caduta di Fetonte”.
 Forse non si sa, o quantomeno non si dice abbastanza, ma nel capoluogo piemontese, proprio nella Galleria Sabauda, sono conservati grandi nomi della storia dell’arte, quali Botticelli, di cui è visibile la così detta “Venere Gualino”, dal nome del suo acquirente, Riccardo Gualino, che la comprò nel 1920 per poi cederla dieci anni dopo alla Galleria. Davanti al quadro è impossibile non pensare alla ben più nota Venere degli Uffizi. L’opera venne probabilmente realizzata nel momento di massima attività della bottega del maestro fiorentino. La fanciulla si presenta nuda al visitatore, leggera e pallida, alle sue spalle una nicchia dal fondo scuro; poggia i piedi su un gradino di marmo chiaro, che le vicende conservative del dipinto hanno reso leggermente sghembo. Cerca, con pudore, di coprirsi con le mani e con i lunghi capelli biondi ramati. Oggi si tende a vedere nella “Venere Gualino” un’opera indipendente, anche tenendo conto di una menzione di Giorgio Vasari, che ricorda come in varie case fiorentine si trovassero raffigurazioni simili, prodotte nella bottega di Botticelli: una scultura della tipologia della “Venus Pudica” dovette essere il modello in comune tra queste opere e la tela degli Uffizi. Altri nomi in cui ci si imbatte con timoroso rispetto sono Filippino Lippi, Andrea Mantegna, Beato Angelico, Veronese, Tiepolo, Orazio Gentileschi, Vanvitelli, Canaletto e altri, autori che ha più senso vi inviti ad andare a visionare piuttosto che elencarli freddamente.
Forse non si sa, o quantomeno non si dice abbastanza, ma nel capoluogo piemontese, proprio nella Galleria Sabauda, sono conservati grandi nomi della storia dell’arte, quali Botticelli, di cui è visibile la così detta “Venere Gualino”, dal nome del suo acquirente, Riccardo Gualino, che la comprò nel 1920 per poi cederla dieci anni dopo alla Galleria. Davanti al quadro è impossibile non pensare alla ben più nota Venere degli Uffizi. L’opera venne probabilmente realizzata nel momento di massima attività della bottega del maestro fiorentino. La fanciulla si presenta nuda al visitatore, leggera e pallida, alle sue spalle una nicchia dal fondo scuro; poggia i piedi su un gradino di marmo chiaro, che le vicende conservative del dipinto hanno reso leggermente sghembo. Cerca, con pudore, di coprirsi con le mani e con i lunghi capelli biondi ramati. Oggi si tende a vedere nella “Venere Gualino” un’opera indipendente, anche tenendo conto di una menzione di Giorgio Vasari, che ricorda come in varie case fiorentine si trovassero raffigurazioni simili, prodotte nella bottega di Botticelli: una scultura della tipologia della “Venus Pudica” dovette essere il modello in comune tra queste opere e la tela degli Uffizi. Altri nomi in cui ci si imbatte con timoroso rispetto sono Filippino Lippi, Andrea Mantegna, Beato Angelico, Veronese, Tiepolo, Orazio Gentileschi, Vanvitelli, Canaletto e altri, autori che ha più senso vi inviti ad andare a visionare piuttosto che elencarli freddamente.
Prima di uscire “a riveder le stelle” vorrei soffermarmi ancora su un’opera e su un autore che amo particolarmente: “Ercole nel giardino delle Esperidi” di Pieter Paul Rubens, (Siegen, 1577-Anversa, 1640). L’opera si trova nella sala 29, dove sono esposti altri capolavori del genio barocco per eccellenza. Nelle sue opere prevale la complessità, la policentricità, l’intrecciarsi di motivi e linee di forza, la pienezza rigogliosa delle forme, lo splendore e la vivacità dei colori, il virtuosismo tecnico che gli permette di giungere ad una definizione dell’opera molto finita e preziosa. In questo specifico quadro è rappresentato un Ercole forzuto e massiccio, fatto di carne e di muscoli, secondo i canoni di Rubens, mentre sta per cogliere i pomi d’oro nel mitico giardino delle Esperidi. È l’undicesima fatica che l’eroe greco deve affrontare e che riesce a superare grazie al consiglio di Prometeo, che gli suggerisce di farsi aiutare da Atlante.
Alcuni di voi si ricorderanno la divertente rivisitazione Disney in cui il protagonista viene appellato “scemercole”, bene, forse è vero che l’intelligenza è caratteristica più di Odisseo che di Ercole, ma in questo episodio l’eroe dimostra di sapersela cavare. Quando Ercole si reca da Atlante, quest’ultimo accetta di aiutarlo, ma per poterlo fare è necessario che il forzuto greco regga un po’ il Mondo al posto suo; Ercole acconsente e a quel punto Atlante, sgranchendosi la schiena, fa per andarsene e abbandonare l’eroe a quel compito infausto. Spaventato dal quel mesto destino Ercole aguzza l’ingegno: “Fammi aggiustare la veste prima di andartene,” dice Ercole ad Atlante mentre gli ripassa quel Mondo così pesante, e l’altro ci casca in pieno.
Dall’arte c’è sempre qualcosa da imparare.
Alessia Cagnotto