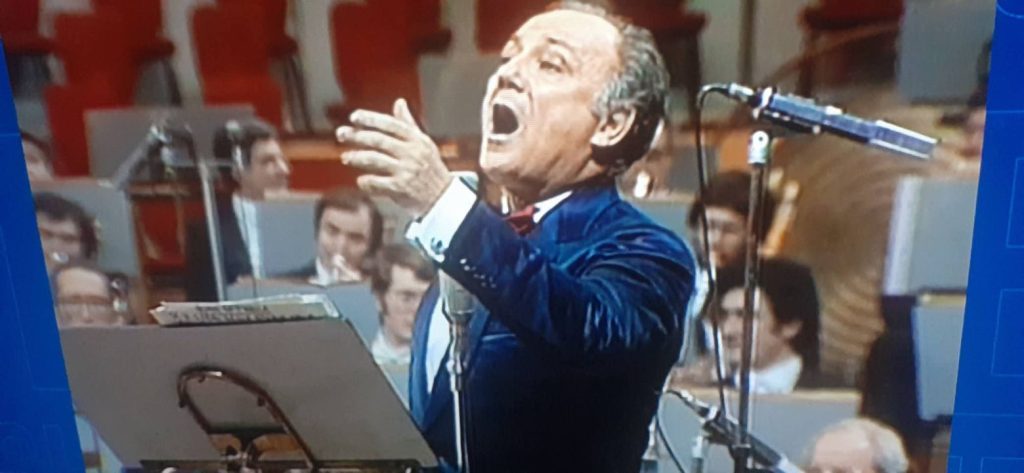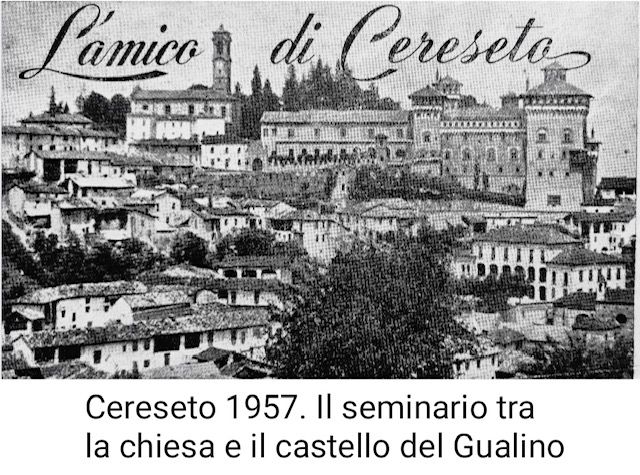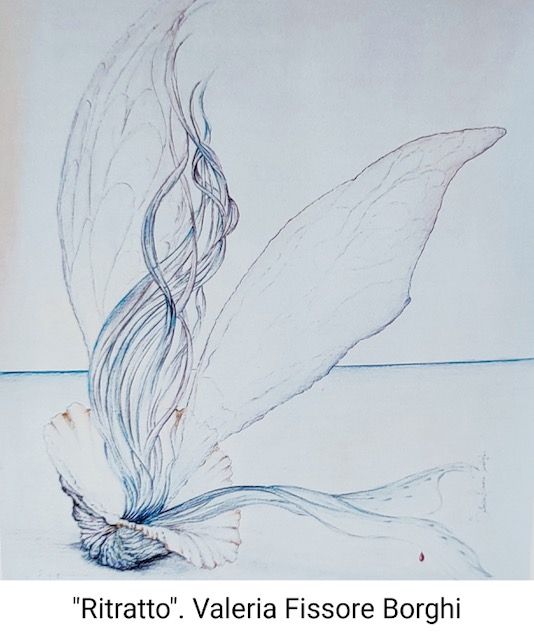SCOPRI – TO ALLA SCOPERTA DI TORINO
C’è stato un tempo in cui, prima di Roma e molto prima di Cinecittà, il cuore del cinema italiano batteva a Torino. Una città elegante, industriale, riservata, che oggi associamo più facilmente all’automobile, ai viali alberati e ai caffè storici, ma che a inizio Novecento fu uno dei luoghi più vivi e innovativi del cinema europeo. Capire perché Torino sia stata la prima capitale del cinema italiano significa tornare a un’epoca di sperimentazione, entusiasmo e ambizione, quando il cinema non era ancora un’industria consolidata ma una scoperta, quasi una scommessa.
Alla fine dell’Ottocento Torino era una città perfettamente pronta ad accogliere il nuovo linguaggio cinematografico. Era una capitale da poco perduta, ma non aveva perso la sua centralità culturale e tecnologica. Aveva infrastrutture moderne, una borghesia colta e curiosa, una forte tradizione fotografica e scientifica. Quando il cinematografo fece la sua comparsa in Europa, qui trovò un terreno fertile. Le prime proiezioni entusiasmarono il pubblico e, nel giro di pochi anni, dalla semplice visione si passò alla produzione vera e propria.
Non è un caso che le prime case di produzione italiane siano nate proprio a Torino. In una città abituata a pensare in grande e a investire nel futuro, il cinema venne subito percepito non come un passatempo, ma come un’arte e un’industria. Studi di posa, laboratori, troupe stabili: tutto cominciò a prendere forma con sorprendente rapidità. Torino iniziò così a raccontare storie per immagini, anticipando linguaggi e soluzioni narrative che avrebbero fatto scuola.
La nascita di un’industria cinematografica
Nei primi anni del Novecento Torino diventò un vero e proprio laboratorio cinematografico. Qui nacquero produzioni ambiziose, kolossal ante litteram, film storici e mitologici che richiamavano l’antica Roma, la Grecia classica, le grandi epopee. Una delle case di produzione più importanti fu Itala Film che portò il cinema italiano su un livello internazionale. Con mezzi tecnici avanzati e una visione moderna del racconto filmico, gli studi torinesi iniziarono a competere con le grandi produzioni francesi e americane.
Il cinema torinese non era improvvisato. Era frutto di una progettualità precisa, di una città che sapeva unire rigore industriale e gusto estetico. Registi, tecnici e attori lavoravano in modo continuativo, sperimentando nuove soluzioni visive, movimenti di macchina, scenografie monumentali. Torino diventò una fabbrica di immagini, ma anche un luogo di pensiero, dove si rifletteva sul linguaggio cinematografico quando altrove si era ancora legati alla semplice ripresa teatrale.
In questo contesto emerse la figura di Giovanni Pastrone, uno dei grandi pionieri del cinema mondiale. Con lui, il cinema italiano fece un salto decisivo in avanti, dimostrando che anche in Italia si potevano realizzare opere spettacolari, complesse e capaci di dialogare con il pubblico internazionale.
Cabiria e il sogno di Torino capitale del cinema
Il simbolo assoluto di quell’epoca d’oro è Cabiria, un film che segnò un punto di svolta non solo per il cinema italiano, ma per la storia del cinema tout court. Girato in gran parte a Torino, fu un’opera colossale per durata, ambizione e innovazione tecnica. I suoi movimenti di macchina, le scenografie imponenti e la struttura narrativa influenzarono registi di tutto il mondo, compresi alcuni futuri giganti di Hollywood.
Con Cabiria, Torino dimostrò di poter essere non solo la culla, ma anche il vertice del cinema italiano. Per qualche anno sembrò davvero possibile che la città piemontese diventasse stabilmente il centro dell’industria cinematografica nazionale. Le sale erano numerose, il pubblico rispondeva con entusiasmo e le produzioni torinesi circolavano all’estero con successo.
Eppure, questo primato durò poco. Le ragioni furono molteplici: cambiamenti economici, la Prima guerra mondiale, lo spostamento progressivo delle produzioni verso Roma, dove il clima, gli spazi e le scelte politiche favorirono la nascita di un nuovo polo cinematografico. Torino, fedele al suo carattere, non fece rumore. Continuò a produrre cultura, ma lasciò che il centro del cinema italiano si spostasse altrove.
L’eredità cinematografica di Torino oggi
Anche se non è più una capitale produttiva come lo è stata agli inizi del Novecento, Torino non ha mai smesso di essere una città di cinema. La sua eredità è viva nei festival, nei musei, nelle scuole di cinema e in un rapporto con l’immagine che resta profondo e consapevole. Il cinema, qui, non è solo intrattenimento: è memoria, ricerca, racconto del reale.
Camminando per Torino si percepisce ancora quel legame originario. Nei suoi palazzi austeri, nei cortili, nelle piazze ordinate, c’è una naturale predisposizione alla messa in scena. Non stupisce che tanti registi contemporanei continuino a sceglierla come set, attratti da una città che non si impone ma si lascia scoprire, proprio come il cinema delle origini.
Essere stata la prima capitale del cinema italiano non è per Torino un titolo da esibire, ma una storia da custodire. Una storia fatta di intuizioni, di rischio, di visione. E forse è proprio questo che rende il suo rapporto con il cinema così autentico: Torino non ha mai cercato di essere protagonista a tutti i costi. Lo è stata quando serviva, e ha saputo farsi da parte senza dimenticare ciò che aveva costruito.
.
NOEMI GARIANO