Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 al 31 agosto torna il PDFF, Piemonte Documenteur Film Fest, una manifestazione pronta a dare il ciak ai nuovi aspiranti registi provenienti da tutta Italia per girare le loro storie nella splendida cornice delle Langhe.
Si tratta del primo festival europeo sul genere del falso documentario, nato nel 2009 da un’idea di Carlotta Givo e realizzato grazie al contributo dei cinque Comuni ospitanti (Monforte d’Alba, Murazzano, Novello, Roddino e Treiso), oltre a quello di RECTV Produzioni srl, della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e co- finanziato attraverso il portale di crowdfunding eppela e Banca Azzoaglio e patrocinio della Regione Piemonte.
“Abbiamo messo a disposizione dei partecipanti uno sceneggiatore e uno scrittore, Pino Pace – spiega la direttrice Ilaria Chiesa – e ci piaceva l’idea di aiutare chi non avesse mai partecipato al PDFF per evitare di uscire troppo dal genere del falso documentario, e per questo abbiamo scelto un ex vincitore come supporto”.
A giudicare l’operato degli aspiranti filmmakers sarà una giuria composta da Sergio Troiano (Cinema Ambrosio), Fabrizio Dividi ( Corriere della Sera, Torino), Daniela Scavino ( La Stampa, Cuneo) , Elena Ciofalo ( Centro Nazionale del Corto) e Lucilla Riggio ( ShortsFit Distribucion).
Mara Martellotta




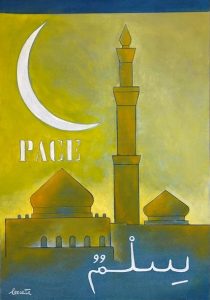



 Se lo ius soli mi ha sempre trovato nettamente contrario anche per le motivazioni politiche dei suoi sostenitori, lo ius scholae voluto da Tajani suscita perplessità per l’uso strumentale che ne vuole fare, creando un problema al suo Governo e godendosi gli elogi sospetti dell’opposizione. E’ cosa vecchia sostenuta anche da Fini che ritorna a parlarne mentre uno come lui dovrebbe stare in silenzio. Per 15 anni l’argomento è rimasto in salamoia perché rischiava di far saltare il Governo Gentiloni e il Governo Draghi. Anche a sinistra al momento del voto erano freddi perché capivano che quelle posizioni “facevano perdere dei voti” nelle barriere dominate da immigrati. Da 15 anni e ‘ rimasto tutto fermo : essi dimostrano la nessuna urgenza del problema, avanzato tra i primi dal ministro Andrea Riccardi, della Comunità di Sant’ Egidio, ma anche presidente della “Dante Alighieri”, che ha tutt’altra storia. È un problema catto – comunista estraneo alla cultura liberale che Tajani dice di rappresentare. Lo storico Federico Chabod, che scrisse pagine magistrali sull’identità nazionale, rifiuterebbe ambedue questi finti ius. Il primo problema italiano è la perdita di cittadini italiani che va affrontata con una forte politica di sostegno alle famiglie. Se guardiamo gli immensi problemi della Francia, dobbiamo essere cauti nel favorire immigrati che possono rivoltarsi contro perché l’integrazione è volontaristica, come diceva Chabod, e può cambiare dopo la cittadinanza che implica anche il voto. Perché il problema è anche quello di avere un alto numero di stranieri votanti che possono determinare la politica italiana. Possibile che Tajani non capisca? Passi per il fatto che non sappia nulla di cosa scrisse Chabod. Politici colti oggi quasi non ne esistono più.
Se lo ius soli mi ha sempre trovato nettamente contrario anche per le motivazioni politiche dei suoi sostenitori, lo ius scholae voluto da Tajani suscita perplessità per l’uso strumentale che ne vuole fare, creando un problema al suo Governo e godendosi gli elogi sospetti dell’opposizione. E’ cosa vecchia sostenuta anche da Fini che ritorna a parlarne mentre uno come lui dovrebbe stare in silenzio. Per 15 anni l’argomento è rimasto in salamoia perché rischiava di far saltare il Governo Gentiloni e il Governo Draghi. Anche a sinistra al momento del voto erano freddi perché capivano che quelle posizioni “facevano perdere dei voti” nelle barriere dominate da immigrati. Da 15 anni e ‘ rimasto tutto fermo : essi dimostrano la nessuna urgenza del problema, avanzato tra i primi dal ministro Andrea Riccardi, della Comunità di Sant’ Egidio, ma anche presidente della “Dante Alighieri”, che ha tutt’altra storia. È un problema catto – comunista estraneo alla cultura liberale che Tajani dice di rappresentare. Lo storico Federico Chabod, che scrisse pagine magistrali sull’identità nazionale, rifiuterebbe ambedue questi finti ius. Il primo problema italiano è la perdita di cittadini italiani che va affrontata con una forte politica di sostegno alle famiglie. Se guardiamo gli immensi problemi della Francia, dobbiamo essere cauti nel favorire immigrati che possono rivoltarsi contro perché l’integrazione è volontaristica, come diceva Chabod, e può cambiare dopo la cittadinanza che implica anche il voto. Perché il problema è anche quello di avere un alto numero di stranieri votanti che possono determinare la politica italiana. Possibile che Tajani non capisca? Passi per il fatto che non sappia nulla di cosa scrisse Chabod. Politici colti oggi quasi non ne esistono più. Per capire l’importanza storica dell’Accademia italiana della cucina, fondata da Orio Vergani nel 1953 ,basterebbe leggere la sua Rivista “Civiltà della tavola” e gli editoriali del suo presidente Paolo Petroni, un maestro libero e competente non legato alle cordate affaristiche delle guide o delle lobby tipo quella di Carlin Petrini, un politicante che ha avuto grande notorietà giungendo perfino alla cattedra universitaria per chiara fama. Petroni nell’editoria le di luglio 2024 afferma che anche il mondo dell’alta ristorazione sta cambiando: non bastano più nuove parole o ingredienti esotici o creatività estetica. Il “fine dining” è sul viale del tramonto. L’impiattamento, cioè la disposizione di una vivanda nel piatto “tramite virgole di salsa verde, puntini rossi, stelline gialle, granelli argentati, elementi decorativi, che hanno fatto la fortuna di Gualtiero Marchesi, e’ ormai una moda in declino. “Certi aspetti della cucina cosiddetta di alto livello – scrive Petroni – stanno stancando molti appassionati frequentatori di ristoranti” perché rivelano il trucco: stupire ed aumentare i prezzi.
Per capire l’importanza storica dell’Accademia italiana della cucina, fondata da Orio Vergani nel 1953 ,basterebbe leggere la sua Rivista “Civiltà della tavola” e gli editoriali del suo presidente Paolo Petroni, un maestro libero e competente non legato alle cordate affaristiche delle guide o delle lobby tipo quella di Carlin Petrini, un politicante che ha avuto grande notorietà giungendo perfino alla cattedra universitaria per chiara fama. Petroni nell’editoria le di luglio 2024 afferma che anche il mondo dell’alta ristorazione sta cambiando: non bastano più nuove parole o ingredienti esotici o creatività estetica. Il “fine dining” è sul viale del tramonto. L’impiattamento, cioè la disposizione di una vivanda nel piatto “tramite virgole di salsa verde, puntini rossi, stelline gialle, granelli argentati, elementi decorativi, che hanno fatto la fortuna di Gualtiero Marchesi, e’ ormai una moda in declino. “Certi aspetti della cucina cosiddetta di alto livello – scrive Petroni – stanno stancando molti appassionati frequentatori di ristoranti” perché rivelano il trucco: stupire ed aumentare i prezzi. L’associazione internazionale Regina Elena si è fatta promotrice di una causa benemerita volta a proclamare la beatificazione di una donna di straordinarie virtù umane e cristiane che nel corso della sua vita si è dedicata con generosità assoluta agli altri a partire dal terremoto di Messina. Durante la Grande Guerra trasformò il Quirinale in ospedale per i feriti, agendo in prima persona. Fu la promotrice della ricerca contro il cancro e tentò anche di lanciare con altre regine europee un appello per la pace in alternativa alla devastante seconda guerra mondiale. C’è stato chi ha sbagliato a volerla far seppellire a Vicoforte per mettere se stesso in luce. Oggi il comitato appena creato, al quale ho dato subito la mia adesione, e’ la grande occasione per rilanciare la figura di Elena di Savoia regina della carità e rosa d’oro della Cristianità nella giusta dimensione, liberandola dal cono d’ombra di Vicoforte.
L’associazione internazionale Regina Elena si è fatta promotrice di una causa benemerita volta a proclamare la beatificazione di una donna di straordinarie virtù umane e cristiane che nel corso della sua vita si è dedicata con generosità assoluta agli altri a partire dal terremoto di Messina. Durante la Grande Guerra trasformò il Quirinale in ospedale per i feriti, agendo in prima persona. Fu la promotrice della ricerca contro il cancro e tentò anche di lanciare con altre regine europee un appello per la pace in alternativa alla devastante seconda guerra mondiale. C’è stato chi ha sbagliato a volerla far seppellire a Vicoforte per mettere se stesso in luce. Oggi il comitato appena creato, al quale ho dato subito la mia adesione, e’ la grande occasione per rilanciare la figura di Elena di Savoia regina della carità e rosa d’oro della Cristianità nella giusta dimensione, liberandola dal cono d’ombra di Vicoforte.
 Anch’io ho notato questa informazione insistita e ripetitiva. E’ cosa riprovevole, che crea paure sociali nelle persone e vuole insistere su una follia collettiva e una criminalità destinata ad allarmare. Certo essa non manifesta una capacità di indagine rapida perchè siamo sempre agli stessi punti di partenza o quasi. Sarebbe interessante sentire un sociologo e uno psicologo per poi pensare l’esatto opposto delle loro spiegazioni condite di assolute certezze. Quante sciocchezze da questi interpreti della società odierna che sembrano i nuovi oracoli del nostro millennio dispensatori di verità scientifiche da quattro soldi causa dell’ impazzimento della nostra cultura!
Anch’io ho notato questa informazione insistita e ripetitiva. E’ cosa riprovevole, che crea paure sociali nelle persone e vuole insistere su una follia collettiva e una criminalità destinata ad allarmare. Certo essa non manifesta una capacità di indagine rapida perchè siamo sempre agli stessi punti di partenza o quasi. Sarebbe interessante sentire un sociologo e uno psicologo per poi pensare l’esatto opposto delle loro spiegazioni condite di assolute certezze. Quante sciocchezze da questi interpreti della società odierna che sembrano i nuovi oracoli del nostro millennio dispensatori di verità scientifiche da quattro soldi causa dell’ impazzimento della nostra cultura!










