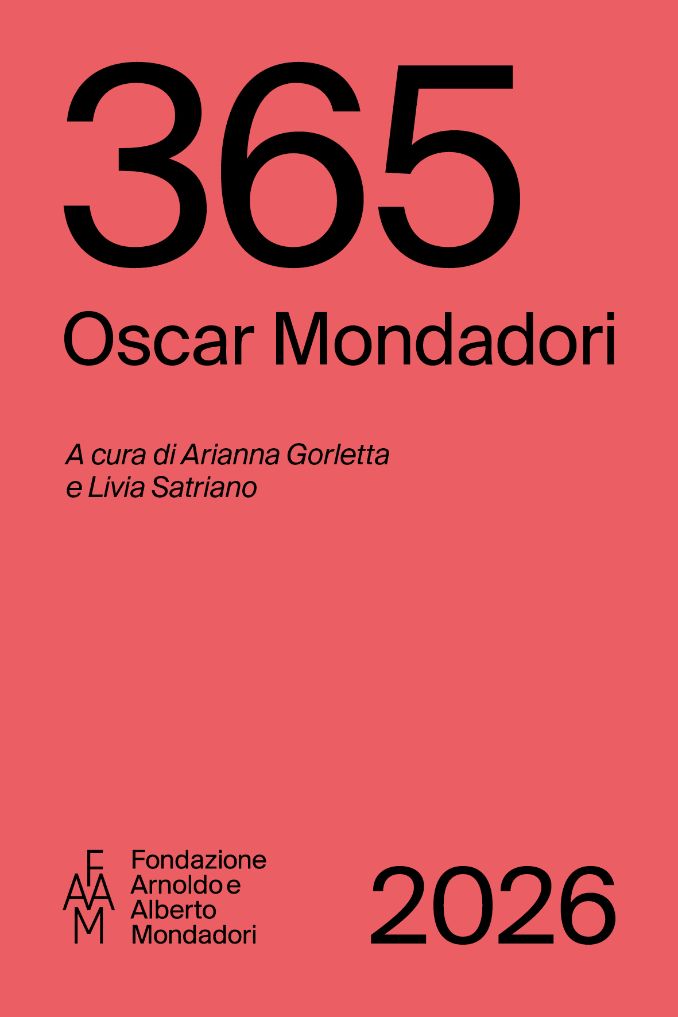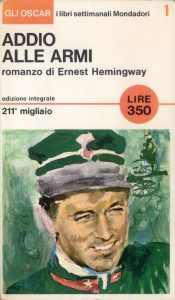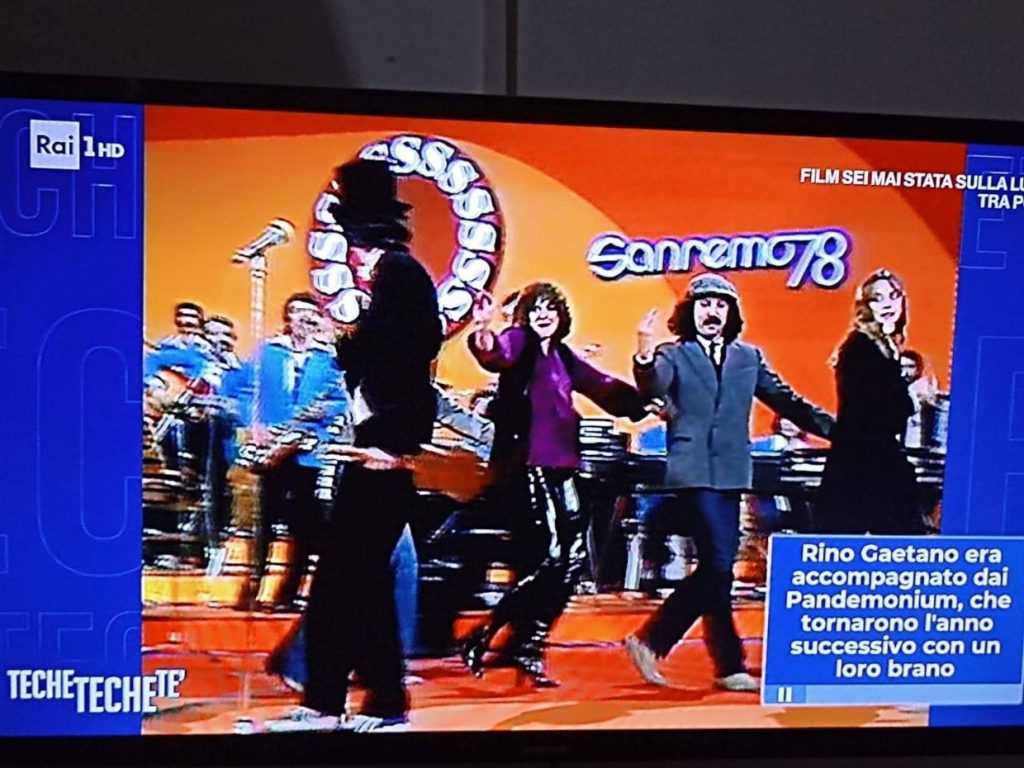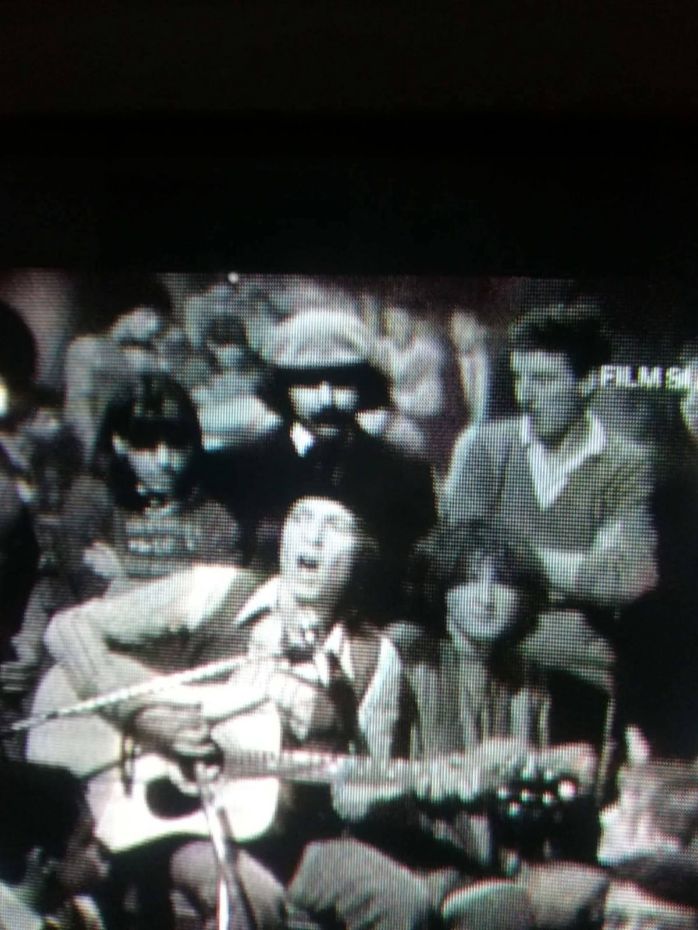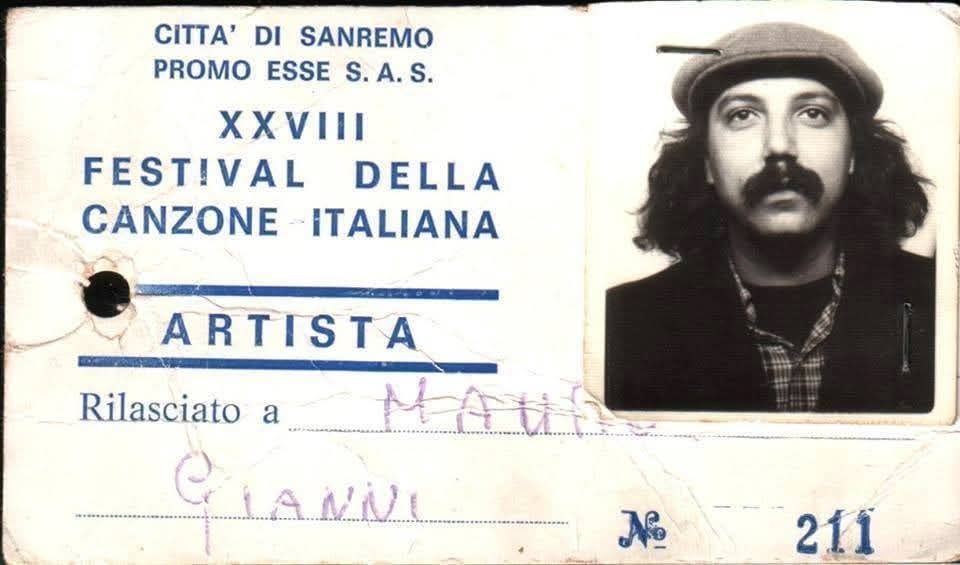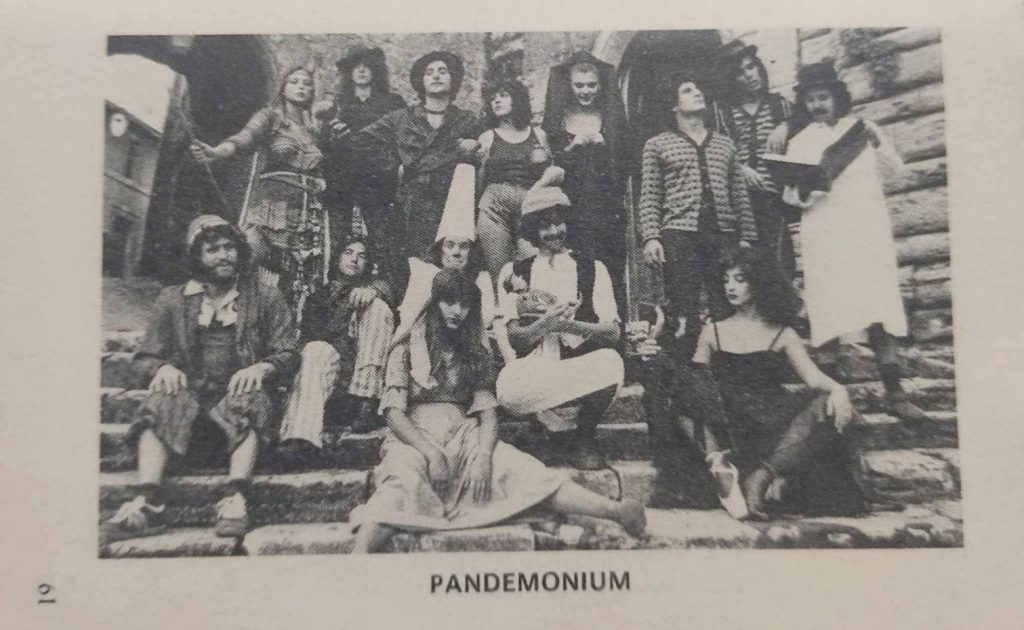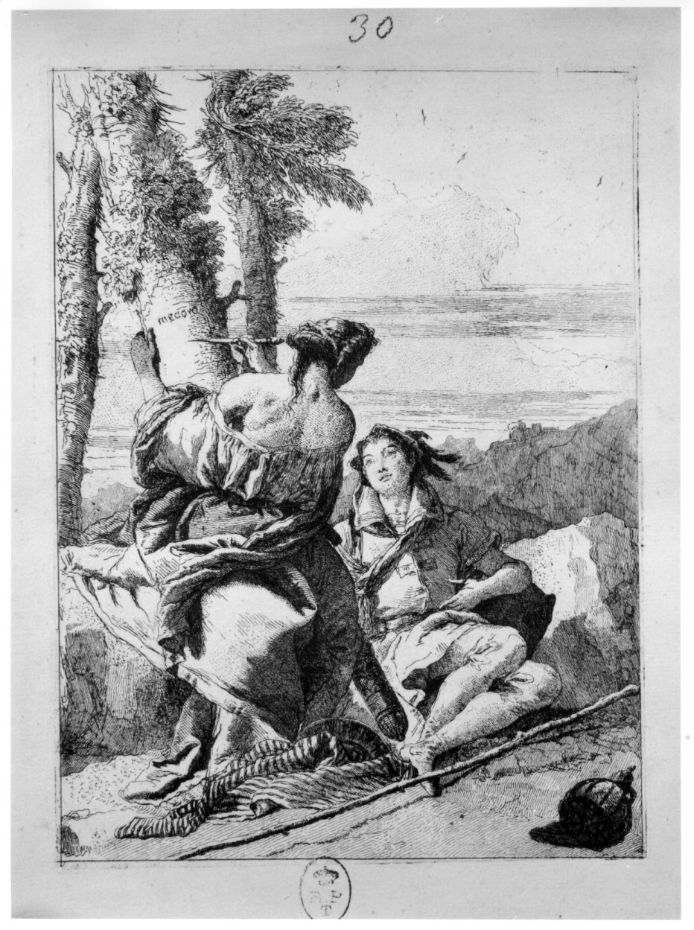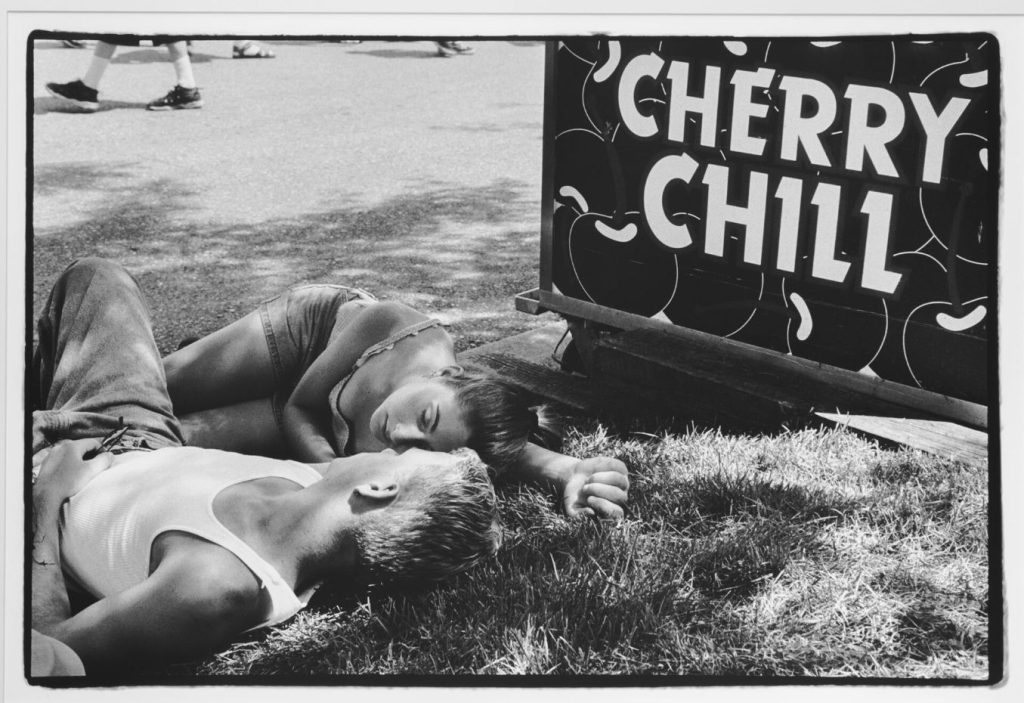domenica 22 febbraio – ore 16.30
TEATRO CARDINAL MASSAIA – Torino
Il progetto artistico che porta sul palco la magia delle storie e delle favole più amate Disney, trasformandole in uno spettacolo musicale dal vivo, frizzante e interattivo,
per un’esperienza unica e indimenticabile adatta a tutte le età. Data inclusa nella rassegna “Merenda a teatro”.