Erano anni, quelli, in cui in Italia nasceva e prosperava un’originale linea di fumetti comici. Ne facevano parte, a buon diritto, fra i tanti, tre personaggi che raggiunsero una grande popolarità: Cucciolo, Beppe e Tiramolla. Il loro creatore grafico è stato Giorgio Rebuffi
Gli anni Cinquanta, oltre ad essere il periodo in cui la Rai iniziò le trasmissioni televisive in bianco e nero, s’avviava la corsa allo spazio e l’Olivetti realizzava la mitica “Lettera 22”, sono stati anche anni formidabili per il fumetto italiano. Le tirature diventarono importanti per una rinata industria del fumetto che portava sul mercato una concorrenza “made in Italy” ai classici d’oltreoceano targati Usa.
Tex, Pecos Bill, Kinowa, Capitan Miki, il Grande Blek, il Piccolo Ranger e le loro epopee avventurose, in primo luogo, ma non solo. Erano anni, quelli, in cui in Italia nasceva e prosperava un’originale linea di fumetti comici. Ne facevano parte, a buon diritto, fra i tanti, tre personaggi che raggiunsero una grande popolarità: Cucciolo, Beppe e Tiramolla. Il loro creatore grafico è stato Giorgio Rebuffi, prolifico inventore di protagonisti e comprimari del fumetto comico italiano.
Nato a Milano nel 1928, Rebuffi ( che è morto nell’ottobre scorso, ad 86 anni) iniziò la sua attività di professionista del fumetto nel 1949, creando lo Sceriffo Fox ( un corvo nero, con tanto di pistole e stella) per le edizioni Alpe: le stesse che porteranno al successo Cucciolo e Beppe che, di lì a poco, saranno affidati proprio alle cure di Rebuffi per un decisivo “restyling”. I due, infatti, avevano fatto il loro esordio nel 1941, disegnati da Rino Anzi. Quelli che in origine erano due cagnolini antropomorfi, sotto la penna e i pennini di Rebuffi, si trasformeranno in una coppia (uno alto e smilzo, l’altro basso grassottello) che farà il verso un po’ a Topolino e Pippo (anche qui il piccoletto è scaltro e l’allampanato è un po’ svampito) e anche ad analoghe coppie comiche del cinema, come Gianni e Pinotto e Stanlio ed Ollio. Nell’agosto del 1952 compare per la prima volta al pubblico dei bambini e ragazzi italiani, a pagina 12 del numero 8 di Cucciolo mensile, un nuovo protagonista dei fumetti: si chiama Tiramolla. L’episodio in questione è il primo di una storia lunga che si concluderà con la quarta puntata nel n. 11 (novembre 1952).
Dieci anni dopo, i quattro episodi verranno unificati e ristampati con il titolo “Il mistero della villa” (Le storie di Tiramolla – anno II n. 18, 23 agosto 1962). La penna che lo tratteggia è quella dell’eclettico Rebuffi e Tiramolla (ideato da Roberto Renzi), elastico personaggio di caucciù con il cilindro in testa, aristocratico e pigro ma, suo malgrado, coinvolto in guai ed avventure andrà a formare il trio con Cucciolo e Beppe. I tre, assieme ad una serie di straordinari comprimari (il malvagio Bombarda, il menagramo Giona,il maggiordomo Saetta,il cane Ullaò, il nipotino Caucciù e, soprattutto, Pugacioff, il perennemente affamato e sovversivo “luposki della steppaff”), segneranno in modo indelebile il fumetto comico di quegli anni. Un fumetto fatto di storie semplici e un po’ ingenue, ricche di invenzioni e di gag, storie che hanno accompagnato i lunghi e spensierati pomeriggi di tanti di noi quando eravamo bambini e ragazzi.
Marco Travaglini





 A differenza degli equini e dei bovini, animali da tiro e da soma, utili ai lavori nei campi o come “mezzo di trasporto” negli spostamenti, o delle pecore e delle capre – che fornivano latte e pelli – il maiale era invece solo ( e quasi tutto) carne commestibile, che costituiva la stragrande maggioranza delle riserve di “ciccia” già dalla preistoria. Un nobile animale, preziosissimo, che offriva il meglio di se per condimenti, grassi e sapori, sugna, lardo, strutto, cotenne (basti pensare che, in origine, la bagna càoda piemontese era fatta con lardo o sugna). La sugna serviva a tanti scopi: dall’ingrassare gli scarponi ( per mantenerli morbidi e protetti ) e le ruote dei carri, fino a farne candele e ceri. Nemmeno le ossa e i “peli” si buttavano del maiale: con le migliori veniva prodotto del sapone, dalle unghie si ricavava uno straordinario concime e con le setole s’imbastivano robustissimi ancorché rozzi, tessuti. Disporre di un maiale era un ottimo investimento: non è forse evocativo il fatto che, spesso se non sempre, i salvadanai hanno la forma di un porcellino? Fino a più di un secolo fa i maiali erano cresciuti liberi di ingozzarsi di ghiande nei boschi dove prevalevano querce e farnie. Finite quelle, esaurita la scorta di cibo, per così dire, “naturale”, non avendo altro cibo per ingrassarlo ancor più, il maiale passava al macello. E, sezionato in tutto e per tutto, finiva per gran parte sulla tavola. Spesso dire maiale equivale a dire prosciutto e salume anche se non solo col porcello si fanno ottimi insaccati. Dove sono nato, nel profondo nord del Piemonte e dell’Italia di “mezzanotte”, quando si parla di salumi è naturale pensare alle valli ossolane ed alle produzioni locali. Dal prosciutto crudo della Val Vigezzo alle mocette, dai violini di cervo e di capra alla mortadella. Nella valle Anzasca, ai piedi del Rosa, da Macugnaga a Castiglione, con carne della testa e del guanciale – cotta e aromatizzata – si produceva il salame di testa. Salamini, salamelle e salsicce da grigliare si trovano un po’ ovunque, mentre è difficile trovare ancora, la salsiccia di riso: un divertente salame povero con riso bollito e maiale che si conserva sotto grasso. C’è sempre, nelle lavorazioni artigianali, il “tocco” di qualità, il vanto di tradizioni che si trasformano in prelibatezze che, spesso, non ammettono confronti.
A differenza degli equini e dei bovini, animali da tiro e da soma, utili ai lavori nei campi o come “mezzo di trasporto” negli spostamenti, o delle pecore e delle capre – che fornivano latte e pelli – il maiale era invece solo ( e quasi tutto) carne commestibile, che costituiva la stragrande maggioranza delle riserve di “ciccia” già dalla preistoria. Un nobile animale, preziosissimo, che offriva il meglio di se per condimenti, grassi e sapori, sugna, lardo, strutto, cotenne (basti pensare che, in origine, la bagna càoda piemontese era fatta con lardo o sugna). La sugna serviva a tanti scopi: dall’ingrassare gli scarponi ( per mantenerli morbidi e protetti ) e le ruote dei carri, fino a farne candele e ceri. Nemmeno le ossa e i “peli” si buttavano del maiale: con le migliori veniva prodotto del sapone, dalle unghie si ricavava uno straordinario concime e con le setole s’imbastivano robustissimi ancorché rozzi, tessuti. Disporre di un maiale era un ottimo investimento: non è forse evocativo il fatto che, spesso se non sempre, i salvadanai hanno la forma di un porcellino? Fino a più di un secolo fa i maiali erano cresciuti liberi di ingozzarsi di ghiande nei boschi dove prevalevano querce e farnie. Finite quelle, esaurita la scorta di cibo, per così dire, “naturale”, non avendo altro cibo per ingrassarlo ancor più, il maiale passava al macello. E, sezionato in tutto e per tutto, finiva per gran parte sulla tavola. Spesso dire maiale equivale a dire prosciutto e salume anche se non solo col porcello si fanno ottimi insaccati. Dove sono nato, nel profondo nord del Piemonte e dell’Italia di “mezzanotte”, quando si parla di salumi è naturale pensare alle valli ossolane ed alle produzioni locali. Dal prosciutto crudo della Val Vigezzo alle mocette, dai violini di cervo e di capra alla mortadella. Nella valle Anzasca, ai piedi del Rosa, da Macugnaga a Castiglione, con carne della testa e del guanciale – cotta e aromatizzata – si produceva il salame di testa. Salamini, salamelle e salsicce da grigliare si trovano un po’ ovunque, mentre è difficile trovare ancora, la salsiccia di riso: un divertente salame povero con riso bollito e maiale che si conserva sotto grasso. C’è sempre, nelle lavorazioni artigianali, il “tocco” di qualità, il vanto di tradizioni che si trasformano in prelibatezze che, spesso, non ammettono confronti. Costituita da un impasto a grana fine di fegato di maiale con carne di suino, grasso di sottogola e spezie, si presenta a forma di ciambella. Un particolare non secondario è l’impasto. Alcuni lo condiscono con del vin brulé, preferibilmente barbera; altri invece usano del vino bianco per dare “tono” alla mortadella che, in ogni caso, sarà poi fatta stagionare per qualche mese. A detta di alcuni ricorda la “salama” ferrarese e si può mangiare sia cotta ( con la purea di patate )che cruda o affumicata. In dialetto cusiano quest’insaccato è conosciuto come “fidighin”e trova la sua terra d’elezione sulla sponda orientale del lago d’Orta, tra il paese dell’isola di San Giulio e Gozzano, oltre che nell’areale tra l’aronese e Borgomanero. La pancetta drogata di montagna (conciata con spezie, aglio ed un “fiato” di grappa) non si trova solo dove i sentieri s’inerpicano e si devono fare i conti con le “ragioni della montanità”( asprezza dell’ambiente, altrimetria in crescita, clima conseguente, accessi ardui) ma anche in collina.Se ne producono di buonissime nel Vergante, nell’entroterra del lago Maggiore, sulle “motte” che fanno da contorno al vasto panettone del Mottarone, la “montagna dei milanesi”. Ma, tornando alla pianura del riso e variando sul tema del maiale, ci si può imbattere di nuovo nell’oca o nell’anatra e, parlando questa volta di prosciutto, è d’obbligo spendere almeno un cenno al petto affumicato d’oca. Minuscolo e signorile prosciutto senz’osso, ottenuto dal petto di uno dei più interessanti e prelibati protagonisti della vita sull’aia, si conserva a lungo e si consuma crudo. Raro da trovare, riserva delle sorprese molto piacevoli al fortunato che lo gusta, lentamente, con la stessa assenza di fretta con cui si confeziona. In subordinata si può deviare sul prosciutto d’anatra: una piccola coscia speziata, salata, lasciata all’aria o affumicata.
Costituita da un impasto a grana fine di fegato di maiale con carne di suino, grasso di sottogola e spezie, si presenta a forma di ciambella. Un particolare non secondario è l’impasto. Alcuni lo condiscono con del vin brulé, preferibilmente barbera; altri invece usano del vino bianco per dare “tono” alla mortadella che, in ogni caso, sarà poi fatta stagionare per qualche mese. A detta di alcuni ricorda la “salama” ferrarese e si può mangiare sia cotta ( con la purea di patate )che cruda o affumicata. In dialetto cusiano quest’insaccato è conosciuto come “fidighin”e trova la sua terra d’elezione sulla sponda orientale del lago d’Orta, tra il paese dell’isola di San Giulio e Gozzano, oltre che nell’areale tra l’aronese e Borgomanero. La pancetta drogata di montagna (conciata con spezie, aglio ed un “fiato” di grappa) non si trova solo dove i sentieri s’inerpicano e si devono fare i conti con le “ragioni della montanità”( asprezza dell’ambiente, altrimetria in crescita, clima conseguente, accessi ardui) ma anche in collina.Se ne producono di buonissime nel Vergante, nell’entroterra del lago Maggiore, sulle “motte” che fanno da contorno al vasto panettone del Mottarone, la “montagna dei milanesi”. Ma, tornando alla pianura del riso e variando sul tema del maiale, ci si può imbattere di nuovo nell’oca o nell’anatra e, parlando questa volta di prosciutto, è d’obbligo spendere almeno un cenno al petto affumicato d’oca. Minuscolo e signorile prosciutto senz’osso, ottenuto dal petto di uno dei più interessanti e prelibati protagonisti della vita sull’aia, si conserva a lungo e si consuma crudo. Raro da trovare, riserva delle sorprese molto piacevoli al fortunato che lo gusta, lentamente, con la stessa assenza di fretta con cui si confeziona. In subordinata si può deviare sul prosciutto d’anatra: una piccola coscia speziata, salata, lasciata all’aria o affumicata.



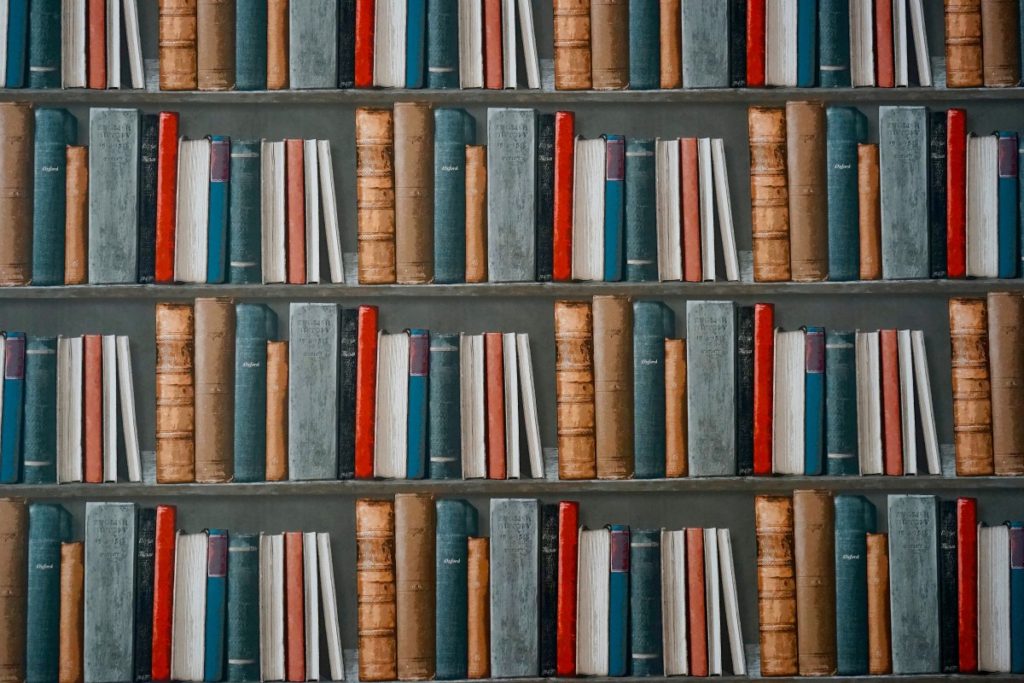




 Non si trattava solo dell’eco del movimento studentesco e della percezione, quasi palpabile, del montante malessere operaio che sarebbe poi esploso nell’autunno caldo. A scuotere le fronde del partito che Luigi Longo aveva ereditato da Togliatti era un certo venticello di dissenso che già si era manifestato con alcune battaglie per la democrazia interna al partito e una diversa idea sul “modello di sviluppo“, mosso da un gruppo di compagni più a sinistra, vicini a Pietro Ingrao, in contrapposizione alla componente più “moderata” del partito, capeggiata da Giorgio Amendola. Da poco era uscita una rivista mensile, diretta da Lucio Magri e da Rossana Rossanda: “Il Manifesto”. Il contrasto con la linea del partito diventò piuttosto forte, al punto che il PCI ne chiese la sospensione delle pubblicazioni. Ma ormai il treno de Il Manifesto era in piena corsa e non poteva più essere fermato. Così, durante una drammatica riunione del Comitato Centrale, in una fredda giornata di fine di novembre del 1969 , il gruppo dirigente comunista deliberò la radiazione per Rossana Rossanda, Luigi Pintor e Aldo Natoli con l’accusa di “frazionismo“. Nei confronti di Lucio Magri venne adottato solo un provvedimento amministrativo mentre a Massimo Caprara (che dal 1944 e per vent’anni era stato il segretario personale di Togliatti), Valentino Parlato e Luciana Castellina non venne rinnovata la tessera. Ciò che si muoveva dentro e attorno al giornale, che diventò successivamente un “quotidiano comunista”, si trasformò in breve in formazione politica autonoma alla sinistra del PCI. Anche in Val d’Ossola la battaglia politica generò scontri molto duri, dividendo e mettendo gli uni contro gli altri compagni e amici da lunga data. Per i due fratelli Bentinelli di Villadossola si trattò di un vero dramma famigliare. Da una parte Libero, il maggiore tra i due, militante severo e indisponibile a critiche e compromessi, e dall’altra Nandino, un pò più giovane, testardo come un mulo e “scaldatissimo” nel sostenere le ragioni del dissenso. Tanto tuonò che piovve e così anche il più giovane dei Bentinelli si trovò espulso da quella che era la sua seconda famiglia. I due fratelli arrivarono al punto d’ignorarsi e se proprio capitava che si trovassero uno di fronte all’altro, facevano finta di non conoscersi. Per alcuni mesi andarono avanti così, ignorandosi e tenendosi il broncio.Libero continuava a frequentare le riunioni della sezione del Pci, alla Lucciola.Nandino, a parte qualche serata con due o tre compagni di Domodossola e Varzo che condividevano le stesse idee, usciva raramente da casa. Con il tempo però la nostalgia per quelle discussioni che infiammavano le serate tra le quattro mura della sede per poi trasferirsi alla Casa del Popolo o al bar “Monte Rosa” si fece sentire. A Libero rodeva l’anima pensare ai suoi ormai ex-compagni che si riunivano anche due volte alla settimana, mentre lui era lì, solo con il suo orgoglio che non gli consentiva di recedere dalle posizioni che aveva preso anche se non era poi del tutto convinto di aver fatto la scelta giusta. Il dubbio s’insinuava e l’umore ne risentiva. Ogni giorno che passava Nandino s’adombrava sempre più, assumendo l’atteggiamento scontroso di chi aveva, come s’usava dire, “le balle girate” e questo lo rendeva quasi irriconoscibile anche agli occhi di chi gli era più vicino .Libero, interpellato da sua cognata sulla possibilità del rientro del fratello nelle file del partito, rispose che la cosa era fattibile ma che occorreva da parte di Nandino una “bella autocritica”, per dare ragione dell’errore fatto e del conseguente ravvedimento.Il fratello però non ne voleva sapere di cospargersi il capo di cenere. “Piuttosto che ammettere l’errore vado da Don Gaspare ad offrirmi come sacrestano”,diceva rosso in volto, alzando il tono della voce. E l’esempio, per un mangiacristiani come lui, doveva bastare a tacitare ogni supplica di ravvedimento. Ma ben presto la nostalgia si trasformò in invidia e quel tarlo si mise a lavorare nella sua testa finché decise che era giunto il momento di agire.Una sera di metà luglio, armato di cacciavite, s’avvicinò allo stabile della Lucciola senza farsi notare. Nel caseggiato che ospitava il magazzino delle attrezzature della Festa de L’Unità e al piano superiore la sezione del Pci, era in corso la riunione settimanale. Nello spiazzo erano posteggiate sette o otto auto, un paio di Vespe e la bicicletta di Libero. Nandino, avvelenato da un misto d’invidia e rancore per il fatto che “quelli” si riunivano mentre a lui toccava rimaner fuori, decise di bucar loro tutte le gomme. L’aria della sera era ancora calda e le finestre della sezione aperte. Renato, affacciatosi per fumare una sigaretta, udì degli strani fischi provenire dal basso. Si sporse un po’ di più e, intravvedendo un’ombra aggirarsi tra le auto, avvertì gli altri. “C’è qualcosa che non va di sotto. Ho sentito dei rumori strani e mi è parso di vedere qualcuno”, disse allarmato. Scesero rapidamente le scale e lo spettacolo che si presentò agli occhi dei militanti del Pci lasciò tutti senza parole: le auto avevano le gomme a terra, bucate dal cacciavite. E così anche le Vespe. Nandino, colto alla sprovvista, si era nascosto nella siepe ma venne scovato quasi subito. Condotto sotto il porticato, finì con il trovarsi proprio davanti al fratello e non trovando niente di meglio da dire per giustificarsi gli sussurrò con voce affranta “A te la bici però non l’ho neanche toccata”. Una bugia che mostrò subito d’avere le gambe corte poiché la vecchia Atala di Libero aveva subito la stessa sorte, con entrambe le gomme sgonfie, tristemente afflosciate. Solo l’autorevolezza del fratello maggiore impedì a Nandino di buscarsi un sacco di legnate. E la spiegazione che accompagnò il risarcimento dei danni, placò gli animi. In fondo l’invidia di Nandino, figlia dell’orgoglio e della sua testa dura, era frutto di un disperato bisogno di stare con gli altri, con i suoi compagni di sempre e non trovando il modo giusto per tornare sui suoi passi senza rimetterci la faccia,aveva pensato di “punirli” con quella bravata. La storia finì con il ritorno del “figliol prodigo” per il quale non venne sacrificato il vitello più grasso ma assegnato il compito gravoso di fare i turni di vigilanza notturna all’imminente Festa de L’Unità. Così avrebbe avuto modo di pensare a ciò che aveva fatto e, già che c’era, far buona guardia affinchè nessuno – a mani nude o con qualche cacciavite- potesse aveve la tentazione di giocare qualche brutto scherzo.
Non si trattava solo dell’eco del movimento studentesco e della percezione, quasi palpabile, del montante malessere operaio che sarebbe poi esploso nell’autunno caldo. A scuotere le fronde del partito che Luigi Longo aveva ereditato da Togliatti era un certo venticello di dissenso che già si era manifestato con alcune battaglie per la democrazia interna al partito e una diversa idea sul “modello di sviluppo“, mosso da un gruppo di compagni più a sinistra, vicini a Pietro Ingrao, in contrapposizione alla componente più “moderata” del partito, capeggiata da Giorgio Amendola. Da poco era uscita una rivista mensile, diretta da Lucio Magri e da Rossana Rossanda: “Il Manifesto”. Il contrasto con la linea del partito diventò piuttosto forte, al punto che il PCI ne chiese la sospensione delle pubblicazioni. Ma ormai il treno de Il Manifesto era in piena corsa e non poteva più essere fermato. Così, durante una drammatica riunione del Comitato Centrale, in una fredda giornata di fine di novembre del 1969 , il gruppo dirigente comunista deliberò la radiazione per Rossana Rossanda, Luigi Pintor e Aldo Natoli con l’accusa di “frazionismo“. Nei confronti di Lucio Magri venne adottato solo un provvedimento amministrativo mentre a Massimo Caprara (che dal 1944 e per vent’anni era stato il segretario personale di Togliatti), Valentino Parlato e Luciana Castellina non venne rinnovata la tessera. Ciò che si muoveva dentro e attorno al giornale, che diventò successivamente un “quotidiano comunista”, si trasformò in breve in formazione politica autonoma alla sinistra del PCI. Anche in Val d’Ossola la battaglia politica generò scontri molto duri, dividendo e mettendo gli uni contro gli altri compagni e amici da lunga data. Per i due fratelli Bentinelli di Villadossola si trattò di un vero dramma famigliare. Da una parte Libero, il maggiore tra i due, militante severo e indisponibile a critiche e compromessi, e dall’altra Nandino, un pò più giovane, testardo come un mulo e “scaldatissimo” nel sostenere le ragioni del dissenso. Tanto tuonò che piovve e così anche il più giovane dei Bentinelli si trovò espulso da quella che era la sua seconda famiglia. I due fratelli arrivarono al punto d’ignorarsi e se proprio capitava che si trovassero uno di fronte all’altro, facevano finta di non conoscersi. Per alcuni mesi andarono avanti così, ignorandosi e tenendosi il broncio.Libero continuava a frequentare le riunioni della sezione del Pci, alla Lucciola.Nandino, a parte qualche serata con due o tre compagni di Domodossola e Varzo che condividevano le stesse idee, usciva raramente da casa. Con il tempo però la nostalgia per quelle discussioni che infiammavano le serate tra le quattro mura della sede per poi trasferirsi alla Casa del Popolo o al bar “Monte Rosa” si fece sentire. A Libero rodeva l’anima pensare ai suoi ormai ex-compagni che si riunivano anche due volte alla settimana, mentre lui era lì, solo con il suo orgoglio che non gli consentiva di recedere dalle posizioni che aveva preso anche se non era poi del tutto convinto di aver fatto la scelta giusta. Il dubbio s’insinuava e l’umore ne risentiva. Ogni giorno che passava Nandino s’adombrava sempre più, assumendo l’atteggiamento scontroso di chi aveva, come s’usava dire, “le balle girate” e questo lo rendeva quasi irriconoscibile anche agli occhi di chi gli era più vicino .Libero, interpellato da sua cognata sulla possibilità del rientro del fratello nelle file del partito, rispose che la cosa era fattibile ma che occorreva da parte di Nandino una “bella autocritica”, per dare ragione dell’errore fatto e del conseguente ravvedimento.Il fratello però non ne voleva sapere di cospargersi il capo di cenere. “Piuttosto che ammettere l’errore vado da Don Gaspare ad offrirmi come sacrestano”,diceva rosso in volto, alzando il tono della voce. E l’esempio, per un mangiacristiani come lui, doveva bastare a tacitare ogni supplica di ravvedimento. Ma ben presto la nostalgia si trasformò in invidia e quel tarlo si mise a lavorare nella sua testa finché decise che era giunto il momento di agire.Una sera di metà luglio, armato di cacciavite, s’avvicinò allo stabile della Lucciola senza farsi notare. Nel caseggiato che ospitava il magazzino delle attrezzature della Festa de L’Unità e al piano superiore la sezione del Pci, era in corso la riunione settimanale. Nello spiazzo erano posteggiate sette o otto auto, un paio di Vespe e la bicicletta di Libero. Nandino, avvelenato da un misto d’invidia e rancore per il fatto che “quelli” si riunivano mentre a lui toccava rimaner fuori, decise di bucar loro tutte le gomme. L’aria della sera era ancora calda e le finestre della sezione aperte. Renato, affacciatosi per fumare una sigaretta, udì degli strani fischi provenire dal basso. Si sporse un po’ di più e, intravvedendo un’ombra aggirarsi tra le auto, avvertì gli altri. “C’è qualcosa che non va di sotto. Ho sentito dei rumori strani e mi è parso di vedere qualcuno”, disse allarmato. Scesero rapidamente le scale e lo spettacolo che si presentò agli occhi dei militanti del Pci lasciò tutti senza parole: le auto avevano le gomme a terra, bucate dal cacciavite. E così anche le Vespe. Nandino, colto alla sprovvista, si era nascosto nella siepe ma venne scovato quasi subito. Condotto sotto il porticato, finì con il trovarsi proprio davanti al fratello e non trovando niente di meglio da dire per giustificarsi gli sussurrò con voce affranta “A te la bici però non l’ho neanche toccata”. Una bugia che mostrò subito d’avere le gambe corte poiché la vecchia Atala di Libero aveva subito la stessa sorte, con entrambe le gomme sgonfie, tristemente afflosciate. Solo l’autorevolezza del fratello maggiore impedì a Nandino di buscarsi un sacco di legnate. E la spiegazione che accompagnò il risarcimento dei danni, placò gli animi. In fondo l’invidia di Nandino, figlia dell’orgoglio e della sua testa dura, era frutto di un disperato bisogno di stare con gli altri, con i suoi compagni di sempre e non trovando il modo giusto per tornare sui suoi passi senza rimetterci la faccia,aveva pensato di “punirli” con quella bravata. La storia finì con il ritorno del “figliol prodigo” per il quale non venne sacrificato il vitello più grasso ma assegnato il compito gravoso di fare i turni di vigilanza notturna all’imminente Festa de L’Unità. Così avrebbe avuto modo di pensare a ciò che aveva fatto e, già che c’era, far buona guardia affinchè nessuno – a mani nude o con qualche cacciavite- potesse aveve la tentazione di giocare qualche brutto scherzo.