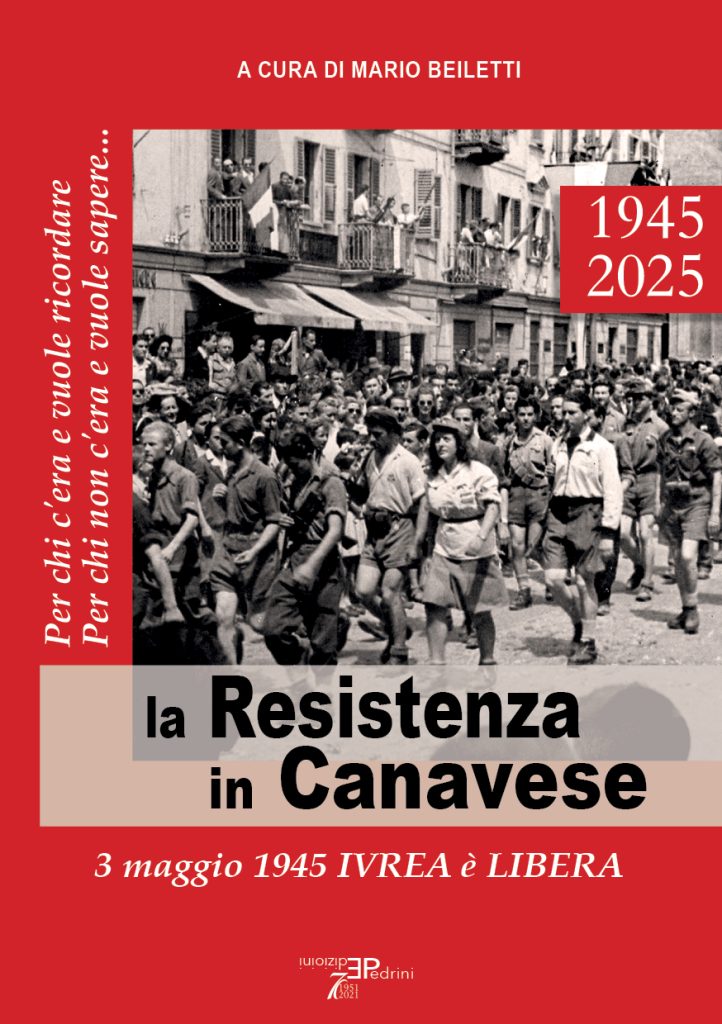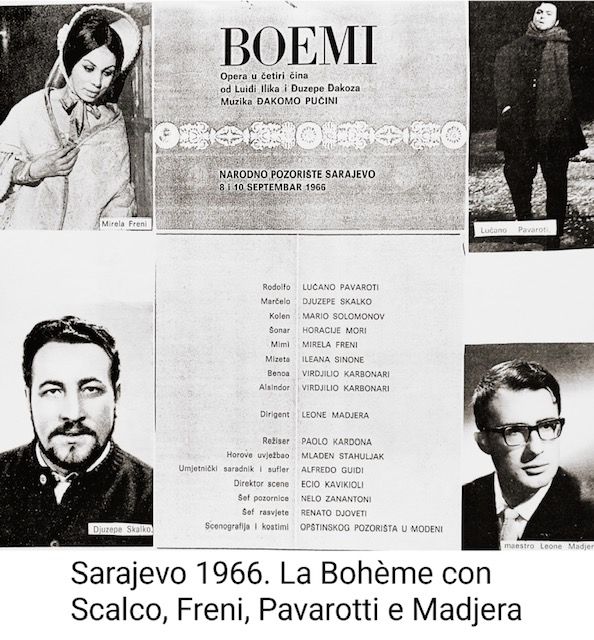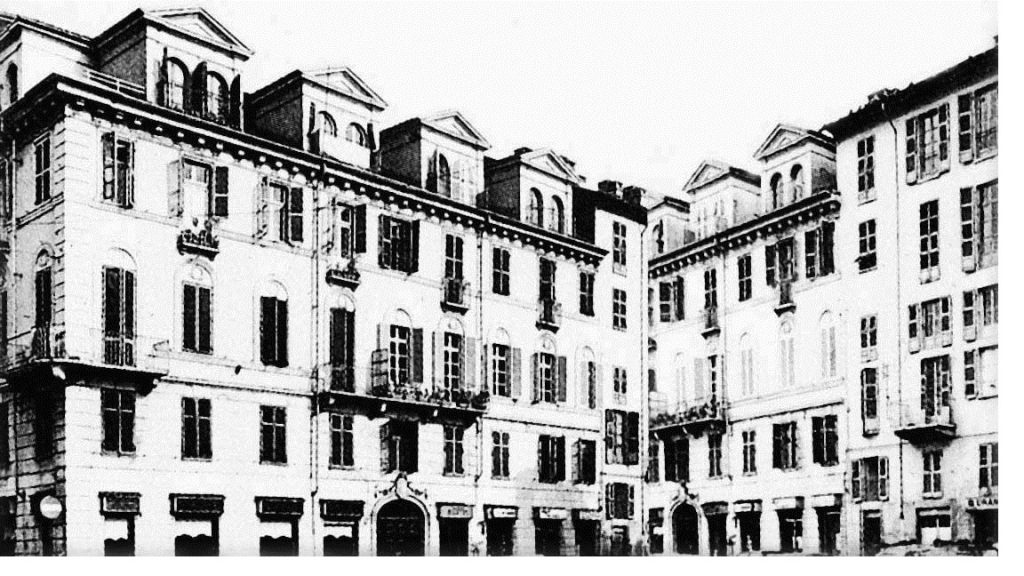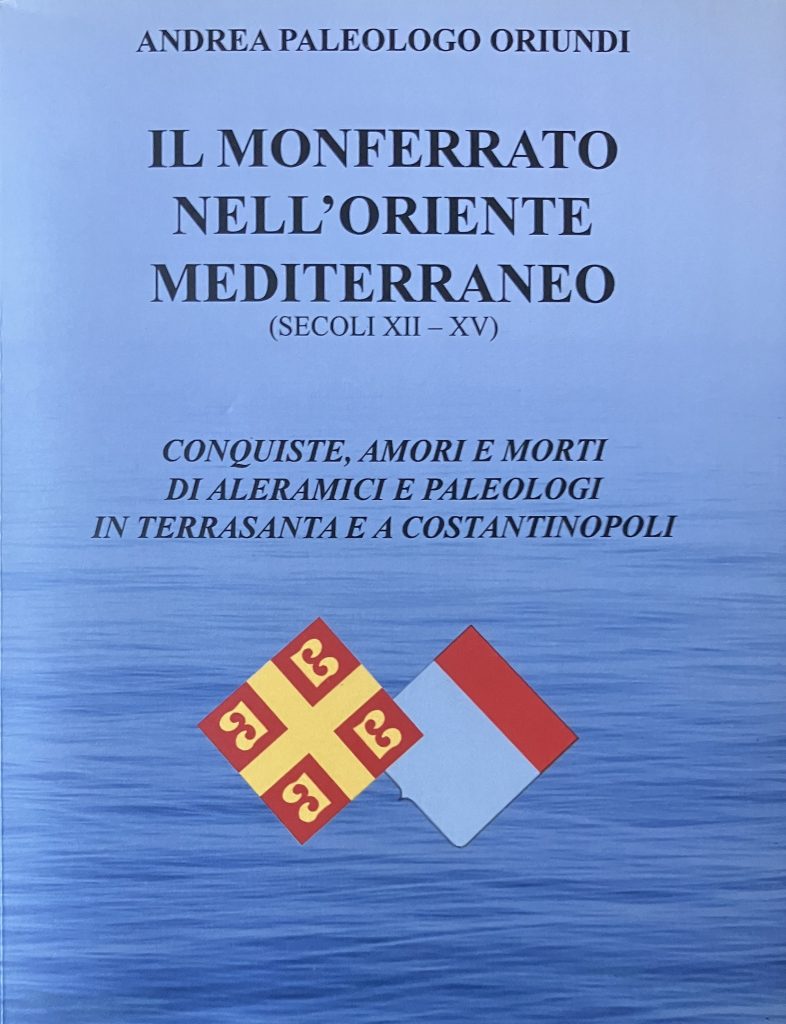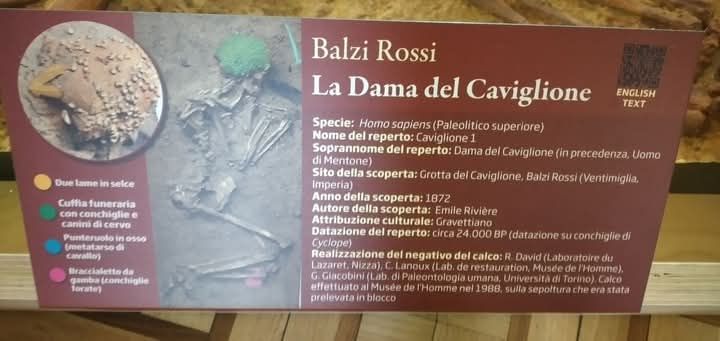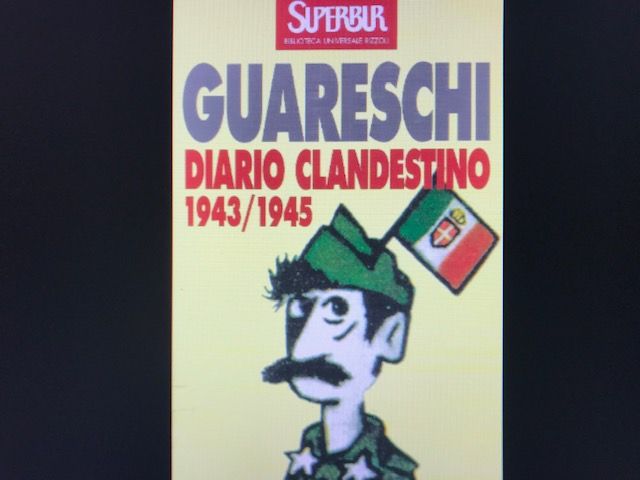In questo giorno del ricordo voglio raccontare per la prima volta un episodio. Amico per molti anni di Valerio Zanone, di cui ho sempre apprezzato la cultura, ho avuto con lui un qualche dissenso. In particolare una volta gli chiesi come mai i laici, i liberali, i democratici per decine di anni avessero ignorato il tema delle foibe e dell’esodo. Anche i democristiani si comportarono in modo analogo. Zanone non ebbe esitazione nel rispondermi che le foibe erano un tema missino e che non si doveva portare acqua alla destra fascista senza aggiungere altro. Rimasi senza parole. In tempi successivi posi la stessa domanda a Giovanni Spadolini che in modo più articolato e raffinato culturalmente disse le stesse cose di Zanone. Solo l’onesta’intellettuale dell’ antifascista nativo di Fiume Leo Valiani che in giovinezza era stato comunista portò’ il vecchio senatore a dirmi che bisognava superare l’errore di aver ignorato le foibe , “una tragedia della storia italiana”. Mi disse anche che Mario Pannunzio non aveva ignorato quella tragedia e che era un dovere dei giovani riscattare l’errore grave che “la mia generazione” aveva commesso. C’erano ancora in circolazione politici che erano stati fascisti e che avevano tentato di cancellare il passato da nascondere anche ignorando la storia. Ricordo che una volta Davide Lajolo, già gerarca fascista e combattente in Spagna dalla parte di Franco, diventato poi partigiano e deputato comunista, si alzò da tavola dove stavamo cenando perché ritenne una provocazione intollerabile il fatto che io avessi avviato un timido discorso sulle foibe alla presenza della poetessa esule da Zara Liana De Luca. Intervenne un altro commensale e l’ira di Lajolo si mitigò, anche se ribadì : “questi discorsi lasciamoli ai fascisti”. E non aggiunse altro, riprendendo il pranzo. Questo era il clima degli anni 70. I comunisti negavano perfino la possibilità di parlare delle foibe, ma anche i non comunisti non erano tanto meglio. Il trattato di Osimo che Valiani definì “indegno” e che fu una capitolazione definitiva e impacciata nei confronti di Tito fu opera di un governo di centro – sinistra del 1975 . Dietro c’era la regia del PCI, ma il
In questo giorno del ricordo voglio raccontare per la prima volta un episodio. Amico per molti anni di Valerio Zanone, di cui ho sempre apprezzato la cultura, ho avuto con lui un qualche dissenso. In particolare una volta gli chiesi come mai i laici, i liberali, i democratici per decine di anni avessero ignorato il tema delle foibe e dell’esodo. Anche i democristiani si comportarono in modo analogo. Zanone non ebbe esitazione nel rispondermi che le foibe erano un tema missino e che non si doveva portare acqua alla destra fascista senza aggiungere altro. Rimasi senza parole. In tempi successivi posi la stessa domanda a Giovanni Spadolini che in modo più articolato e raffinato culturalmente disse le stesse cose di Zanone. Solo l’onesta’intellettuale dell’ antifascista nativo di Fiume Leo Valiani che in giovinezza era stato comunista portò’ il vecchio senatore a dirmi che bisognava superare l’errore di aver ignorato le foibe , “una tragedia della storia italiana”. Mi disse anche che Mario Pannunzio non aveva ignorato quella tragedia e che era un dovere dei giovani riscattare l’errore grave che “la mia generazione” aveva commesso. C’erano ancora in circolazione politici che erano stati fascisti e che avevano tentato di cancellare il passato da nascondere anche ignorando la storia. Ricordo che una volta Davide Lajolo, già gerarca fascista e combattente in Spagna dalla parte di Franco, diventato poi partigiano e deputato comunista, si alzò da tavola dove stavamo cenando perché ritenne una provocazione intollerabile il fatto che io avessi avviato un timido discorso sulle foibe alla presenza della poetessa esule da Zara Liana De Luca. Intervenne un altro commensale e l’ira di Lajolo si mitigò, anche se ribadì : “questi discorsi lasciamoli ai fascisti”. E non aggiunse altro, riprendendo il pranzo. Questo era il clima degli anni 70. I comunisti negavano perfino la possibilità di parlare delle foibe, ma anche i non comunisti non erano tanto meglio. Il trattato di Osimo che Valiani definì “indegno” e che fu una capitolazione definitiva e impacciata nei confronti di Tito fu opera di un governo di centro – sinistra del 1975 . Dietro c’era la regia del PCI, ma il In questo giorno del ricordo voglio raccontare per la prima volta un episodio. Amico per molti anni di Valerio Zanone, di cui ho sempre apprezzato la cultura, ho avuto con lui un qualche dissenso. In particolare una volta gli chiesi come mai i laici, i liberali, i democratici per decine di anni avessero ignorato il tema delle foibe e dell’esodo. Anche i democristiani si comportarono in modo analogo. Zanone non ebbe esitazione nel rispondermi che le foibe erano un tema missino e che non si doveva portare acqua alla destra fascista senza aggiungere altro. Rimasi senza parole. In tempi successivi posi la stessa domanda a Giovanni Spadolini che in modo più articolato e raffinato culturalmente disse le stesse cose di Zanone. Solo l’onesta’intellettuale dell’ antifascista nativo di Fiume Leo Valiani che in giovinezza era stato comunista portò’ il vecchio senatore a dirmi che bisognava superare l’errore di aver ignorato le foibe , “una tragedia della storia italiana”. Mi disse anche che Mario Pannunzio non aveva ignorato quella tragedia e che era un dovere dei giovani riscattare l’errore grave che “la mia generazione” aveva commesso. C’erano ancora in circolazione politici che erano stati fascisti e che avevano tentato di cancellare il passato da nascondere anche ignorando la storia. Ricordo che una volta Davide Lajolo, già gerarca fascista e combattente in Spagna dalla parte di Franco, diventato poi partigiano e deputato comunista, si alzò da tavola dove stavamo cenando perché ritenne una provocazione intollerabile il fatto che io avessi avviato un timido discorso sulle foibe alla presenza della poetessa esule da Zara Liana De Luca. Intervenne un altro commensale e l’ira di Lajolo si mitigò, anche se ribadì : “questi discorsi lasciamoli ai fascisti”. E non aggiunse altro, riprendendo il pranzo. Questo era il clima degli anni 70. I comunisti negavano perfino la possibilità di parlare delle foibe, ma anche i non comunisti non erano tanto meglio. Il trattato di Osimo che Valiani definì “indegno” e che fu una capitolazione definitiva e impacciata nei confronti di Tito fu opera di un governo di centro – sinistra del 1975 . Dietro c’era la regia del PCI, ma il
In questo giorno del ricordo voglio raccontare per la prima volta un episodio. Amico per molti anni di Valerio Zanone, di cui ho sempre apprezzato la cultura, ho avuto con lui un qualche dissenso. In particolare una volta gli chiesi come mai i laici, i liberali, i democratici per decine di anni avessero ignorato il tema delle foibe e dell’esodo. Anche i democristiani si comportarono in modo analogo. Zanone non ebbe esitazione nel rispondermi che le foibe erano un tema missino e che non si doveva portare acqua alla destra fascista senza aggiungere altro. Rimasi senza parole. In tempi successivi posi la stessa domanda a Giovanni Spadolini che in modo più articolato e raffinato culturalmente disse le stesse cose di Zanone. Solo l’onesta’intellettuale dell’ antifascista nativo di Fiume Leo Valiani che in giovinezza era stato comunista portò’ il vecchio senatore a dirmi che bisognava superare l’errore di aver ignorato le foibe , “una tragedia della storia italiana”. Mi disse anche che Mario Pannunzio non aveva ignorato quella tragedia e che era un dovere dei giovani riscattare l’errore grave che “la mia generazione” aveva commesso. C’erano ancora in circolazione politici che erano stati fascisti e che avevano tentato di cancellare il passato da nascondere anche ignorando la storia. Ricordo che una volta Davide Lajolo, già gerarca fascista e combattente in Spagna dalla parte di Franco, diventato poi partigiano e deputato comunista, si alzò da tavola dove stavamo cenando perché ritenne una provocazione intollerabile il fatto che io avessi avviato un timido discorso sulle foibe alla presenza della poetessa esule da Zara Liana De Luca. Intervenne un altro commensale e l’ira di Lajolo si mitigò, anche se ribadì : “questi discorsi lasciamoli ai fascisti”. E non aggiunse altro, riprendendo il pranzo. Questo era il clima degli anni 70. I comunisti negavano perfino la possibilità di parlare delle foibe, ma anche i non comunisti non erano tanto meglio. Il trattato di Osimo che Valiani definì “indegno” e che fu una capitolazione definitiva e impacciata nei confronti di Tito fu opera di un governo di centro – sinistra del 1975 . Dietro c’era la regia del PCI, ma il