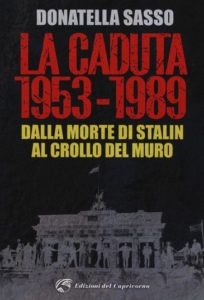Non si ferma la ricerca rigorosa di Armano Luigi Gozzano, proposta in un volume con eccellente prefazione di Carlo Alfonso Maria Burdet, attraverso una documentazione storica di grande interesse sulla genealogia della antica e nobile casata dei Gozzano in Piemonte, frutto di consultazioni di archivi parrocchiali, comunali e statali
L’emigrazione ebbe inizio nel 1500: a

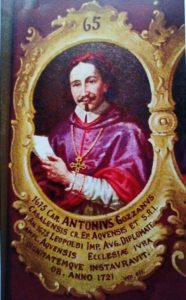






 Goffredo di Buglione (1060-1100) duca della Bassa Lorena, è l’eroe della prima Crociata che conquista Gerusalemme strappandola ai musulmani. A cavallo, con l’armatura e il vessillo, si fa ammirare dall’alto di una statua equestre al centro della piazza Reale di Bruxelles, cuore dell’Unione Europea.
Goffredo di Buglione (1060-1100) duca della Bassa Lorena, è l’eroe della prima Crociata che conquista Gerusalemme strappandola ai musulmani. A cavallo, con l’armatura e il vessillo, si fa ammirare dall’alto di una statua equestre al centro della piazza Reale di Bruxelles, cuore dell’Unione Europea. 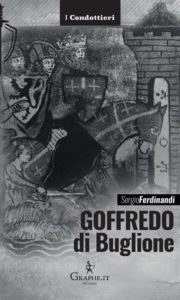 rappresentato come un modello di perfezione della cavalleria cristiana contribuendo ad alimentare il processo di mitizzazione. Mentre giullari e menestrelli diffondevano in tutta l’Europa i racconti della presa di Gerusalemme, i cavalieri più coraggiosi dell’esercito crociato venivano considerati degli eroi. Il condottiero più esaltato fu proprio Goffredo sul quale sono fiorite molte leggende e una serie di racconti popolari nei quali il guerriero cristiano appare come un santo. Sergio Ferdinandi svela che dietro la storia del condottiero c’è tanto altro, che va oltre il mito, dalle abili strategie militari che Goffredo di Buglione attuò per arrivare a Gerusalemme alle qualità di un uomo di raro spessore umano, di grande valore militare e di profonda fede. Dopo la morte la sua figura fu accostata a quella di altri santi guerrieri come San Michele e San Giorgio e al pari di questi, secondo la tradizione cristiana, uccise il male con la spada e la fede. Morì a soli 40 anni colpito da un misterioso morbo dopo aver gettato le basi territoriali di un Regno che sarebbe durato fino al 1291 con la conquista musulmana di San Giovanni d’Acri.
rappresentato come un modello di perfezione della cavalleria cristiana contribuendo ad alimentare il processo di mitizzazione. Mentre giullari e menestrelli diffondevano in tutta l’Europa i racconti della presa di Gerusalemme, i cavalieri più coraggiosi dell’esercito crociato venivano considerati degli eroi. Il condottiero più esaltato fu proprio Goffredo sul quale sono fiorite molte leggende e una serie di racconti popolari nei quali il guerriero cristiano appare come un santo. Sergio Ferdinandi svela che dietro la storia del condottiero c’è tanto altro, che va oltre il mito, dalle abili strategie militari che Goffredo di Buglione attuò per arrivare a Gerusalemme alle qualità di un uomo di raro spessore umano, di grande valore militare e di profonda fede. Dopo la morte la sua figura fu accostata a quella di altri santi guerrieri come San Michele e San Giorgio e al pari di questi, secondo la tradizione cristiana, uccise il male con la spada e la fede. Morì a soli 40 anni colpito da un misterioso morbo dopo aver gettato le basi territoriali di un Regno che sarebbe durato fino al 1291 con la conquista musulmana di San Giovanni d’Acri.