Il libro di Eric Gobetti ‘E allora le foibe ‘?, edito per i tipi degli Editori Laterza nell’aprile 2020 e giunto ormai alla sua ottava edizione, al di là delle poco più di cento pagine di testo (cui segue un’interessante bibliografia ragionata) sin dalle sue prime righe è un lavoro destinato a generare discussioni.
L’argomento è di quelli dedicati sui quali ancora oggi nella Penisola, nonostante l’istituzione della Giornata del Ricordo, si fatica a trovare una memoria condivisa, un riconoscimento di quello che accadde nei giorni della seconda guerra mondiale e, soprattutto, che ne seguirono la fine, ovvero il dramma delle foibe quello successivo degli Istriani, dei Dalmati, dei Giuliani da quelle che erano state chiamate dal nazionalismo italiano di inizio secolo le ‘Terre Irredente’.
La stessa introduzione, del resto, evidenzia subito ‘l’urgenza’ del suo essere, come sottolinea l’autore: “impedire che il Giorno del Ricordo diventi una data memoriale fascista, togliere ai propagandisti politici il monopolio delle celebrazioni’. Parole che andrebbero benissimo se fossero state applicate anche al 25 aprile in passato per evitare che la Liberazione diventasse una data memoriale di una sola parte politica (anche se è vero che il Pci con la sua struttura clandestina si fece carico di gran parte della Resistenza nel bene e nel male ed ebbe molti militanti che caddero in combattimento, vennero giustiziati o presero la via del lager, ma la Resistenza non fu un’esclusiva dei comunisti ma anche di tutte le altre forze, socialisti, giellisti, cattolici, monarchici, liberali) e chi lo avesse detto passava immediatamente per revisionista. Il caso di Giampaolo Pansa, nato e morto antifascista, è emblematico.
Nella sua pubblicazione Gobetti parla di ‘morte e di violenza, di sofferenza e di esilio’ è vero, ma l’impressione che si ha leggendo l’agevole pubblicazione e che sia tutta a senso unico, ovvero degli italiani ‘brutti e cattivi’ e degli slavi ‘buoni e vittime incomprese’ che reagiscono a tanti soprusi e reazioni perpetrate dai fascisti nel ventennio. Una visione oggettiva della storia, al di là dei sentimenti di parte, non può negare che il fascismo di frontiere fu una delle espressioni più deleterie del periodo mussoliniano, pur contestualizzata – come tutto deve sempre essere fatto – nel periodo in cui si articolò. Negare la lingua, il culto, la cultura, l’istruzione scolastica ai neo-sudditi sloveni perseguendo una politica di italianizzazione forzata fu un atto miope, come lo fu nei confronti degli altoatesini o anche nell’arco alpino occidentale. E’ sufficiente leggere i ‘Discorsi parlamentari dell’on. Engelbert Besednjak’ per avere la conferma di quanto appena espresso, anche se il deputato della minoranza slovena nell’indirizzo di risposta al discorso della Corona del 4 giugno 1924, suo primo discorso in lingua italiana, non avrà riserve nei confronti del Governo Mussolini. E Besednjak, terminata la legislatura, dovrà abbandonare l’Italia per evitare dal fascismo persecuzioni. A parte questa breve digressione poco conosciuta dalla grande storia, rileva però che Gobetti non è realmente andato alla vera radice del problema del Confine Orientale, che ha un nome preciso e si chiama ‘Nazionalismo’. E non è soltanto di marca fascista o comunista, come potrebbe fare pensare una semplificazione, ma è più generalmente italiano e slavo e risale al post prima guerra mondiale e agli errori della pace di Versailles. In un bel libro, oggi dimenticato (nella pur ampia bibliografia ragionale di Gobetti non ve n’è traccia) ‘La Jugoslavia dalla Conferenza di Pace al Trattato di Rapallo’, Il Saggiatore, 1966, Ivo Lederer, nato a Zagabria nel 1929 e allora professore incaricato all’Università di Yale, descrive ciò che accadde nei convulsi giorni che seguirono il 4 novembre 1918, con l’esercito italiano proiettato verso Lubiana e fermato dagli Alleati dell’Intesa, un Pietro Badoglio avversario dello jugoslavismo e fervente sostenitore del Trattato di Londra del 1915 che infiltra sul territorio del nascente stato dei Servi, dei Croati e degli Sloveni dei propagandisti ‘foraggiati’ dall’esercito italiano.
E dall’altro capo, come non dimenticare che la delegazione del neo Stato che riuniva gli Slavi del Sud si presentò a Versailles, con una delegazione capeggiata da Nikola Pasic che incluse nelle proprie richieste territoriali le città di Trieste, Gradisca, Monfalcone e Gorizia. Siamo nel 1918, il fascismo non è ancora nato, come pure il Partito Comunista di Jugoslavia non è ancora nato perché sarà fondato a Vukovar nel 1920. E’ un bel passo a ritroso ma indispensabile per comprendere quello che poi sarebbe accaduto negli anni e nei decenni successivi e culminato poi negli episodi di terribili barbarie e di omicidi collettivi che furono le foibe. Di tutto questo, però, non vi è un accenno neanche fugare nell’opera di Gobetti che preferisce puntare il dito su ‘Red Istria’ e fare aleggiare un’ombra di dubbio sul fatto che Norma Cossetto (ma quante furono le Norma Cossetto che non hanno avuto neppure una menzione e sono finite nelle foibe ?) abbia o meno subito violenza. Peccato che l’autore non citi tra le sue fonti padre Flaminio Rocchi con il suo ‘L’esodo dei 350mila giuliani, fiumani e dalmati’ e minimizzi sul fatto che ad essere colpiti furono non gli italiani in quanto italiani, ma in quanto fascisti. C’è da chiedersi, a questo proposito, se ha letto cosa scrive un autore che anche solo a pensarlo lontanamente contiguo al ventennio si offenderebbe, ovvero quel Giorgio Bocca, autore di una ‘Storia dell’Italia partigiana’ la cui lettura sa oggi di molto apologetica della Resistenza. Ebbene, pur sorvolando su fatti come quelli della Osoppo, sulla ‘Liberazione’ di Trieste da parte del IX Corpus, Bocca è netto e si sofferma ampiamente sulla sorte del Cln triestino e sul comportamento che i titini ebbero all’ombra di San Giusto. Fatte tutte queste doverose, sia pure brevi e parziali precisazioni, fermo restando che la guerra è SEMPRE un dramma e nella guerra sono sempre gli innocenti ed i deboli i primi a pagare, viene allora spontaneo fare una domanda: E ALLORA ERIC GOBETTI ?
Massimo Iaretti


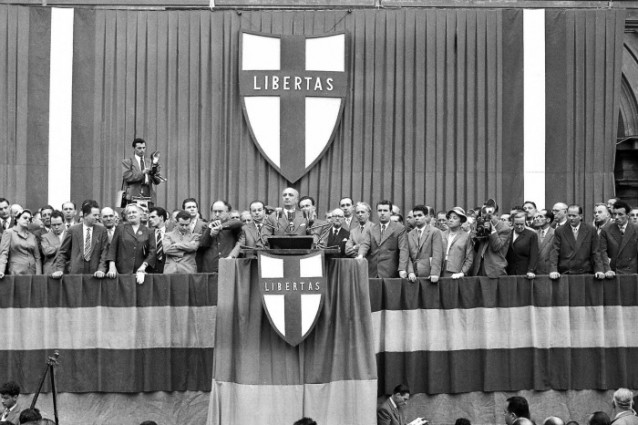

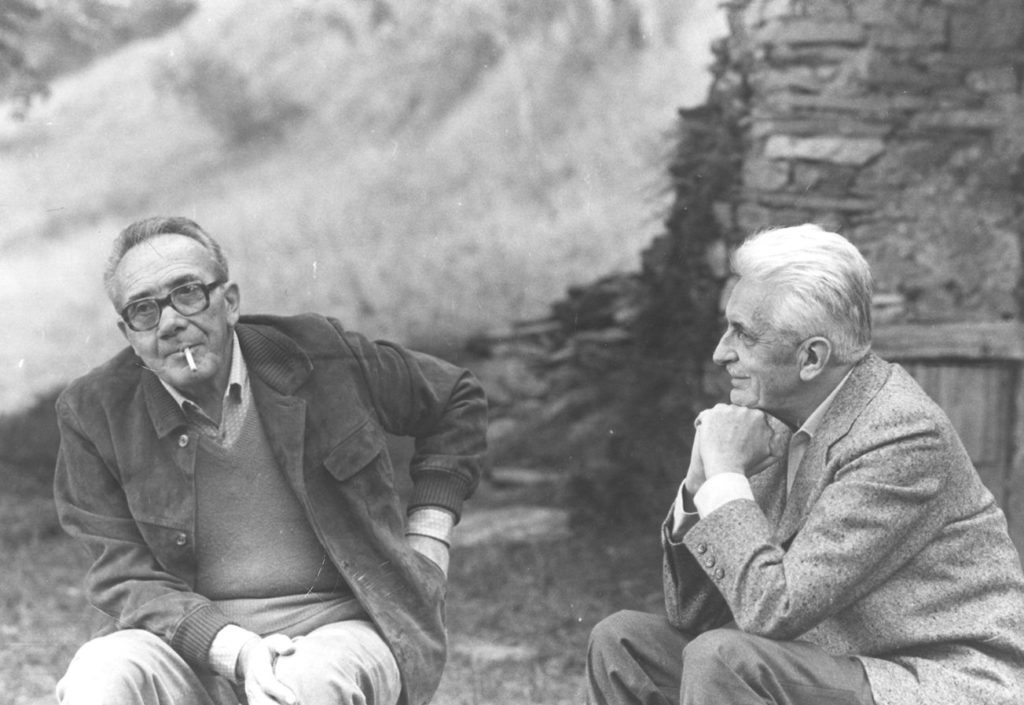
 storia, cinemaSi tratta di un progetto di restauro e riedizione digitale di alcune produzioni documentarie sui temi della Resistenza e della deportazione scelte fra le molte realizzate dall’Ancr nel corso degli anni della sua storia. “Un cofanetto digitale che oltre a contenere otto dei diversi film realizzati, offre la possibilità di esplorare molti materiali di testo, sonori e foto-cinematografici legati ai nuclei storici rappresentati nei documentari”,ricorda Corrado Borsa, del comitato direttivo Ancr. L’obbiettivo è in primo luogo quello di mettere a disposizione delle scuole, on line, opere di sicura efficacia sul piano didattico, realizzate con molti materiali d’epoca, testimonianze di protagonisti, riprese e montaggio coinvolgenti, spesso per varie ragioni difficoltosamente reperibili da tempo.
storia, cinemaSi tratta di un progetto di restauro e riedizione digitale di alcune produzioni documentarie sui temi della Resistenza e della deportazione scelte fra le molte realizzate dall’Ancr nel corso degli anni della sua storia. “Un cofanetto digitale che oltre a contenere otto dei diversi film realizzati, offre la possibilità di esplorare molti materiali di testo, sonori e foto-cinematografici legati ai nuclei storici rappresentati nei documentari”,ricorda Corrado Borsa, del comitato direttivo Ancr. L’obbiettivo è in primo luogo quello di mettere a disposizione delle scuole, on line, opere di sicura efficacia sul piano didattico, realizzate con molti materiali d’epoca, testimonianze di protagonisti, riprese e montaggio coinvolgenti, spesso per varie ragioni difficoltosamente reperibili da tempo.
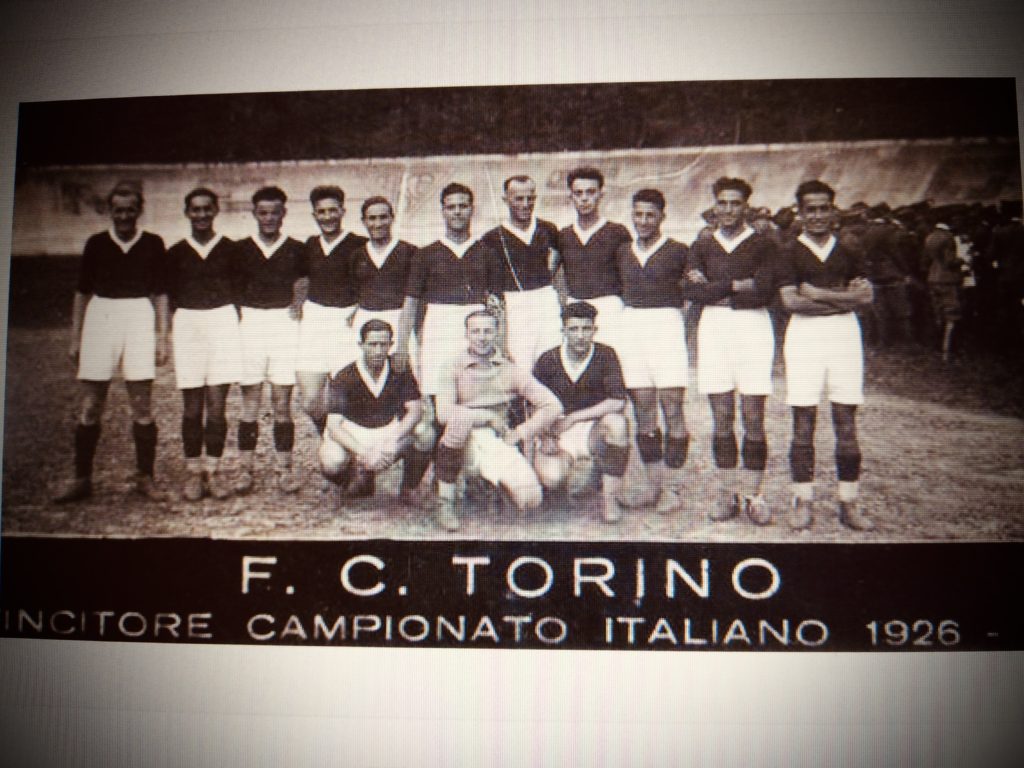

 Scriveva nel 1753 la contessa Angelica Kottulinsky, dama d’onore della principessa Vittoria di Savoia Soissons:
Scriveva nel 1753 la contessa Angelica Kottulinsky, dama d’onore della principessa Vittoria di Savoia Soissons: 



